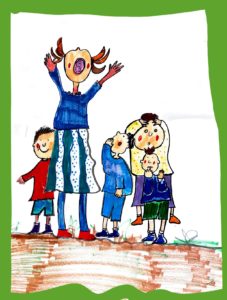di Stefanio Stefanel
Ha fatto molto scalpore in questi giorni la questione del Liceo Morgani di Roma, dove il Collegio docenti con una votazione pressoché paritaria (37 a 36), ha eliminato la sezione “senza voti” operativa da anni.
Personalmente ritengo un grave errore aver portato una simile questione in collegio docenti, visto che stava già nel PTOF che si chiude il 31 agosto 2025 e, inoltre, non andava ad intaccare la valutazione finale che deve per legge essere numerica.
Rimane il messaggio molto esplicito che questa scelta ha trasmesso, cui credo abbia molto nuociuto l’esposizione mediatica data alla sperimentazione in una sola sezione, che ha trasformato, per l’opinione pubblica, tutto il Liceo Morgani di Roma in una scuola senza voti, creando, dunque, una presa di posizione avversa dei docenti che non condividevano la scelta fatta da quella sezione.
La querelle sul Liceo Morgani fa, però, il paio con le varie prese di posizione di esponenti politici della destra, che da tempo vogliono il ritorno dei voti numerici anche nelle scuole primarie, aboliti dall’Ordinanza Ministeriale 172 del 2020, andata a regime nell’ambito di una grande azione formativa del Ministero conclusasi da poco.
Ci sono poi vari personaggi pubblici apertamente conservatori come Paola Mastrocola o apparentemente progressisti come Viola Ardone che lodano il “2” e la sua potenza salvifica e benefica.
Diciamo che le truppe dei donmilaniani sono ben agguerrite, ma in palese fase di ritirata più o meno strategica.
Reginaldo Palermo in un simpatico intervento (Ci vuole una regola chiara: si usa il voto quando governa il centro-destra e il giudizio con il centro-sinistra, 2 novembre 2023, su “Tecnica della scuola”) ha scritto che, quando governa il centro sinistra nelle scuole primarie si valuta con i giudizi, quando governa il centro destra con voti. Continua a leggere
di Stefanio Stefanel
Ha fatto molto scalpore in questi giorni la questione del Liceo Morgani di Roma, dove il Collegio docenti con una votazione pressoché paritaria (37 a 36), ha eliminato la sezione “senza voti” operativa da anni.
Personalmente ritengo un grave errore aver portato una simile questione in collegio docenti, visto che stava già nel PTOF che si chiude il 31 agosto 2025 e, inoltre, non andava ad intaccare la valutazione finale che deve per legge essere numerica.
Rimane il messaggio molto esplicito che questa scelta ha trasmesso, cui credo abbia molto nuociuto l’esposizione mediatica data alla sperimentazione in una sola sezione, che ha trasformato, per l’opinione pubblica, tutto il Liceo Morgani di Roma in una scuola senza voti, creando, dunque, una presa di posizione avversa dei docenti che non condividevano la scelta fatta da quella sezione.
La querelle sul Liceo Morgani fa, però, il paio con le varie prese di posizione di esponenti politici della destra, che da tempo vogliono il ritorno dei voti numerici anche nelle scuole primarie, aboliti dall’Ordinanza Ministeriale 172 del 2020, andata a regime nell’ambito di una grande azione formativa del Ministero conclusasi da poco.
Ci sono poi vari personaggi pubblici apertamente conservatori come Paola Mastrocola o apparentemente progressisti come Viola Ardone che lodano il “2” e la sua potenza salvifica e benefica.
Diciamo che le truppe dei donmilaniani sono ben agguerrite, ma in palese fase di ritirata più o meno strategica.
Reginaldo Palermo in un simpatico intervento (Ci vuole una regola chiara: si usa il voto quando governa il centro-destra e il giudizio con il centro-sinistra, 2 novembre 2023, su “Tecnica della scuola”) ha scritto che, quando governa il centro sinistra nelle scuole primarie si valuta con i giudizi, quando governa il centro destra con voti. Continua a leggere
![]()

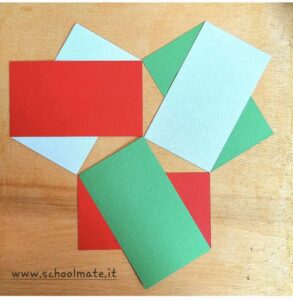 Composizione geometrica di Gabriella Romano[/caption]
di Stefano Stefanel
L’intelligenza artificiale e, soprattutto, il suo uso umanistico ha preso alla sprovvista tutti. La scuola, come sempre avviene, tende ad arretrare davanti ad ogni novità e la scandaglia con i crismi della conservazione, chiedendosi, piuttosto attonita, in che modo la sua tradizionale concezione del sapere venga scossa da ogni nuova “diavoleria” in arrivo. L’intelligenza artificiale, sotto le spoglie nemmeno troppo anonime di Chapt A.I., sta dando alle certezze della scuola una scossa quasi pari a quella data dalla pandemia, che ha trasformato in una settimana gli insegnanti in “esperti” sull’utilizzo delle piattaforme digitali, con modalità di apprendimento molto veloci anche se un po’ caserecce e artigianali.
La prima domanda che ci dobbiamo porre è quella relativa alla proprietà di un testo e quindi al confine che deve esistere tra plagio, citazione, rielaborazione. Il plagio è quando copio qualcosa da qualcuno e non dico che l’ho copiata; la citazione è quando copio qualcosa da qualcuno ed evidenzio chiaramente che cosa ho copiato e dico pubblicamente da chi l’ho copiato (di solito in nota), la rielaborazione è quando prendo spunto da qualcosa scritta o detta da qualcuno, la rielaboro e me ne approprio (e a volte “questo qualcuno” lo cito, mentre altre volte non lo cito). Personalmente sono stato convinto da quanto sosteneva San Tommaso D’Aquino, l’ho imparato all’Università quasi cinquant’anni fa, non ho mai avuto dubbi che alla base di ogni corretta pedagogia ci fosse quel pensiero.
Durante i quolibet all’Università di Parigi nel Trecento gli studenti dovevano sostenere una discussione su un tema introdotto dal San Tommaso. Lo dovevano fare appoggiandosi alle autorità del passato classico o alla contemporaneità del sapere cristiano, spesso contaminata da elementi arabi.
Composizione geometrica di Gabriella Romano[/caption]
di Stefano Stefanel
L’intelligenza artificiale e, soprattutto, il suo uso umanistico ha preso alla sprovvista tutti. La scuola, come sempre avviene, tende ad arretrare davanti ad ogni novità e la scandaglia con i crismi della conservazione, chiedendosi, piuttosto attonita, in che modo la sua tradizionale concezione del sapere venga scossa da ogni nuova “diavoleria” in arrivo. L’intelligenza artificiale, sotto le spoglie nemmeno troppo anonime di Chapt A.I., sta dando alle certezze della scuola una scossa quasi pari a quella data dalla pandemia, che ha trasformato in una settimana gli insegnanti in “esperti” sull’utilizzo delle piattaforme digitali, con modalità di apprendimento molto veloci anche se un po’ caserecce e artigianali.
La prima domanda che ci dobbiamo porre è quella relativa alla proprietà di un testo e quindi al confine che deve esistere tra plagio, citazione, rielaborazione. Il plagio è quando copio qualcosa da qualcuno e non dico che l’ho copiata; la citazione è quando copio qualcosa da qualcuno ed evidenzio chiaramente che cosa ho copiato e dico pubblicamente da chi l’ho copiato (di solito in nota), la rielaborazione è quando prendo spunto da qualcosa scritta o detta da qualcuno, la rielaboro e me ne approprio (e a volte “questo qualcuno” lo cito, mentre altre volte non lo cito). Personalmente sono stato convinto da quanto sosteneva San Tommaso D’Aquino, l’ho imparato all’Università quasi cinquant’anni fa, non ho mai avuto dubbi che alla base di ogni corretta pedagogia ci fosse quel pensiero.
Durante i quolibet all’Università di Parigi nel Trecento gli studenti dovevano sostenere una discussione su un tema introdotto dal San Tommaso. Lo dovevano fare appoggiandosi alle autorità del passato classico o alla contemporaneità del sapere cristiano, spesso contaminata da elementi arabi.
 di Stefano Stefanel
Il primo anno scolastico “regolare” dopo la pandemia finisce in un turbine di scadenze, adempimenti, progetti, che determinano, nei dirigenti scolastici e nelle scuole, una sovrapposizione tra pareri personali e azioni istituzionali.
Proviamo dare una forma sintetica ed ordinata all’obiettivo disordine che circonda le scuole:
di Stefano Stefanel
Il primo anno scolastico “regolare” dopo la pandemia finisce in un turbine di scadenze, adempimenti, progetti, che determinano, nei dirigenti scolastici e nelle scuole, una sovrapposizione tra pareri personali e azioni istituzionali.
Proviamo dare una forma sintetica ed ordinata all’obiettivo disordine che circonda le scuole: