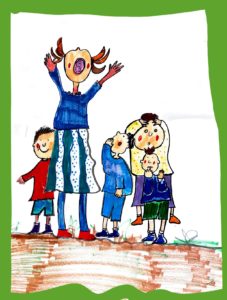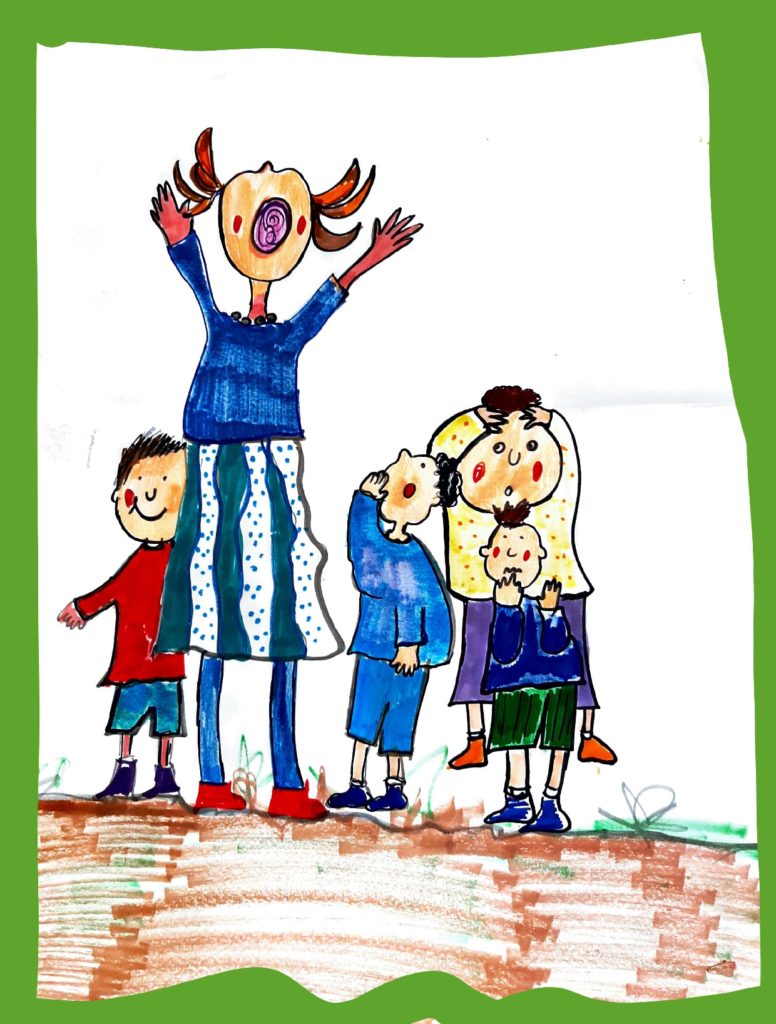di Mario Maviglia e Laura Bertocchi
di Mario Maviglia e Laura Bertocchi
Sorridere per vivere meglio (M.Maviglia)
Nel 1972 Patch Adams, un anomalo e anticonformista medico statunitense, fonda in Virgina il Gesundheit! Institute (Salute, in tedesco). La ricetta di Adams è apparentemente semplice: la salute si fonda sulla felicità ed è possibile intraprendere un percorso di cura e terapia se vi è un approccio con l’altro basato sull’umorismo, la vicinanza emotiva. All’ingresso dell’ospedale da lui fondato ha fatto mettere una frase famosa: “Per noi guarire non è solo prescrivere medicine e terapie ma lavorare insieme condividendo tutto in uno spirito di gioia e cooperazione. La salute si basa sulla felicità – dall’abbracciarsi e fare il pagliaccio al trovare la gioia nella famiglia e negli amici, la soddisfazione nel lavoro e l’estasi nella natura delle arti”.[1]
L’intuizione di Patch Adams non è la trovata di un medico bizzarro o alternativo; in realtà vi sono prove scientifiche che evidenziano il valore terapeutico del riso. È noto infatti che il riso fa aumentare la secrezione di sostanze come l’adrenalina e la noradrenalina e le endorfine che provocano diminuzione del dolore e della tensione. Ma vi sono altri effetti collegati al riso:
“Muscolatura: quando si ride parte la muscolatura … si rilassa e innesca una ginnastica addominale che migliora le funzioni del fegato e dell’intestino (ridere equivale a un buon jogging fatto rimanendo fermi). Solo col riso muoviamo alcuni muscoli del corpo e soprattutto del viso. Quando il cervello invia il messaggio “ridi”, ben quindici muscoli del viso vengono attivati dal segnale … La risata si riflette dall’espressione facciale ai muscoli del torace e dell’addome (le spalle e il torace si sollevano aritmicamente) sino agli sfinteri. Non a caso dopo una risata a crepapelle si sentono i muscoli della pancia doloranti, come pure le costole.
Respirazione: Il primo beneficio provocato da una risata lo riceve la respirazione, che grazie ad essa diventa più profonda. L’aria dei polmoni viene rinnovata attraverso fasi di espirazione e inspirazione tre volte più efficaci che in stato di riposo. Questo favorisce l’eliminazione dell’acido lattico, una sostanza tossica per il nostro organismo, con una sensazione di minor stanchezza. Le alterazioni del ritmo respiratorio intervengono sull’ossigenazione del sangue. La respirazione, inoltre, esercita e rilassa la muscolatura toracica e innesca una ginnastica addominale che migliora le funzioni del fegato e dell’intestino.
Circolazione sanguigna: La risata favorisce, attraverso la respirazione profonda, l’ossigenazione e la circolazione del sangue con aumento della pressione arteriosa. Il riso crea un calore interno generalizzato che ossigenando tutte le cellule del corpo, può accelerare la rigenerazione dei tessuti e stabilizzare molte funzioni corporee, contribuendo a difendere il fisico da infezioni. La riattivazione della circolazione provoca un generale senso di benessere (cenestesi).
Cuore: Durante una risata, il cuore aumenta le pulsazioni anche fino a 120 al minuto.
Occhi: Quando si ride gli occhi sfavillano, hanno una luce più accesa grazie a un nuovo apporto di sangue fresco alle pupille.
Naso: Si dilatano le narici, aumentando così la quantità d’aria che entra nelle fosse nasali. Chi più ride, inoltre, con l’aria fresca ripulisce anche le fosse nasali e chi ride meno incorre nelle malattie di raffreddamento.
Sistema uditivo: Gli stessi suoni emessi da una risata contribuiscono a darci una sferzata di vitalità, grazie a un’azione positiva diretta sui nervi auditivi …
Polmoni: Il primo effetto di una bella risata è di dare aria ai polmoni, con lo stesso risultato degli esercizi che si dovrebbero fare ogni mattina appena alzati. I nostri polmoni contengono infatti dal 10 al 15% di aria residua, che non esce con la respirazione ordinaria, ma che è bene togliere.”[2]
Sulla scia delle esperienze terapeutiche di Patch Adams si è sviluppato un filone di studi denominato clownterapia e di esperienze che si sono diffuse in tutto il mondo[3].
Solo un dubbio rimane dopo quanto detto sopra: perché la gente mediamente sorride e ride poco?
Infatti secondo alcuni dati pubblicati da La Stampa (risalenti al 2010)[4] con l’avanzare dell’età si tende a ridere sempre meno. Infatti, mentre un bebè arriva a ridere fino a 300 volte al giorno, già un adolescente ride “solo” sei volte al dì e dai 20 ai 30 anni si ride in media solo quattro volte al giorno. Tra i 30 e i 40, invece, le cose migliorano: le risate salgono a cinque, ma questo sembra sia legato alla presenza di bambini piccoli, che si hanno di solito intorno proprio in questa fascia d’età. Dopo si assiste ad un crollo: a 50 anni si ride tre volte al giorno, mentre per gli ultra-sessantenni la media si riduce a 2,5. Se si considera che i docenti italiani sono i più vecchi in Europa è facile desumere che nelle classi italiane si tende a ridere e sorridere molto poco.
Sorridere per apprendere meglio (L. Bertocchi)
Se ridere fa vivere meglio, in senso generale, è altrettanto vero che un approccio sorridente, caldo e cordiale aiuta il processo di apprendimento. E questo per ragioni di carattere psicopedagogico. Innanzi tutto, il processo di apprendimento si sviluppa, com’è noto, all’interno di una relazione e dunque la qualità dell’apprendimento, la sua stabilità, la sua implementazione dipendono anche da come funziona tale relazione. In sostanza, c’è un forte intreccio tra gli aspetti cognitivi e quelli emotivi. Una relazione che stigmatizza l’errore o la prestazione probabilmente non aiuta il processo di apprendimento; così pure, una relazione fredda, distaccata, poco empatica rischia di non dare quella giusta motivazione al soggetto in situazione di apprendimento.
Ce ne dà una testimonianza lo scrittore francese Daniel Pennac, che è stato anche professore. In una intervista concessa a Repubblica l’8 ottobre 2016[5], l’inventore di Malaussène afferma “L’umorismo protegge il nostro interlocutore con cui ci stiamo relazionando e in questo senso crea un legame prezioso tra le persone perché con la risata si rassicura l’altro divertendolo. Nel mio caso l’umorismo l’ho ereditato da mio padre. Durante il mio primo anno di scuola sembrava che io non avessi appreso nulla se non la prima lettera dell’alfabeto. Mia madre era terribilmente preoccupata, ma poi mio padre la fece ridere dicendole semplicemente: non ti devi preoccupare, tra ventisei anni conoscerà perfettamente tutte le altre lettere! Ecco, usare il sorriso, la risata, per rassicurare l’altro, per metterlo di nuovo in condizione di affrontare la realtà, questo è il segreto. È quello che ho fatto come professore, rifiutandomi sempre di drammatizzare i piccoli insuccessi dei miei alunni”.
Ridere di se stessi, in primo luogo, appare molto terapeutico, anche perché, nota sempre Pennac, “Tutte le tragedie dell’umanità sono state provocate da megalomani incapaci di prendersi gioco di loro stessi. Io cerco di non prendermi mai troppo sul serio, anche se è più complicato quando sono stanco”. Riguardo la sua esperienza scolastica lo scrittore confessa che provava vergogna per i suoi fallimenti e che nutriva desideri di vendetta contro i suoi professori. “Ho impiegato molto tempo a capire che la vendetta è un sentimento sterile. L’umorismo è stato per me un lungo apprendimento dell’amore”. Da docente, Pennac ha usato l’umorismo come leva motivazionale: “Credo che agli studenti si possa trasmettere l’autoironia è proprio da lì che bisogna cominciare, per combattere in modo efficace la paura che i bambini hanno della scuola. Perché questa paura distrugge ogni capacità di apprendimento”.
Su questi aspetti ha dedicato una grande attenzione Daniela Lucangeli che ha sottolineato la necessità di fondare quella che con felice espressione ha denominato una “didattica del sorriso”[6].
Afferma Lucangeli: “Le nozioni si fissano nel cervello insieme alle emozioni. Se imparo con curiosità e gioia, la lezione si incide nella memoria con curiosità e gioia. Se imparo con noia, paura, ansia, si attiva l’allerta. La reazione istintiva della mente è: scappa da qui che ti fa male. La scuola ancora crea questo cortocircuito negativo”[7].
Ma la studiosa avverte che adottare questa modalità non vuol dire fare i faciloni: “Non si vuole incoraggiare una scuola ‘molle’ ma si vuole incoraggiare una scuola capace di dare il 38% in più di organizzazione cerebrale, se sa come innescare il meccanismo dell’intelligenza creativa, costruttiva distribuita“.
Chiunque si sia trovato ad insegnare sa quanto la motivazione giochi un ruolo decisivo nel processo di apprendimento. Certo, la demotivazione scolastica ha cause molteplici e complesse, ma un atteggiamento positivo, che promuova la motivazione intrinseca, può predisporre favorevolmente all’impegno o, quantomeno, limitare le situazioni di disagio che spingono a rifiutare lo studio. Come chiarisce Boscolo[8], l’insegnante può interagire con l’atteggiamento motivazionale dei suoi alunni. Adottare rinforzi non punitivi, non frustranti, riesce a sostenere nella fatica che l’apprendimento comporta. Ed è qui che il sorriso assume un ruolo cruciale.
Innanzitutto precisiamo che il sorriso deve essere vero, sincero. Bonfiglio[9] ha individuato diverse tipologie di sorriso, tra le quali ricordiamo: il sorriso di paura, di disprezzo, triste. Queste espressioni suscitano emozioni negative, che non favoriscono il processo di insegnamento-apprendimento.
Il sorriso che scegliamo di portare in classe ogni giorno deve essere aperto, onesto, sentito.
C’è il sorriso di benvenuto, che accoglie gli studenti ogni mattina all’ingresso nella scuola; il sorriso di incoraggiamento che, unito ad un cenno del capo, invita alla partecipazione attiva, a prendere parola, ad intervenire in una discussione. I rinforzi positivi non possono che essere accompagnati da un sorriso, così come gli sguardi d’intesa. Sorridere in risposta al nostro interlocutore comunica che abbiamo capito e condividiamo ciò che ci viene detto.
Affinché la nostra espressione sia percepita come sincera e partecipata, è necessario che anche gli occhi sorridano, diversamente la sensazione è che qualcosa stoni, come se lo sguardo trasmettesse un messaggio completamente diverso rispetto al resto.
Naturalmente l’età dei nostri studenti determina la percezione di una gamma più o meno ampia di emozioni, di sfumature di significato. I bambini della scuola dell’infanzia non hanno ancora pienamente sviluppato la sensibilità che generalmente permette ad uno studente di scuola superiore di distinguere un sorriso d’intesa da uno di condivisione.
Non è però questo il punto. Qualunque sia il motivo che ci porta a sorridere in classe, questo deve essere sostenuto ed incentivato perché, come precedentemente esposto, non può esserci apprendimento se manca una disposizione d’animo fiduciosa e propositiva.
Nell’ “Etica Nicomachea”[10] Aristotele aveva notato la stranezza del fatto che per poter fare alcune cose è necessario impararle e che per impararle bisogna farle… Secoli più tardi il paradosso aristotelico non è risolto e si adatta perfettamente al mistero dell’insegnamento-apprendimento: un accompagnamento positivo e propositivo può essere imparato, ma per impararlo è necessario praticarlo. Possiamo quindi imparare a sorridere, ma solo esercitando questa capacità, che può diventare un atteggiamento costante.
Tutto ciò naturalmente non significa che sia necessario avere sempre il sorriso stampato in volto: come abbiamo visto, un sorriso sforzato viene percepito immediatamente come falso. È però necessario acquisire la consapevolezza che le nostre espressioni e i nostri atteggiamenti suscitano reazioni solitamente prevedibili nel nostro interlocutore.
Proviamo quindi a sorridere di più: in quel sorriso ci può essere tutto il senso di ciò che vogliamo trasmettere.
[1] P. Adams (2014) Salute!, Feltrinelli, Milano; P. Adams (2005), Visite a domicilio, Apogeo, Adria
[2] http://www.accademiadellarisata.it/public%5CPDF%5CRicerca%5C1.PDF
[3] A.Dionigi, P, Germani (a cura di) (2014), La clownterapia. Teoria e pratiche, Carocci, Roma; V. Olshansky (2017), Manuale di clownterapia, Audino, Roma; M. L. Mirabella, Clownterapia. Volontari clown in corsia e missionari della gioia, Neos edizioni, Torino, 2006; G. Mattia (a cura di), (2014), Con un naso rosso tutto posso! Esperienze di clownterapia, Pensa editore, S. Cesario di Lecce.
[4] https://www.lastampa.it/cultura/2010/10/09/news/dopo-i-52-anni-non-si-ride-piu-1.3699699
[5] https://www.repubblica.it/rclub/persone/2016/10/08/news/daniel_pennac_una_risata_ci_salvera_-150803693/
[6] https://www.youtube.com/watch?v=FOW821d90pM
[7] M. D’incerti (2019), Daniela Lucangeli, l’importanza di insegnare con gioia, Intervista, in “Donna moderna”, 18/02/2019; D. Lucangeli (2019), Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere, Erickson, Trento
[8] P. Boscolo (2012), La fatica e il piacere di imparare. Psicologia della motivazione scolastica, UTET Università, Torino
[9] S. Bonfiglio (2008), Introduzione alla comunicazione non verbale, ETS, Pisa, p. 90
[10] Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di M. Mazzarelli (2000), Bompiani, Milano