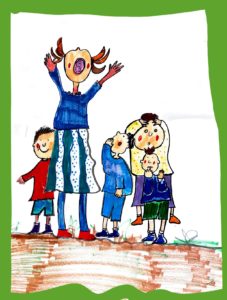La scuola che in tanti sognano, ma che non avremo
Questa campagna elettorale sta facendo sognare tutti gli operatori scolastici: tra aumenti salariali (fino ad arrivare all’equiparazione con la media degli stipendi dei docenti UE), il tempo pieno su tutto il territorio nazionale ed altre importanti promesse, c’è motivo di essere ottimisti rispetto al futuro della scuola italiana.
Non vogliamo offuscare questa immagine idilliaca della scuola che verrà; segnaliamo però che ci sono anche altri problemi che oggi sono sul tappeto e che meriterebbero di essere affrontati. Ne citiamo solo alcuni, ma l’elenco potrebbe essere molto più lungo.
Ormai è invalso l’uso di considerare l’istituzione scolastica come una comunità che interagisce con la più vasta comunità esterna. L’ultimo CCNL Scuola ha introdotto, a questo proposito, l’espressione di “comunità educante” (art. 24). Visione suggestiva e intrigante. Ma perché la scuola possa riconoscersi come “comunità” occorre che vi siano i presupposti, come dire?, materiali perché ciò avvenga. In una comunità, ad esempio, ci si aspetta che i componenti si conoscano tra loro in modo non superficiale, ci si attende che possano interagire al loro interno e condividere idee e progetti; insomma ci si aspetta che vi sia una rete relazionale e comunicativa viva e continua sia in senso orizzontale (tra colleghi) che in senso verticale (con la dirigenza e viceversa). A fronte di ciò, vi sono istituti scolastici che contano più di 2000 studenti ed oltre 200 addetti tra docenti e personale ATA.
È ragionevole pensare che queste strutture si configurino più come dei monstre organizzativi che come comunità. Difficile immaginare, ad esempio, che un dirigente scolastico, in questi contesti, conosca in modo adeguato tutti i docenti dell’istituto, per non parlare degli studenti. Purtroppo le norme attuali fissano solo i numeri minimi per far funzionare un’autonomia scolastica (non meno di 600 alunni ordinariamente e non meno di 400 nelle zone di montagna o piccole isole); non viene fissato un numero massimo. Pensare di fondare “comunità educanti” con numeri così alti è pura utopia in quanto viene a mancare l’elemento caratterizzante una comunità, ossia quello relazionale-comunicativo; al più si può fondare una comunità organizzativa con una chiara definizione dei ruoli e dei poteri dei diversi soggetti coinvolti. La soglia che la legge fissa come livello minimo dovrebbe costituire invece il livello normale di un’istituzione scolastica. I grandi istituti scolastici rispondono ad esigenze di risparmio economico e, tutto sommato, perseguono modelli aziendalistici (ricordano le grandi fabbriche), ma i processi educativi, per essere curati e sviluppati adeguatamente, dovrebbero ispirarsi a modelli umanistici, ossia favorire l’incontro tra le persone e tra queste e la cultura, in tutte le sue poliedriche forme.
La scuola, com’è noto, ha il compito di curare i processi di apprendimento e socializzazione delle giovani generazioni in modo che questi possano inserirsi attivamente nella società e realizzare, per quanto possibile, i loro desideri. Tutto ciò che ruota intorno alla scuola (competenze professionali, aspetti organizzativi, dispositivi amministrativi, risorse strumentali ecc.) dovrebbe essere subordinato o collegato a questo compito prioritario (alla mission della scuola, come spesso viene detto). Se però si analizza come la scuola è andata strutturandosi nel corso di questi ultimi due decenni si può facilmente verificare che questo principio è stato fortemente contraddetto nei fatti. Prendiamo l’aspetto burocratico. Ogni organizzazione non può fare a meno di documentare, attestare, certificare ecc. la propria attività, per vari e molteplici motivi; ma quando la produzione di atti raggiunge livelli assimilabili alla categoria della superfetazione, allora rischia di essere messa in discussione la stessa mission dell’organizzazione stessa, nel senso che ciò che doveva essere visto come un mezzo diventa un fine. È quello che è successo alla scuola e che continua a succedere: un profluvio di norme, circolari, direttive, note, decreti, istruzioni e quant’altro, che soffoca l’attività di docenti e dirigenti. Non è esagerato dire che oggi il docente italiano rischia di essere più paragonabile ad uno scribacchino che a un intellettuale. Non vi è aspetto della funzione docente (e dirigente) che non sia fortemente interessata a produzioni scritte (schede, resoconti, rapporti, verbali, verifiche, progetti, linee operative ecc.), per non parlare dell’insieme di incontri, riunioni, colloqui ecc. che fanno da corollario a tutto ciò. Questa sovrapproduzione burocratica è costantemente sostenuta dallo stesso Ministero (e dalle sue diramazioni periferiche) attraverso una molteplicità di atti (circolari, note, monitoraggi, direttive, ordinanze e altro ancora) che si riversano sulle istituzioni scolastiche il più delle volte senza che vi sia un ritorno degli esiti di quanto richiesto. Questo processo crea inevitabilmente sovrapposizione di norme, spesso in contraddizione tra loro, ponendo i soggetti terminali in situazioni disagevoli di interpretazione ed esegesi delle norme stesse. Forse bisognerebbe riorganizzare in modo sistematico le norme già esistenti (operazione già prevista, per la verità, dalla legge 107/2015, ma finora mai portata a termine) e quindi imporre un limite massimo di atti da produrre nel corso di un anno scolastico. Se le norme nazionali sono chiare e ben sistematizzate, gli interventi amministrativi del Ministero non dovrebbero superare la decina nel corso dell’anno scolastico; ci penseranno le scuole autonome ad organizzare l’attività scolastica sulla base delle norme esistenti. Questo presuppone che il “superiore Ministero” abbandoni definitivamente ogni velleità centralistica e si ponga al servizio dell’autonomia delle scuole.
C’è però da sperare che questo passo indietro del Ministero rispetto alla sovrapproduzione burocratica non venga compensato da analoga sovrapproduzione delle scuole autonome. Talvolta, infatti, sono i dirigenti scolastici a soffrire di comportamenti compulsivi sul piano della produzione di “carte”, attraverso una intensa generazione di norme regolamentari locali, oppure richiedendo ai docenti la produzione/compilazione di una molteplicità di documenti. Una scuola di dimensioni più ridotte probabilmente necessiterebbe di una minore produzione di “carte e scartoffie”. Quello che si vuole sottolineare con decisione è che l’insegnamento dovrebbe essere fortemente sburocratizzato e gli insegnanti non dovrebbero essere oggetto di inutile e snervanti molestie burocratiche; le energie magistrali vanno impiegate prima di tutto e innanzi tutto nella cura dei processi di apprendimento e non nel soddisfare le brame burocratiche dell’ingordo moloch amministrativo, invero mai completamente sazio. Le preoccupazioni dei docenti dovrebbero essere altre: come strutturare la classe in una comunità di apprendimento? Quali strategie mettere in atto nei confronti degli studenti che non apprendono? Come suscitare la motivazione? Quale mediazione didattica appare più indicata per quella specifica classe frequentata da quei particolari alunni? Quali approcci valutativi adottare in termini formativi? Come suscitare e tenere vivo l’interesse degli alunni? Come utilizzare in modo proficuo le tecnologie informatiche nella didattica? Quali approcci sono più efficaci nella gestione della classe o dei gruppi? Come garantire continuità e coerenza tra i diversi interventi dei vari docenti che si alternano in una medesima classe? Come interagire con la realtà esterna senza snaturare la specificità educativa della scuola? Su queste domande prioritariamente, e su altre del medesimo tenore, si dovrebbe indirizzare l’attenzione dei docenti in quanto facilitatori dei processi di apprendimento. Eppure l’impressione che si ricava è che questi problemi siano stati espunti dal dibattito sulla scuola, tutto centrato su ciò che avviene al di fuori dell’aula, come se la professione docente si svolgesse in un altrove contrassegnato dall’assenza della didattica e della pedagogia.
Questo problema appare strettamente intrecciato al cosa insegnare, ossia a ciò che è importante che oggi apprendano gli studenti e soprattutto alle forme di “trasmissione” del sapere. Sul primo punto sembra ormai persa la battaglia condotta per tanti anni e che mirava a snellire ed essenzializzare i curricula delle scuole di ogni ordine e grado. In realtà nel tempo i curricula si sono viepiù ampliati configurandosi di fatto come degli “spezzatini cognitivi” con scarse relazioni tra di loro. Questo processo di secondarizzazione, caratterizzato da nette paratie tra le discipline, ha nel tempo coinvolto anche i gradi iniziali dell’istruzione, talché oggi non vi è una sostanziale differenza tra l’offerta didattica del primo e del secondo ciclo, a parte, evidentemente, i livelli di approfondimento. Parlare di semplificazione del curricolo, attraverso operazioni di apparentamento tra discipline affini o periferiche, oggi appare quasi improponibile anche perché andrebbe a scardinare il meccanismo perverso delle classi di concorso iperspecialistiche. In questa frammentazione sono stati sacrificati, almeno nel primo ciclo, anche i cosiddetti saperi di base, (lingua e matematica, in primo luogo), immolati sull’altare dell’uguaglianza delle discipline, con inevitabili ripercussioni sulle possibilità di padroneggiare tutte le discipline, atteso che una inadeguata alfabetizzazione linguistica pregiudica l’acquisizione delle altre.
Ancor più complesso è il problema della mediazione didattica, ossia di come far arrivare il messaggio agli allievi, e dunque la questione delle strategie e della strumentazione (didattica) che vengono utilizzate. Anche in questo caso sembra che si faccia ancora molta fatica ad uscire dai canoni tradizionali caratterizzati da una comunicazione unidirezionale. In fondo, diciamocelo chiaro, in molte scuole la lezione la fa ancora da padrona. Decenni di insistenza sulla centralità dello studente e sulla cura della personalizzazione si infrangono davanti al totem della sempiterna lezione. Non che questa vada criminalizzata, ma bisognerebbe almeno trovare degli adeguati contrappesi per rendere effettivamente attivo il ruolo dello studente. E oggi esistono delle strategie didattiche che permettono di operare in questa prospettiva. Il lavoro di gruppo o quello cooperativo, ad esempio, appartengono a questa categoria, anche se ancora sono molto poco presenti nel nostro sistema scolastico e in alcuni istituti del tutto ignoti. La didattica laboratoriale, che coniuga l’approfondimento teorico con gli aspetti operativi di una disciplina, è un’altra strategia molto citata ma poco praticata. La responsabilizzazione dello studente con la mobilitazione delle sue capacità elaborative ed operative appare ancora molto poco diffusa nella pratica didattica. Di fatto gli studenti sono quasi sempre destinatari pressoché passivi degli interventi didattici degli insegnanti; sono poche le occasioni in cui possono mettere a frutto, attraverso progetti individuali o di coppia o di gruppo, quanto acquisito in classe. Non che manchino esperienze ispirate a questi principi educativo-didattici, ma nel complesso la didattica appare ancora ingessata, centrata prevalentemente sulla parola dell’insegnante e fortemente disallineata rispetto alle forme contemporanee di conoscenza dei giovani di oggi, immersi in un universo tecnologico dove l’utilizzo dei mezzi informatici ha sostituito le forme tradizionali dell’acquisizione dei dati e delle modalità di comunicazione.
Quanto è stato detto fin qui stenta ad entrare nel dibattito pubblico sulla scuola, ma se non si tengono conto di questi problemi le varie proposte di riforma rischiano di rimanere lettera morta in quanto non riescono ad incidere sulle concrete prassi didattiche. Se non vi è un cambio di paradigma nel modo di fare scuola ogni progetto di riforma è destinato ad arenarsi. Gli stessi interventi che mirano a contrastare le cosiddette “povertà educative” spesso dimenticano di considerare che può essere la stessa scuola ad alimentare ed aggravare queste povertà laddove perpetua forme vetuste di didattica che non riescono a motivare e coinvolgere nei processi di apprendimento la popolazione studentesca più fragile.
Tutto ciò ci porta a fare un’ultima considerazione riguardante il ruolo fondamentale svolto dai docenti nel rinnovamento della didattica e quindi della scuola. Ogni proposta di riforma della scuola non può aspirare ad alcun possibile successo se non trova una classe magistrale in grado di accettare e interpretare le sfide innovative. Lavorare sulle competenze professionali degli insegnanti appare quindi un obiettivo prioritario se non si vogliono perdere importanti opportunità di sviluppo e rinnovamento della scuola. Gli stessi sostanziosi finanziamenti messi in campo dal PNRR rischiano di lasciare inalterato il livello di qualità della scuola se non si interviene sulla formazione dei docenti. Avere insegnanti ben preparati e in grado di modulare gli interventi didattici a seconda delle realtà delle classi, vuol dire investire sulla loro formazione e sui meccanismi di selezione e individuazione di professionisti idonei. Su questo aspetto in Italia si registra una grande fatica a trovare una soluzione adeguata; di fatto ci si accontenta di tenere in piedi un esercito di professionisti malpagato, senza alcun incentivo a migliorare la propria professionalità, con pochissimi controlli sulla qualità del servizio prestato e con una preparazione iniziale alquanto indefinita. Con questi presupposti c’è poco da essere ottimisti.