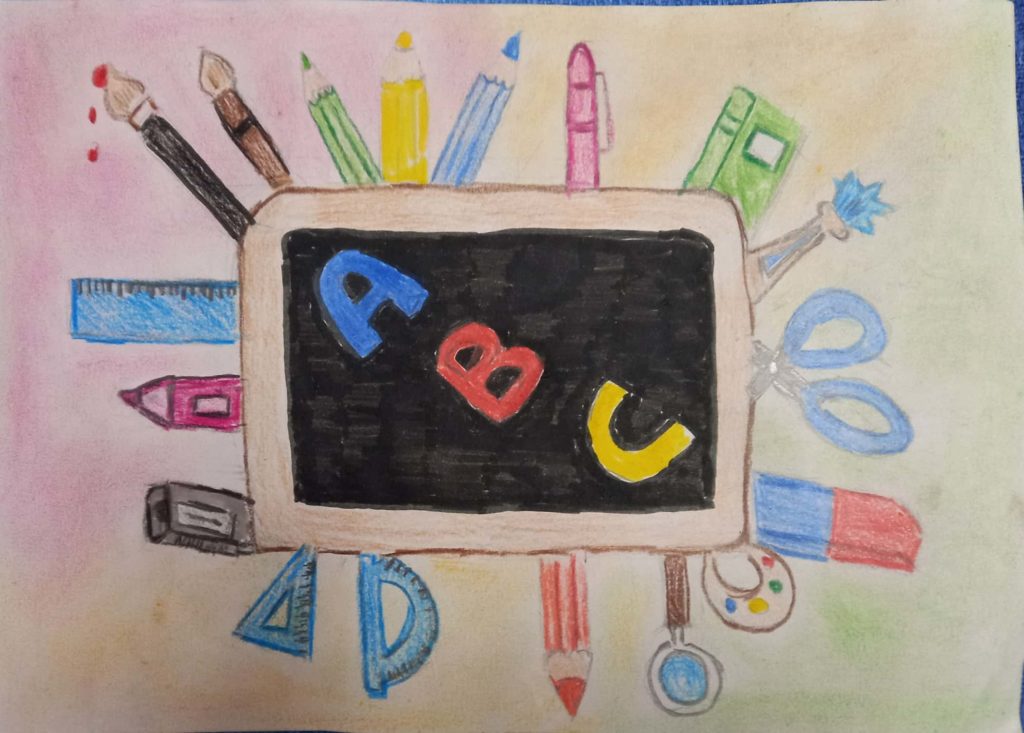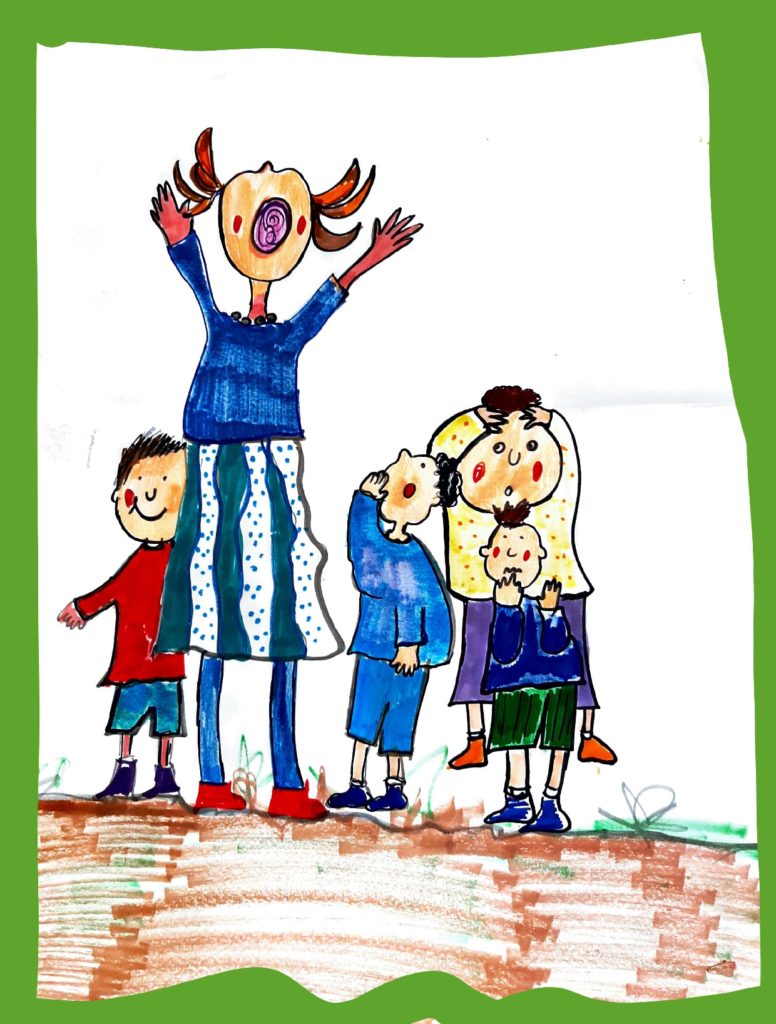di Rodolfo Marchisio
Le scuole sono sovraccariche in questo periodo, a causa della produzione di progetti – cfr. elenco di Stefanel – spesso legati al PNRR; non sembra tutti utili o realizzabili, né, a mio avviso legati ad una strategia esplicita complessiva che sia convincente, che vada aldilà della causalità:
soldi disponibili -> progetto -> soldi erogati.
Poiché almeno 3 filoni di finanziamenti hanno a che fare con la nuova iniezione di tecnologie digitali nella scuola e tutte con la formazione, se non con un modello di scuola, resta da definire qual è l’incastro temporale e funzionale delle varie iniziative in un progetto complessivo.
Per quanto riguarda il cosiddetto “digitale” riprendiamo l’analisi già introdotta e “curiosiamo”.
Almeno all’inizio parrebbe abbastanza chiaro.
“Al fine di coordinare le misure di trasformazione digitale, ciascuna istituzione scolastica adotta il documento “Strategia Scuola 4.0”, che declina il programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR con la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni della didattica, i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2, l’aggiornamento del curricolo e del piano dell’offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale, la definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale, le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale, sulla base di un format comune reso disponibile dall’Unità di missione del PNRR”. Semplice no?
Si tratta di 2,1 miliardi per Scuola 4.0[1] già stanziati in base al numero delle classi (l’elenco completo dei fondi assegnati). Più altri dedicati ai laboratori (Ist. superiori), Labs (elenco completo).
Chi ha meno di 100 mila euro o ha buon senso o fa la figura del poveraccio, mentre gli altri avranno da 125 a 500 mila euro.
Continua a leggere
di Rodolfo Marchisio
Le scuole sono sovraccariche in questo periodo, a causa della produzione di progetti – cfr. elenco di Stefanel – spesso legati al PNRR; non sembra tutti utili o realizzabili, né, a mio avviso legati ad una strategia esplicita complessiva che sia convincente, che vada aldilà della causalità:
soldi disponibili -> progetto -> soldi erogati.
Poiché almeno 3 filoni di finanziamenti hanno a che fare con la nuova iniezione di tecnologie digitali nella scuola e tutte con la formazione, se non con un modello di scuola, resta da definire qual è l’incastro temporale e funzionale delle varie iniziative in un progetto complessivo.
Per quanto riguarda il cosiddetto “digitale” riprendiamo l’analisi già introdotta e “curiosiamo”.
Almeno all’inizio parrebbe abbastanza chiaro.
“Al fine di coordinare le misure di trasformazione digitale, ciascuna istituzione scolastica adotta il documento “Strategia Scuola 4.0”, che declina il programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR con la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni della didattica, i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2, l’aggiornamento del curricolo e del piano dell’offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale, la definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale, le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale, sulla base di un format comune reso disponibile dall’Unità di missione del PNRR”. Semplice no?
Si tratta di 2,1 miliardi per Scuola 4.0[1] già stanziati in base al numero delle classi (l’elenco completo dei fondi assegnati). Più altri dedicati ai laboratori (Ist. superiori), Labs (elenco completo).
Chi ha meno di 100 mila euro o ha buon senso o fa la figura del poveraccio, mentre gli altri avranno da 125 a 500 mila euro.
Continua a leggere
![]()