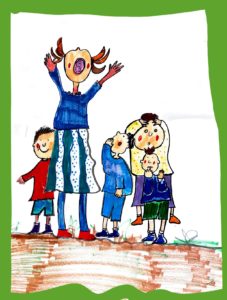Una professione diventata impossibile
In Italia si contano in centinaia di migliaia i laureati che aspirano ad un incarico di insegnamento, anche precario.
Se si pensa a quanto viene remunerato questo lavoro, bisognerebbe gridare al miracolo, se tante persone più o meno giovani vorrebbero esercitarlo.
Ne hanno le competenze?
A quanto pare per l’attuale ministro non ce l’hanno e sarebbero in buona compagnia, perché tutti gli insegnanti, anche di ruolo, dovranno sottoporsi ad un periodo obbligatorio di formazione annuale per essere all’altezza dei tempi…
Sicuramente le competenze per insegnare non ce l’hanno i giovani che studiano all’Università.
A loro è dedicata una parte importante del Capo VIII, relativo all’ istruzione, del decreto n.36 del 30 aprile del 2022, attuativo di una misura del PNRR.
Si tratta di una modifica del decreto legislativo n.59 del 2017, che a suo tempo, ma non molto tempo fa, aveva legiferato sul riordino, sull’adeguamento e sulla semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
Con il decreto del 30 aprile con un solo colpo si è voluto cambiare il sistema di reclutamento e la vita dell’insegnante.
Come debbano essere scelti i futuri insegnanti è materia esclusiva delle leggi dello Stato; come debba svilupparsi una carriera in un posto di lavoro è materia di trattativa sindacale.
Per due aspetti cruciali del funzionamento di un’istituzione importante come la scuola l’amministrazione non ha sentito il dovere di aprire un dibattito pubblico e di confrontarsi con i sindacati e con tutte le associazioni professionali, oltre che con tutte le forze politiche presenti in Parlamento.
Un mero atto di forza, in piccolissima parte attenuato per quel che riguarda la remunerazione degli insegnanti dopo i primi accesi bollori ministeriali. Parlare degli insegnanti che ci sono, di quelli che ci saranno e di come tutti dovrebbero essere è di fatto parlare della scuola che dovrà esserci.
Quale scuola? Non mi pare che se ne sia fatto qualche cenno.
In tutta evidenza si regola la dimensione di un’istituzione non partendo dalle finalità che devono essere perseguite, ma dalle condizioni del personale che sarà chiamato a lavorarvi .
Che la scuola con queste misure e solo con queste misure possa porre rimedio ai tanti suoi problemi, francamente mi sembra molto difficile.
I problemi del sistema scolastico non si riassumono nello stato giuridico del personale della scuola e nemmeno nel sistema di reclutamento, ma da molto tempo nell’incertezza della sua missione e del suo rapporto con la società.
In questa breve nota ci si sofferma solo su alcuni aspetti del sistema di reclutamento degli insegnanti.
Col decreto n.36 del 30 aprile 2022 si propone un modello strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale, coreutica e le scuole per un percorso di formazione iniziale, selezione e prova che abiliti all’insegnamento.
Percorso che si conclude con prova finale scritta e una lezione simulata.
Con l’abilitazione, così conseguita, si potrà partecipare ai concorsi pubblici, indetti su base regionale .
Il predetto percorso di formazione ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
Il percorso configurato per l’abilitazione presenta non pochi ostacoli da affrontare e superare.
Per abilitarsi sono necessari una laurea magistrale e 60 cfu, equivalenti in genere ad un anno accademico, che si possono acquisire anche durante il normale percorso accademico …
L’accesso a questi percorsi, però, non sarebbe poi tanto facile, perché in qualche modo viene previsto un numero programmato di corsi e di corsisti.
Infatti, il Ministero dell’Istruzione, come si legge nel decreto, comunica a quello dell’Università il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo, affinché il sistema di formazione generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali, senza che in generale o su specifiche classi di concorso si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale non sia in grado di assorbirla.
Una soluzione questa che coarta con un principio e con alcuni fatti.
Il principio è quello del diritto allo studio.
Se voglio fare l’insegnante e mi si costringe ad un corso parallelo o successivo a quello accademico, l’accesso non mi può essere impedito in virtù di un numero programmato, incerto nella sua dimensione e di cui si dice che debba essere solo utile alle procedure di selezione.
Ma forse non è vero che più sono i candidati e meglio si può scegliere?
Cosa impedisce di pensare che quanti sono esclusi dai percorsi di abilitazione potrebbero essere migliori di quelli che vi sono ammessi?
Non solo.
Se il titolo di abilitazione non consente di accampare alcun diritto per la sistemazione in ruolo, perché bisogna limitare il numero dei futuri abilitati all’insegnamento?
E non si corre il rischio di dovere ricorrere per gli incarichi temporanei a docenti privi, ancora una volta, di formazione adeguata per insegnare?
L’abilitazione, peraltro, ha durata illimitata e non è detto che chi la consegue voglia subito entrare a scuola per insegnare.
Nel mondo circolano tanti abilitati in professioni che non hanno mai esercitato o che hanno smesso di esercitare…Il problema vero di questo percorso di formazione è quello dei 60 crediti, di cui 20 da dedicare ad attività di tirocinio.
Passare dagli attuali 24 cfu a 60 è proprio un salto mortale e francamente non riesco a capire a quanti possa interessare un’abilitazione che comporti questo prezzo.
Nel sistema scolastico non ci sono solo le medie e i licei, ci sono i tecnici e i professionali in cui dovrebbero insegnare gli ingegneri delle più diverse specializzazioni, i chimici, i geologi, gli agronomi, gli informatici, gli economisti, i giuristi e i tecnici di ogni ramo della produzione e dei servizi per molti dei quali è stato difficile conseguire il titolo di studio nei tempi stabiliti e a molti dei quali non converrebbe aggiungere almeno un anno extra di formazione, perché tanto ci vuole per avere 60 crediti.
Non per entrare in ruolo, ma per potere fare il concorso per entrare in ruolo e percepire uno stipendio, che arriverà a 2000 euro dopo 30 anni e passa di lavoro a scuola.
Ho l’impressione che saranno molto pochi quelli che si sottoporranno a questo itinerario e che tra questi saranno molti quelli che attingeranno al mercato parallelo a quello universitario per aver i 60 crediti, come è successo con i 24.
E’ tempo di miracoli e di prodigi.
Se ora è possibile conseguire due lauree contemporaneamente, perché dovrebbe essere complicato in corso d’opera agguantare in qualche modo 60 cfu?
Tutto è possibile; è possibile anche che, nonostante le ottime intenzioni con cui è stato pensato, questo nuovo sistema di reclutamento fallisca per mancanza di vocazioni o per l’esiguità di quelli che potranno essere ordinati sacerdoti …
Il decreto pensa anche agli insegnanti che vogliono una seconda abilitazione e a quelli che sono precari da non pochi anni, per dare loro l’opportunità sia di potersi abilitare, sia di potere partecipare ai concorsi.
Non si può nascondere la preoccupazione che un sistema così complicato per l’accesso ai ruoli non riuscirà a cancellare il precariato a scuola; anzi è probabile che in molte discipline possa aumentare e anche di molto.
Per i laureati di alcune discipline con questo percorso formativo il mondo delle professioni diventerà ancora più attrattivo rispetto a quello della scuola.
E allora cosa fare? Credo che semplificare il percorso che conduce all’insegnamento sia utile e necessario e che il problema della sua qualità non dipenda molto dal numero dei crediti formativi.
Per imparare a nuotare bisogna buttarsi in acqua e non andare a lezione di nuoto.
Il punto debole del reclutamento a mio modesto avviso è costituito dall’anno di prova.
Su questo tema bisognerebbe lavorare per consentire ai vincitori di concorso di cominciare ad insegnare e nello stesso tempo di assistere alle lezioni altrui e di procedere ad attività di formazione su questioni relative alla pratica in atto ,seriamente predisposte dall’ambito territoriale di riferimento.
Un anno di assistenza alla cattedra degli insegnanti con maggiore esperienze, piuttosto che un anno di insegnamento in proprio, con un tutor che lavora per i fatti propri in altre classi.