 di Raimondo Giunta
di Raimondo Giunta
La molteplicità delle agenzie formative come anche il ritmo inesauribile di innovazione e di sviluppo delle conoscenze che bisogna possedere per non restare ai margini dell’attuale società ridisegnano i compiti che la scuola deve affrontare.
La complessità del problema è costituita dal fatto che le altre agenzie (media soprattutto) hanno qualcosa che la scuola non sempre possiede: la capacità di seduzione e di coinvolgimento.
A prima vista sembra quasi impossibile vincere la sfida per coltivare nei giovani il desiderio e il piacere di apprendere. Si dice con monotonia sempre più assillante che per inserirsi in una società, segnata dalle continue trasformazioni dei suoi assetti economico-sociali e dalle innovazioni permanenti del patrimonio tecnologico e scientifico, e per essere capaci di dominare l’incertezza che per questi motivi si viene a determinare occorra un considerevole bagaglio di saperi e di competenze e soprattutto che si debba essere capaci di imparare ad apprendere.
Se ne è fatto un principio, uno scopo e anche uno slogan.
![]()


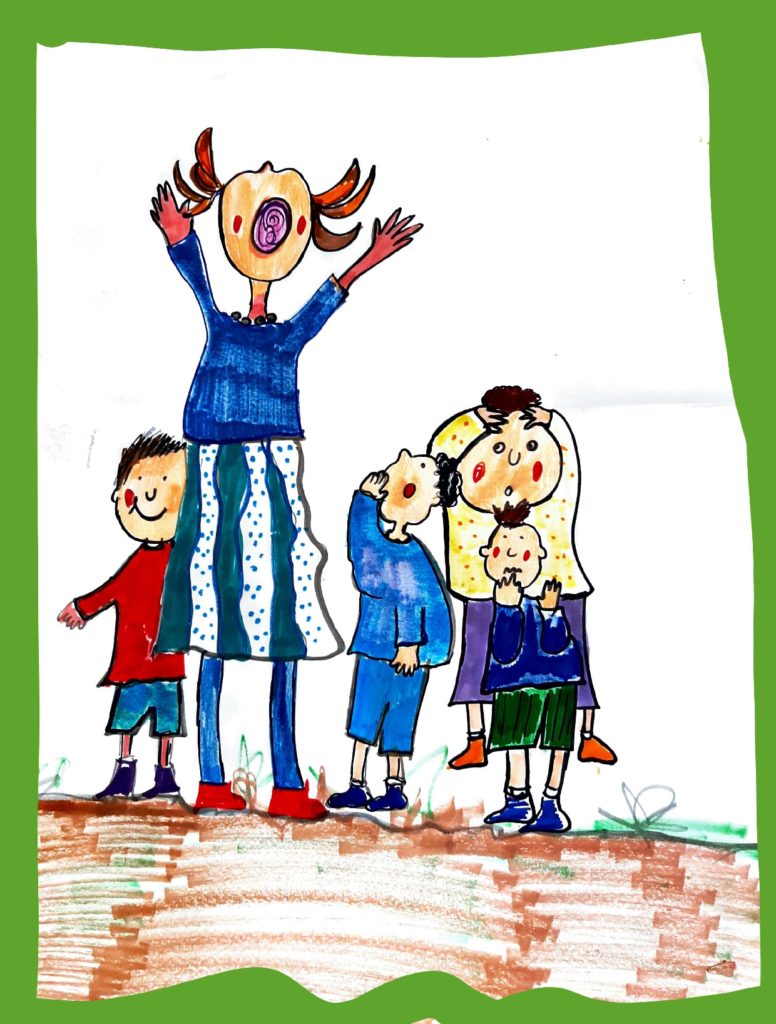

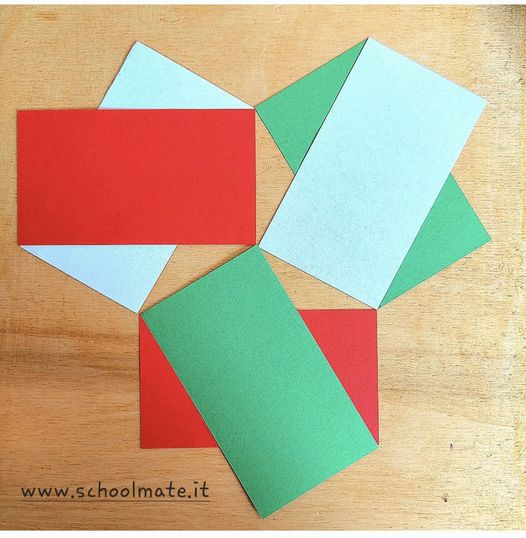



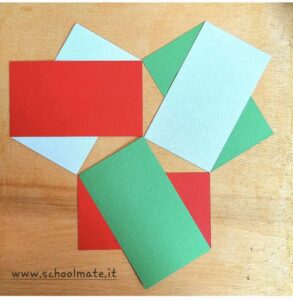 Composizione geometrica di Gabriella Romano[/caption]
di Raimondo Giunta
Ci sono saperi che valgono in sè e sono quelli che danno un orientamento per dare un senso alla propria vita e ci sono saperi che valgono per orientarsi nel mondo del lavoro; l’approccio per competenze come spesso definito, proposto e incentivato questa distinzione tiene a non farla, tant’è che dappertutto si è visto ridurre il peso delle discipline umanistiche e delle stesse discipline teoretiche della scienza.
Che esistano saperi inerti è una favola da Confindustria; che l’inerzia sia congenita a determinate discipline è un’altra fatta propria dagli apostoli delle competenze.
Ogni sapere è vivido e fruttuoso se viene problematizzato; se si fa comprendere che si è costituito come risposta ai problemi che l’uomo ha dovuto affrontare nella sua storia.
E per la storia è opportuno ricordare che nei tecnici e nei professionali si è sempre considerato il rapporto col mondo del lavoro come proprio principio costitutivo.
Contrariamente a quel che viene detto la scuola che non si lascia trascinare nel dogmatismo dell’approccio per competenze è un scuola che dà strumenti di libertà; la scuola che predica la spendibiltà dei saperi predispone all’accettazione servile, all’adeguamento puro e semplice ai dati del mercato del lavoro.
Un matematico che aveva insegnato negli Stati Uniti e in Italia disse che dal punto di vista della produttività intellettuale è meglio insegnare geometria parlando di segmenti piuttosto che di bastoncini; non c’è nulla di più produttivo di un insegnamento teorico serio, rigoroso e profondo.
Un personaggio come M.Crahay, a cui si deve la realizzazione in Belgio di uno dei primi se non del primo curriculum per competenze in Europa dice della competenza che non ha fondamento e che è simile alla caverna di Alì Babà; non posso tralasciare, infine, B.Rey che delle competenze cosiddette trasversali ha mostrato tutta la loro debolezza, se non proprio l’insostenibilità.
P.S. Le competenze senza conoscenze sono vuote; si è competenti perchè si sa e si sa ciò che viene appreso in materie umanistiche, scientifiche e professionali.]]>
Composizione geometrica di Gabriella Romano[/caption]
di Raimondo Giunta
Ci sono saperi che valgono in sè e sono quelli che danno un orientamento per dare un senso alla propria vita e ci sono saperi che valgono per orientarsi nel mondo del lavoro; l’approccio per competenze come spesso definito, proposto e incentivato questa distinzione tiene a non farla, tant’è che dappertutto si è visto ridurre il peso delle discipline umanistiche e delle stesse discipline teoretiche della scienza.
Che esistano saperi inerti è una favola da Confindustria; che l’inerzia sia congenita a determinate discipline è un’altra fatta propria dagli apostoli delle competenze.
Ogni sapere è vivido e fruttuoso se viene problematizzato; se si fa comprendere che si è costituito come risposta ai problemi che l’uomo ha dovuto affrontare nella sua storia.
E per la storia è opportuno ricordare che nei tecnici e nei professionali si è sempre considerato il rapporto col mondo del lavoro come proprio principio costitutivo.
Contrariamente a quel che viene detto la scuola che non si lascia trascinare nel dogmatismo dell’approccio per competenze è un scuola che dà strumenti di libertà; la scuola che predica la spendibiltà dei saperi predispone all’accettazione servile, all’adeguamento puro e semplice ai dati del mercato del lavoro.
Un matematico che aveva insegnato negli Stati Uniti e in Italia disse che dal punto di vista della produttività intellettuale è meglio insegnare geometria parlando di segmenti piuttosto che di bastoncini; non c’è nulla di più produttivo di un insegnamento teorico serio, rigoroso e profondo.
Un personaggio come M.Crahay, a cui si deve la realizzazione in Belgio di uno dei primi se non del primo curriculum per competenze in Europa dice della competenza che non ha fondamento e che è simile alla caverna di Alì Babà; non posso tralasciare, infine, B.Rey che delle competenze cosiddette trasversali ha mostrato tutta la loro debolezza, se non proprio l’insostenibilità.
P.S. Le competenze senza conoscenze sono vuote; si è competenti perchè si sa e si sa ciò che viene appreso in materie umanistiche, scientifiche e professionali.]]>