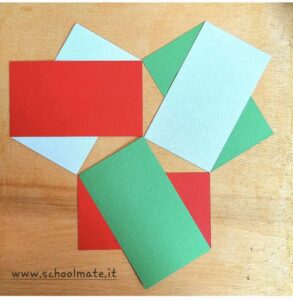Psicopatologia del voto
C’era il professore di fisica che l’aveva interrogato sulla puleggia, ma lo studente aveva fatto scena muta e quindi era stato rimandato al posto con due. Eppure conosceva tutto sulle carrucole, ma non sapeva che puleggia e carrucola fossero la stessa cosa.
Da questo aneddoto molti anni fa, erano gli anni novanta del secolo scorso, prendeva l’avvio uno dei primi libri, pubblicati nel nostro paese, sulla valutazione scolastica del docimologo Gaetano Domenici. Docimologia è la scienza degli esami, termine introdotto dallo psicologo francese Henry Piéron, quando iniziò le sue prime ricerche sugli esami di licenza elementare nel lontano 1922.
Si poneva così la questione della valutazione scolastica e della sua affidabilità sulla base della quale docenti e responsabili del governo della scuola avrebbero dovuto strutturare le loro decisioni.
È che la valutazione come consapevolezza dei processi d’apprendimento e dei loro risultati ha sempre faticato a trovare cittadinanza nello spirito delle nostre scuole e del nostro insegnamento, timorosi d’essere contaminati dal germe dell’aziendalismo, tanto che ancora troppi sono i docenti, e non solo, che guardano con sospetto, quando non con ostilità, ai dati forniti di anno in anno dai test Ocse Pisa e da quelli dell’ Invalsi.
In compenso resistono i voti, con i loro ingredienti di soggettività ed emotività, di giudizi morali, di effetti pigmalione che nulla c’entrano con la misurazione degli apprendimenti e dei processi scolastici. I voti per cui, se sei anche un campione in fisica, ti abbasso il voto perché la tua condotta scolastica lascia a desiderare.
Ora il voto è imputato di produrre ansia e stress ed ogni discorso sulla validità e finalità delle valutazioni scolastiche passa in secondo piano.
Dalla scuola del merito all’ansia da prestazione degli studenti, al burnout degli insegnanti. La nostra scuola sempre più si avvia ad essere una maionese impazzita. Da un lato un ministro che ripristina lo spirito di competizione, dall’altro studenti e docenti che non reggono, che denunciano tutta la loro fragilità.
Studenti stressati dall’essere valutati, insegnanti, sempre più immiseriti nel loro ruolo, che, perdendo lo strumento del voto, temono di vedere ancora più svilita la loro funzione, dall’altra parte i genitori restii a rinunciare al voto che resta comunque l’indicatore prioritario per esercitare il controllo sull’andamento scolastico dei figli.
Psicopatologie, dunque, stati d’animo, stress dei protagonisti come se il teatro e il testo della commedia da mettere in scena ogni giorno poco contassero.
Dopo la pandemia da Covid il voto è divenuto l’imputato numero uno delle psicopatologie di tanti studenti, tale da indurre taluni istituti a relegarli esclusivamente al termine dell’anno scolastico.
Una sorta di tregua sul campo di battaglia che resta la scuola, una cura psicoterapica per consentire all’adolescenza di riprendersi dai traumi scolastici.
Curioso, perché nel frattempo l’antico ministero della pubblica istruzione ha perso l’aggettivo “pubblica” per recuperare il sostantivo “merito”.
Questo vezzo tutto italiano di affrontare i problemi del sistema scolastico a spizzichi e bocconi, tipo il liceo quadriennale sperimentale, ora la sospensione di voti e quadrimestri, lasciando inalterato tutto il resto come se ogni parte non fosse funzionale al tutto, come se si fosse potuto fare a meno di voti e quadrimestri o trimestri anche prima. E allora perché non si è provveduto per tempo? Perché alcuni sì ed altri no? Perché nascondere i voti per un intero anno scolastico per poi farli ricomparire al termine di esso? Farli ricomparire all’esame di stato?
Altroché psicopatologia del voto, qui siamo di fronte alla schizofrenia scolastica.
Preoccupa la cultura nelle cui mani è oggi posta la nostra scuola, dal ministro ai dirigenti, agli insegnanti.
Ma siete proprio onestamente convinti che siano i voti la vera causa del disagio di tanti studenti? Ci credete davvero? Le alte percentuali di abbandono e di dispersione scolastica non riescono a suggerirvi altro? È davvero preoccupante, perché significa che la nostra scuola non è nelle mani giuste.
Dovrebbe essere chiaro da anni che il problema dei voti è solo un aspetto, un sintomo di una crisi più vasta del nostro sistema formativo, con il suo seguito di modello docente prevalente, di cattedre, di interrogazioni, pagelle ed esami ed altro ancora. Tutto coerente con la filosofia persistente dell’ organizzazione gentiliana del nostro sistema scolastico, che ci si ostina a voler mantenere, quando da alcuni addirittura non si pretenderebbe di ripristinarne l’antico splendore, a dispetto dell’usura dei tempo.
Una struttura scolastica che ancora fa degli esami, anche questi di emanazione gentiliana, non solo il momento finale del processo, ma un fattore di condizionamento di tutto il processo, una motivazione che si sovrappone ad ogni altra motivazione, una gara che esalta il clima competitivo della vita scolastica e l’individualismo conseguente.
Un modello di insegnante che, essendo l’emanazione di questa struttura scolastica, finisce col subordinare alla funzione giudicatrice ogni altra funzione, collocando in essa la sostanziale motivazione dell’insegnamento, quando non la sua gratificazione.
Allora il disagio degli studenti è il sintomo di una contaminazione, di una infezione prodotta da una scuola disagiata e a sua volta disagiante, è l’espressione più eclatante della crisi della sua funzione, quella che dovrebbe essere oggi, rispetto ai bisogni formativi qui e ora, e non quella di ieri, di epoche che non ci sono più.