 di Giovanni Fioravanti
C’era il professore di fisica che l’aveva interrogato sulla puleggia, ma lo studente aveva fatto scena muta e quindi era stato rimandato al posto con due. Eppure conosceva tutto sulle carrucole, ma non sapeva che puleggia e carrucola fossero la stessa cosa.
Da questo aneddoto molti anni fa, erano gli anni novanta del secolo scorso, prendeva l’avvio uno dei primi libri, pubblicati nel nostro paese, sulla valutazione scolastica del docimologo Gaetano Domenici. Docimologia è la scienza degli esami, termine introdotto dallo psicologo francese Henry Piéron, quando iniziò le sue prime ricerche sugli esami di licenza elementare nel lontano 1922.
Si poneva così la questione della valutazione scolastica e della sua affidabilità sulla base della quale docenti e responsabili del governo della scuola avrebbero dovuto strutturare le loro decisioni.
È che la valutazione come consapevolezza dei processi d’apprendimento e dei loro risultati ha sempre faticato a trovare cittadinanza nello spirito delle nostre scuole e del nostro insegnamento, timorosi d’essere contaminati dal germe dell’aziendalismo, tanto che ancora troppi sono i docenti, e non solo, che guardano con sospetto, quando non con ostilità, ai dati forniti di anno in anno dai test Ocse Pisa e da quelli dell’ Invalsi.
In compenso resistono i voti, con i loro ingredienti di soggettività ed emotività, di giudizi morali, di effetti pigmalione che nulla c’entrano con la misurazione degli apprendimenti e dei processi scolastici. I voti per cui, se sei anche un campione in fisica, ti abbasso il voto perché la tua condotta scolastica lascia a desiderare.
Ora il voto è imputato di produrre ansia e stress ed ogni discorso sulla validità e finalità delle valutazioni scolastiche passa in secondo piano. Continua a leggere
di Giovanni Fioravanti
C’era il professore di fisica che l’aveva interrogato sulla puleggia, ma lo studente aveva fatto scena muta e quindi era stato rimandato al posto con due. Eppure conosceva tutto sulle carrucole, ma non sapeva che puleggia e carrucola fossero la stessa cosa.
Da questo aneddoto molti anni fa, erano gli anni novanta del secolo scorso, prendeva l’avvio uno dei primi libri, pubblicati nel nostro paese, sulla valutazione scolastica del docimologo Gaetano Domenici. Docimologia è la scienza degli esami, termine introdotto dallo psicologo francese Henry Piéron, quando iniziò le sue prime ricerche sugli esami di licenza elementare nel lontano 1922.
Si poneva così la questione della valutazione scolastica e della sua affidabilità sulla base della quale docenti e responsabili del governo della scuola avrebbero dovuto strutturare le loro decisioni.
È che la valutazione come consapevolezza dei processi d’apprendimento e dei loro risultati ha sempre faticato a trovare cittadinanza nello spirito delle nostre scuole e del nostro insegnamento, timorosi d’essere contaminati dal germe dell’aziendalismo, tanto che ancora troppi sono i docenti, e non solo, che guardano con sospetto, quando non con ostilità, ai dati forniti di anno in anno dai test Ocse Pisa e da quelli dell’ Invalsi.
In compenso resistono i voti, con i loro ingredienti di soggettività ed emotività, di giudizi morali, di effetti pigmalione che nulla c’entrano con la misurazione degli apprendimenti e dei processi scolastici. I voti per cui, se sei anche un campione in fisica, ti abbasso il voto perché la tua condotta scolastica lascia a desiderare.
Ora il voto è imputato di produrre ansia e stress ed ogni discorso sulla validità e finalità delle valutazioni scolastiche passa in secondo piano. Continua a leggere
![]()


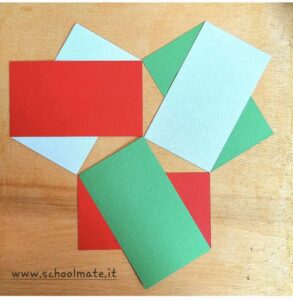



 disegno di Matilde Gallo, anni 10[/caption]
di Giovanni Fioravanti
Ho incontrato Vygotskij agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, la collana “Paideia” degli Editori Riuniti ne pubblicava due opere: Lo sviluppo psichico del bambino, con l’introduzione di Leontjev e cenni bio-bibliografici a cura, già allora, di Luciano Mecacci, Immagina-zione e creatività nell’età infantile, con la prefazione di Alberto Alberti, in fine il libro di Lurija Linguaggio e comportamento.
Poi nel 1976 Vygotskij approda alle edizioni Giunti con la pubblicazione di Pensiero e Linguaggio” nella collana di psicologia scientifica diretta, tra gli altri, da Guido Petter.
L’iniziativa è di Angela Massucco Costa, ordinario di psicologia sperimentale all’università di Torino, che ne cura anche l’edizione, con l’introduzione di Bruner.
Gli anni ’70-’80 segnano l’esplosione d’interesse in Italia per il pedologo russo. La pedologia, censurata dal regime sovietico, comprende biologia, pediatria, psicologia, pedagogia, qualcosa come le scienze dell’educazione. Per Vygotskij è la riorganizzazione delle funzioni psichiche sotto l’influenza dei fattori sociali e culturali. All’indomani del crollo del muro di Berlino, dopo la caduta del regime sovietico, viene meno la censura nei confronti delle opere di Vygotskij, si scoprono i suoi taccuini, opere inedite, la figlia Gita ne pubblica la biografia. Un po’ in tutto il mondo si riaccende l’interesse per lo psicologo russo.
Così non accade in Italia, nonostante sia italiano il maggior studioso di Vygotskij, Luciano Mecacci, che ha lavorato con Lurija nell’Istituto di Psicologia di Mosca dove lo stesso Vy-gotskij condusse le sue ricerche. Sarebbe interessante indagare le ragioni di questa diserzione tutta italiana, certamente crisi della cultura e crisi dell’insegnamento vanno di pari passo. Da tempo manca nel nostro paese una riflessione seria sulla cultura necessaria alla scuola, in una scuola che si è andata sempre più avvitando su se stessa in questioni di cattedre e di precariato.
Può essere che abbia inciso, come ha osservato Alain Goussot, la profonda crisi della cultura marxista italiana, anche nella sua versione gramsciana.
Ma non ne sono convinto, perché l’opera di Vygotskij va ben oltre ogni confine riduttivamente culturale. È più credibile il perdurare di una opzione cognitivista ancora prevalente nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento.
Se sei interessato all’argomento ti suggeriamo questa nostra intervista con Raffaele Iosa che racconta il suo incontro con la figlia di Vygotskij
disegno di Matilde Gallo, anni 10[/caption]
di Giovanni Fioravanti
Ho incontrato Vygotskij agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, la collana “Paideia” degli Editori Riuniti ne pubblicava due opere: Lo sviluppo psichico del bambino, con l’introduzione di Leontjev e cenni bio-bibliografici a cura, già allora, di Luciano Mecacci, Immagina-zione e creatività nell’età infantile, con la prefazione di Alberto Alberti, in fine il libro di Lurija Linguaggio e comportamento.
Poi nel 1976 Vygotskij approda alle edizioni Giunti con la pubblicazione di Pensiero e Linguaggio” nella collana di psicologia scientifica diretta, tra gli altri, da Guido Petter.
L’iniziativa è di Angela Massucco Costa, ordinario di psicologia sperimentale all’università di Torino, che ne cura anche l’edizione, con l’introduzione di Bruner.
Gli anni ’70-’80 segnano l’esplosione d’interesse in Italia per il pedologo russo. La pedologia, censurata dal regime sovietico, comprende biologia, pediatria, psicologia, pedagogia, qualcosa come le scienze dell’educazione. Per Vygotskij è la riorganizzazione delle funzioni psichiche sotto l’influenza dei fattori sociali e culturali. All’indomani del crollo del muro di Berlino, dopo la caduta del regime sovietico, viene meno la censura nei confronti delle opere di Vygotskij, si scoprono i suoi taccuini, opere inedite, la figlia Gita ne pubblica la biografia. Un po’ in tutto il mondo si riaccende l’interesse per lo psicologo russo.
Così non accade in Italia, nonostante sia italiano il maggior studioso di Vygotskij, Luciano Mecacci, che ha lavorato con Lurija nell’Istituto di Psicologia di Mosca dove lo stesso Vy-gotskij condusse le sue ricerche. Sarebbe interessante indagare le ragioni di questa diserzione tutta italiana, certamente crisi della cultura e crisi dell’insegnamento vanno di pari passo. Da tempo manca nel nostro paese una riflessione seria sulla cultura necessaria alla scuola, in una scuola che si è andata sempre più avvitando su se stessa in questioni di cattedre e di precariato.
Può essere che abbia inciso, come ha osservato Alain Goussot, la profonda crisi della cultura marxista italiana, anche nella sua versione gramsciana.
Ma non ne sono convinto, perché l’opera di Vygotskij va ben oltre ogni confine riduttivamente culturale. È più credibile il perdurare di una opzione cognitivista ancora prevalente nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento.
Se sei interessato all’argomento ti suggeriamo questa nostra intervista con Raffaele Iosa che racconta il suo incontro con la figlia di Vygotskij
