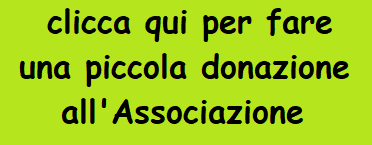Album di famiglia, a proposito del “kennediano di Piadena”
Una delle ragioni per cui in Italia le pedagogie attive non sono riuscite a incidere nell’Istituzione scuola e la sua pedagogia è la divisione tra due interpretazioni politiche delle stesse: a sinistra c’era chi le considerava un modo importante per cambiare la società a partire dalla scuola e chi, invece, ritenendo prioritaria anche temporalmente la battaglia politica contro il capitalismo, pensava che fosse del tutto inutile, anzi controproducente, cercare di cambiare un’istituzione borghese che sarebbe di per sé repressiva e quindi meritava di sprofondare. Quest’ultima posizione era sostenuta, ad esempio, dai Quaderni Piacentini.
Quaderni Piacentini era una Rivista politica trimestrale fondata da Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi nel 1962. E’ stata un’importante rivista della sinistra extraparlamentare.
In questo articolo del 1971 (è pubblicato integralmente sul sito di Gessetti Colorati) Mario Lodi, definito il “kennediano di Piadena” viene accusato di “riformismo didattico”. Il riformismo sarebbe ingenuo e pericoloso perché manipolerebbe i ragazzi con una forma edulcorata di potere invece di renderli consapevoli della lotta di classe in cui l’avversario sarebbe anche l’insegnante (viene alla mente, ad esempio, “Quel brutale, finalmente? “ un classico di quegli anni).
Il rapporto educativo sarebbe di per sé autoritario, dunque la classe cooperativa non sarebbe altro che un mito borghese, un inganno.
Le riforme con cui Lodi (e molti come me) lavoravano negli anni Settanta e le tecniche didattiche sarebbero stati dunque una manovra del potere per mantenere il suo sfruttamento di classe. E via discorrendo. In questo articolo (mancano le firme delle persone, secondo una consolidata prassi per cui non ci si assume la responsabilità personale ma solo quella del collettivo) l’intolleranza ideologica prevale su tutto. Non si lavora per un’educazione alla tolleranza e alla democrazia ma per radicalizzare un conflitto radicale tra il bene e il male, dove il bene sta naturalmente dalla parte degli autori dell’articolo. Tutte le utopie, quando si trasformano in concezioni provvidenziali della storia, finiscono lì.
L’utopia della speranza si trasforma in utopia della certezza, dei detentori della verità. Questo articolo è importante perché, riaprendo l’armadio dei ricordi della sinistra, svela ambiguità presenti ancor oggi e su cui non si è ancora ampiamente riflettuto.
Cadute le illusioni palingenetiche, queste posizioni oggi si ripresentano sotto una veste diversa, quella della deistituzionalizzazione e della critica radicale della scuola in nome di un’idea di rifiuto totale di qualsiasi autorità, considerata di per sé repressiva (rifiuto che, questo sì, è un mito: il rifiuto totale di qualsiasi autorità non elimina l’autorità ma ne introduce una forma più sottile, quella della seduzione).
E’ un rifiuto a cui vengono spesso arruolati educatori come Oury o Freinet, che però non sostenevano affatto queste tesi. Oggi tutti osannano Mario Lodi ma allora molti a sinistra lo condannavano duramente.
Se non vogliamo comportarci come le Chiese laiche o religiose più integraliste (da vivi li condannano come eretici, e dopo morti li fanno santi, tanto non possono più parlare) sarebbe bene ragionare su tutto questo e chiedersi se non siano ancora presenti logiche settarie che non fanno che ostacolare l’impegno comune a favore delle pedagogie attive e dell’impegno per una società più giusta e solidale.