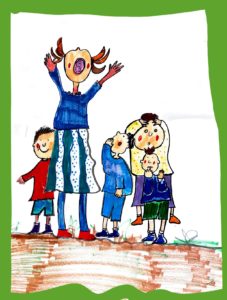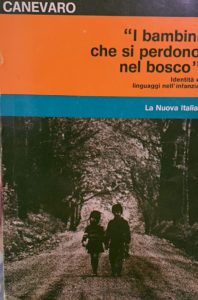di Marco Guastavigna
Walled garden e business network fremono di sdegno: il ministro Bianchi – con una formulazione che, se riportata fedelmente, è lesiva anche della grammatica – ha ancora una volta sconvolto il proprio universo di riferimento professionale: “In Italia, in 4-5 anni, dobbiamo riaddestrare 650mila insegnanti per andare incontro ad insegnamento adeguato al futuro digitale e all’interconnessione globale che si è ormai prospettato”.
Ma come si permette? Riaddestrare, ovvero addestrare un’altra volta? Approccio davvero pessimo. Per non parlare dell’obbligatorietà della formazione, vulnus ricorrente e storicamente pluri-rigettato dalla categoria.
I contenuti di questa obedience 4.0, binomio esseri umani-dispositivi digitali? La solita confusione concettuale, il solito lessico nebuloso del marketing istituzionale: “Abbiamo investito 800mln per farlo e solo ieri abbiamo lanciato un progetto da 2,5mln per dare nuova formazione a chi insegna. Dobbiamo affrontare questo percorso per introdurre nella scuola l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione collegata alla questione etica. Non siamo all’anno zero, abbiamo già dei buoni esempi ma ora dobbiamo spalmare questi primi buoni risultati per toccare i 10mln di studenti italiani”.
Prossimo al gramelot, ma del tutto coerente con le scelte di chi lo ha immediatamente preceduto, il rapporto con le piattaforme del capitalismo cibernetico e la privatizzazione della sfera dell’istruzione pubblica: “Il problema al quale stiamo lavorando con i tecnici del ministero è come le aziende del sistema globale possono essere d’aiuto per l’Ue e per l’Italia per raggiungere il risultato di questa diversa crescita formativa interpretando in modo corretto i nuovi linguaggi che devono usare ai vari livelli gli insegnanti di matematica, materie umanistiche, lingue e via dicendo”.
Continua a leggere
di Marco Guastavigna
Walled garden e business network fremono di sdegno: il ministro Bianchi – con una formulazione che, se riportata fedelmente, è lesiva anche della grammatica – ha ancora una volta sconvolto il proprio universo di riferimento professionale: “In Italia, in 4-5 anni, dobbiamo riaddestrare 650mila insegnanti per andare incontro ad insegnamento adeguato al futuro digitale e all’interconnessione globale che si è ormai prospettato”.
Ma come si permette? Riaddestrare, ovvero addestrare un’altra volta? Approccio davvero pessimo. Per non parlare dell’obbligatorietà della formazione, vulnus ricorrente e storicamente pluri-rigettato dalla categoria.
I contenuti di questa obedience 4.0, binomio esseri umani-dispositivi digitali? La solita confusione concettuale, il solito lessico nebuloso del marketing istituzionale: “Abbiamo investito 800mln per farlo e solo ieri abbiamo lanciato un progetto da 2,5mln per dare nuova formazione a chi insegna. Dobbiamo affrontare questo percorso per introdurre nella scuola l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione collegata alla questione etica. Non siamo all’anno zero, abbiamo già dei buoni esempi ma ora dobbiamo spalmare questi primi buoni risultati per toccare i 10mln di studenti italiani”.
Prossimo al gramelot, ma del tutto coerente con le scelte di chi lo ha immediatamente preceduto, il rapporto con le piattaforme del capitalismo cibernetico e la privatizzazione della sfera dell’istruzione pubblica: “Il problema al quale stiamo lavorando con i tecnici del ministero è come le aziende del sistema globale possono essere d’aiuto per l’Ue e per l’Italia per raggiungere il risultato di questa diversa crescita formativa interpretando in modo corretto i nuovi linguaggi che devono usare ai vari livelli gli insegnanti di matematica, materie umanistiche, lingue e via dicendo”.
Continua a leggere
![]()





 La società attuale si caratterizza per l’avvento della globalizzazione, che sta incidendo profondamente sia nella vita delle singole persone che della collettività.
La globalizzazione è un fenomeno complesso, che riguarda la sfera economica, socio-politica e culturale. Il primo aspetto è legato all’esistenza delle multinazionali e all’esigenza di importare ed esportare materie prime e merci.
Il secondo aspetto riguarda la nascita di organizzazioni internazionali sia a carattere politico (ONU, OCSE), che sociali (OMS, UNESCO).
Infine, l’aspetto culturale riguarda l’integrazione delle culture, delle tradizioni, dei valori e dei comportamenti di alcuni popoli rispetto ad altri.
Il complesso tema degli alunni non italiani viene affrontato in modo ampio e documentato nel
La società attuale si caratterizza per l’avvento della globalizzazione, che sta incidendo profondamente sia nella vita delle singole persone che della collettività.
La globalizzazione è un fenomeno complesso, che riguarda la sfera economica, socio-politica e culturale. Il primo aspetto è legato all’esistenza delle multinazionali e all’esigenza di importare ed esportare materie prime e merci.
Il secondo aspetto riguarda la nascita di organizzazioni internazionali sia a carattere politico (ONU, OCSE), che sociali (OMS, UNESCO).
Infine, l’aspetto culturale riguarda l’integrazione delle culture, delle tradizioni, dei valori e dei comportamenti di alcuni popoli rispetto ad altri.
Il complesso tema degli alunni non italiani viene affrontato in modo ampio e documentato nel