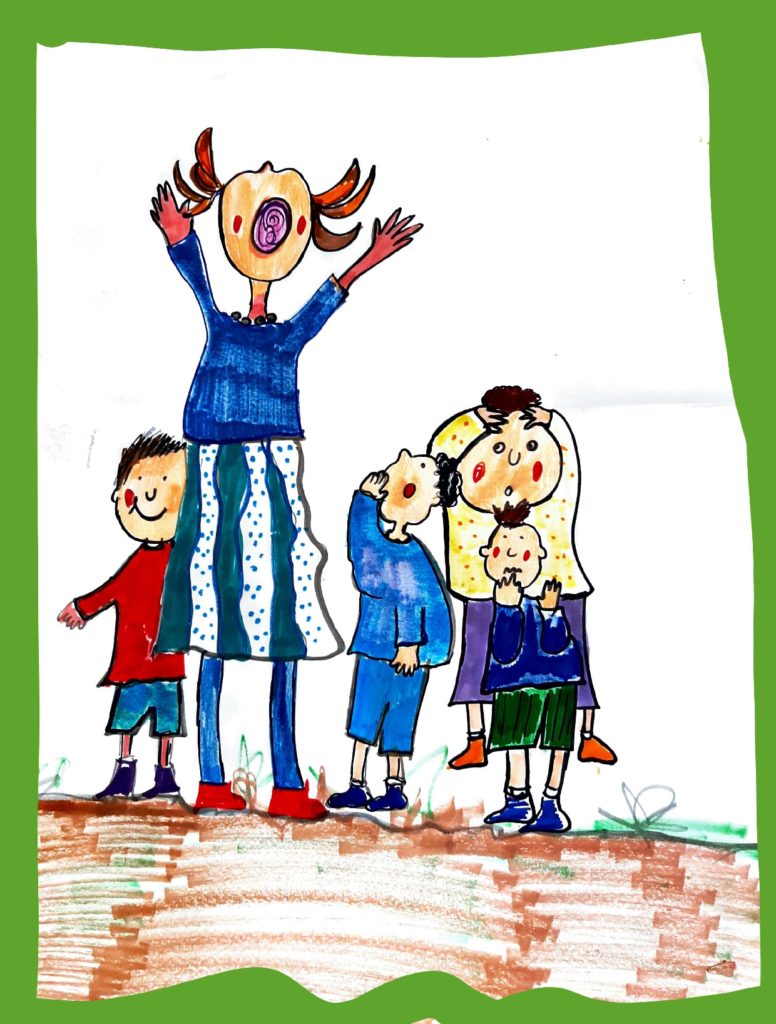di Rodolfo Marchisio
Di cosa si parla nel nostro percorso di formazione
Nel nostro percorso di riflessione e discussione previsto sul tema Come il web cambia il nostro linguaggio, presentato nell’articolo La lingua italiana ai tempi del web ed esemplificato nell’articolo Come il web cambia la nostra lingua intendiamo dialogare insieme sui temi di linguistica, cittadinanza, cultura digitale legati al campo di ricerca che proponiamo.
Partendo da 4 obiettivi ed approfondendo insieme i 4 filoni che si possono sviluppare anche in base all’interesse espresso dai partecipanti tramite il form d’iscrizione.
Premessa. La lingua cambia con l’avvento del web e questo cambiamento coinvolge:
Informazioni, conoscenze, pensieri, modo di ragionare e di agire
ma anche
percezioni, emozioni, sentimenti, relazioni, amicizie, modo di essere.
Questo significa che ci cambia sia come persone, nella nostra vita individuale, sociale e relazionale,
sia come cittadini negando o modificando comportamenti legati a diritti.
E che questi cambiamenti sono intrecciati fra loro e legati anche all’influenza del web.
Filoni 1. – Lingua (lessico, grammatica, linguistica) e informazione.
di Rodolfo Marchisio
Di cosa si parla nel nostro percorso di formazione
Nel nostro percorso di riflessione e discussione previsto sul tema Come il web cambia il nostro linguaggio, presentato nell’articolo La lingua italiana ai tempi del web ed esemplificato nell’articolo Come il web cambia la nostra lingua intendiamo dialogare insieme sui temi di linguistica, cittadinanza, cultura digitale legati al campo di ricerca che proponiamo.
Partendo da 4 obiettivi ed approfondendo insieme i 4 filoni che si possono sviluppare anche in base all’interesse espresso dai partecipanti tramite il form d’iscrizione.
Premessa. La lingua cambia con l’avvento del web e questo cambiamento coinvolge:
Informazioni, conoscenze, pensieri, modo di ragionare e di agire
ma anche
percezioni, emozioni, sentimenti, relazioni, amicizie, modo di essere.
Questo significa che ci cambia sia come persone, nella nostra vita individuale, sociale e relazionale,
sia come cittadini negando o modificando comportamenti legati a diritti.
E che questi cambiamenti sono intrecciati fra loro e legati anche all’influenza del web.
Filoni 1. – Lingua (lessico, grammatica, linguistica) e informazione.
- La lingua come gioco di costruzioni
- Semplificazione attuale della lingua italiana (ipotassi/paratassi)
- Scomparsa di modi e tempi del verbo e democrazia
- La riduzione del vocabolario
- La lingua dei giovani
- SMS, abbreviazioni, lapidi, Placiti cassinesi
- Neologismi, parole straniere, gergo social
- Decalogo dell’informazione – Paone
- Le regole della disinformazione – Choamsky
- Riflessioni sulla lingua – Ghemo
- Il rapporto numero e qualità delle parole e democrazia
- Influenza del linguaggio sulle competenze chiave
- Alice nel paese delle meraviglie – le parole e il potere
- Le parole (anche online) sono “fatti” ed hanno conseguenze reali
- Come la lingua influenza il modo di pensare
- Parole e potere: le neo-lingue
- Post verità e percepito
- Svalutazione della conoscenza e della competenza
- Nuove competenze linguistiche digitali
- Parole chiave della lingua
- Accademia della Crusca – Video sul tema.
- Lingua del web: aggressività e mancanza linguaggi non verbali. Wallace.
- Il linguaggio del corpo ed il tono della voce
- Il linguaggio (e il gergo dei social)
- Emozioni ed emoticon
- Parole ombrello (digitale, libertà, democrazia)
- Post verità, fake news e parole dell’odio. L’odio in rete.
- Caratteristiche e regole della lingua online
- della Crusca: varie forme di comunicazione mediata dalla rete.
- Il mezzo influenza lo scritto: breve, semplificato nei SN, più lungo e complesso nei siti ufficiali
- Lettura spezzata o multimediale
- Il rapporto testo e interfaccia
- Lessico: nuove parole per nuove cose (hastag), anglicismi, sigle (FB), parole da azioni (cliccare).
- La famiglia del web (webmaster…)
- Vecchie parole, nuovi significati (Virale)
- Tormentoni e regionalismi.
- Linguistica e letteratura del coding
- Libro e/o e book
- Stili di lettura off e online
- Leggere e leggere online
- Lettura ipertestuale
- Scrivere e scrivere online
- Scrittura online. Regole, caratteristiche, consigli
- La disintermediazione: tutti scrittori. Si ma…
- Il nuovo linguaggio dei giovani multimediale dei giovani.
- I vantaggi della scrittura ipertestuale e della scrittura collettiva o a più mani.
![]()


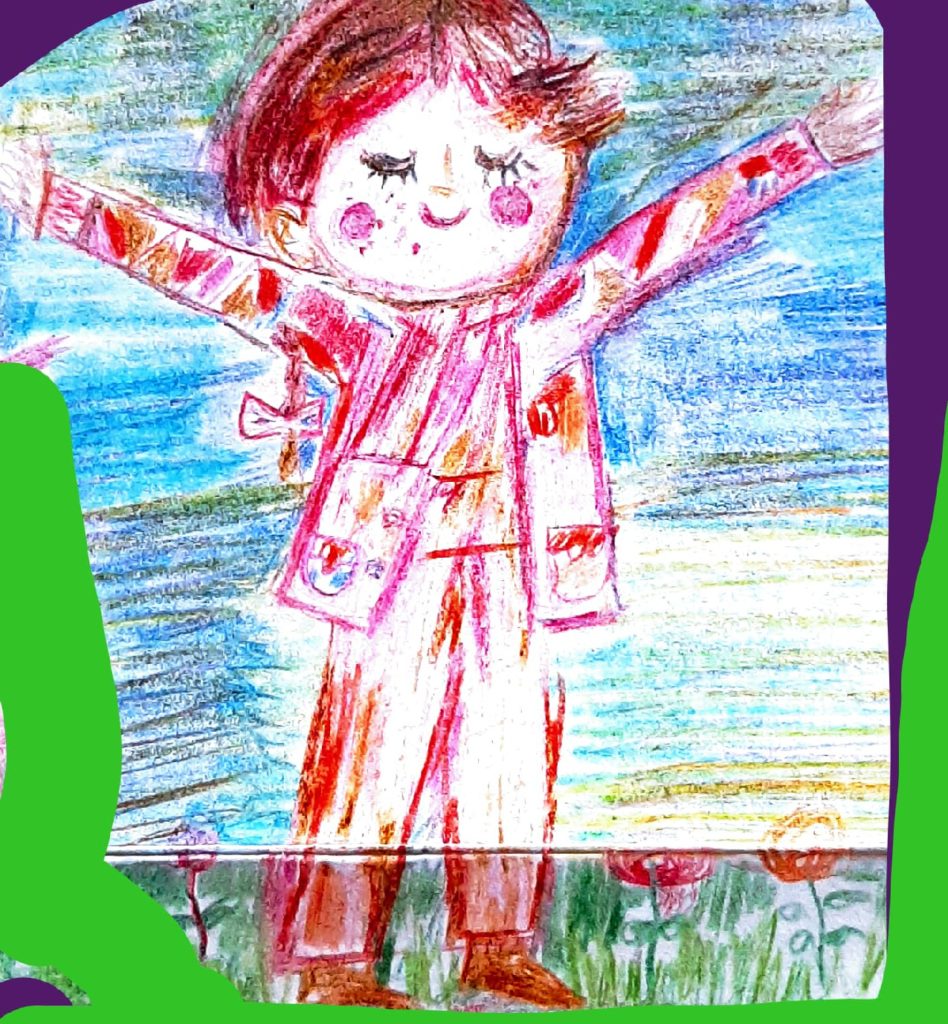


 disegno di Matilde Gallo, anni 10[/caption]
di Guglielmo Rispoli
Dunque sarà Ministero dell’Istruzione e del merito.
Sono il profilo politico guardando da destra, da sinistra o da centro si possono fare tutte le legittime ipotesi (probabilmente tutte errate) con riferimento al proprio legittimo punto di vista ma anche col rischio di incorrere nei pregiudizi tipici di una popolazione che ragiona per approssimazione e luoghi comuni e dimenticando, parlo per i presunti progressisti, che il novecento è finito.
Questo mio contributo analizza il rapporto tra Scuola e Merito focalizzandosi sul ruolo e il successo delle azioni di Ministero dal 1999 ad oggi (vari governi di destra e centro destra e vari governi di centrosinistra).
Senza ombra di dubbio l’Amministrazione della Scuola della Repubblica Italiana è immeritevole.
Vediamo insieme perché prendendo dati conosciuti e significativi.
#01_ I dati della corruzione della politica e il numero dei processi la dicono lunga sullo scarso merito degli amministratori pubblici intesi come categoria e non come singoli. Anche nel Ministero dell’istruzione ci sono stati recentissimi casi di inquinamento e di tangenti, fatti inaccettabili.
Voto in decimi: 4emezzo – grazie al lavoro indefesso ed onesto di tanti.
Giudizio descrittivo: si può e si deve fare di più. Diamo spazio e visibilità alla qualità del lavoro dell’onesto personale amministrativo dal Ministero agli UUSSRR, alle singole Scuole
disegno di Matilde Gallo, anni 10[/caption]
di Guglielmo Rispoli
Dunque sarà Ministero dell’Istruzione e del merito.
Sono il profilo politico guardando da destra, da sinistra o da centro si possono fare tutte le legittime ipotesi (probabilmente tutte errate) con riferimento al proprio legittimo punto di vista ma anche col rischio di incorrere nei pregiudizi tipici di una popolazione che ragiona per approssimazione e luoghi comuni e dimenticando, parlo per i presunti progressisti, che il novecento è finito.
Questo mio contributo analizza il rapporto tra Scuola e Merito focalizzandosi sul ruolo e il successo delle azioni di Ministero dal 1999 ad oggi (vari governi di destra e centro destra e vari governi di centrosinistra).
Senza ombra di dubbio l’Amministrazione della Scuola della Repubblica Italiana è immeritevole.
Vediamo insieme perché prendendo dati conosciuti e significativi.
#01_ I dati della corruzione della politica e il numero dei processi la dicono lunga sullo scarso merito degli amministratori pubblici intesi come categoria e non come singoli. Anche nel Ministero dell’istruzione ci sono stati recentissimi casi di inquinamento e di tangenti, fatti inaccettabili.
Voto in decimi: 4emezzo – grazie al lavoro indefesso ed onesto di tanti.
Giudizio descrittivo: si può e si deve fare di più. Diamo spazio e visibilità alla qualità del lavoro dell’onesto personale amministrativo dal Ministero agli UUSSRR, alle singole Scuole