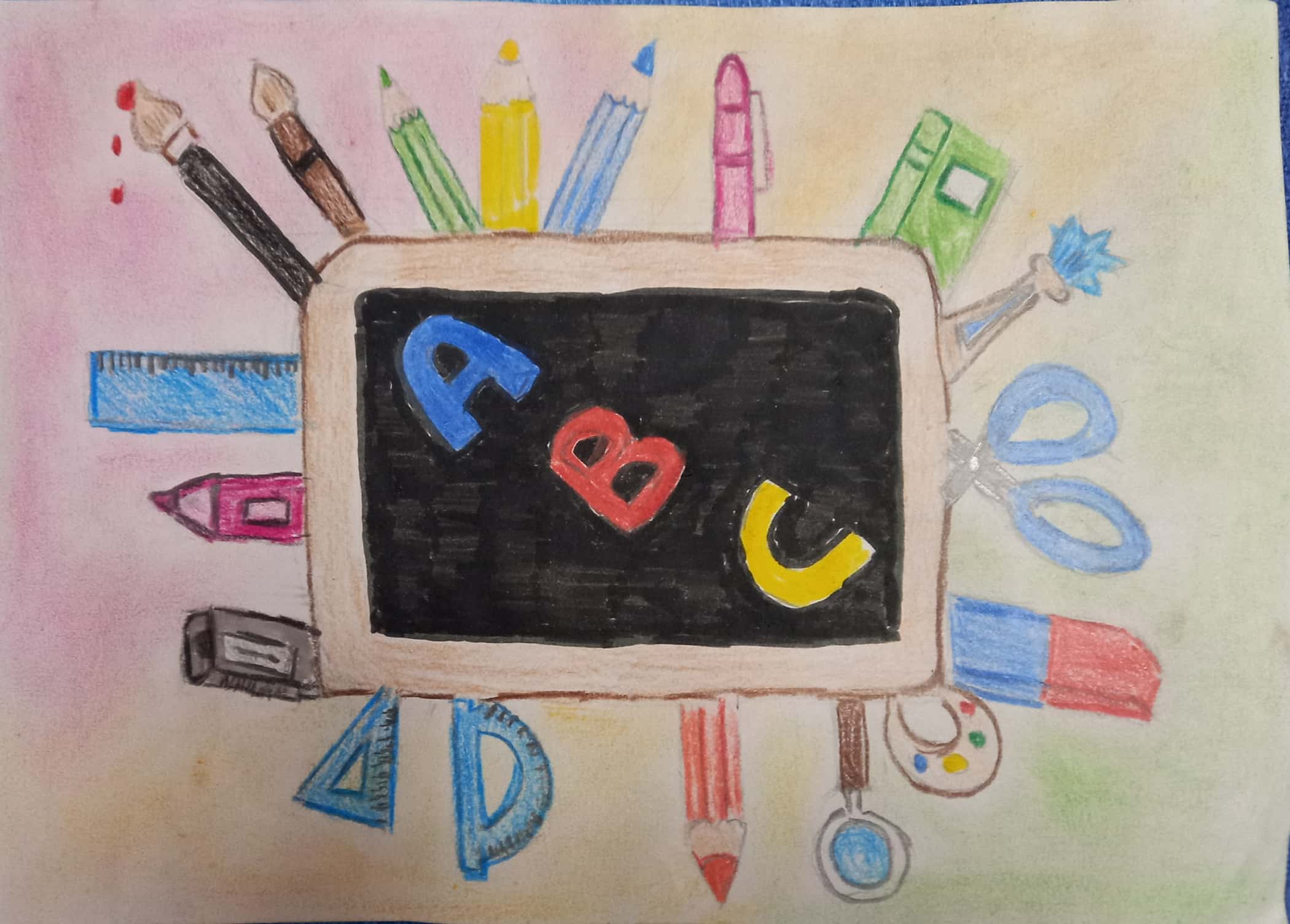a cura di Giancarlo Cavinato
Il MCE propone 4 passi per una pedagogia dell’emancipazione. Si tratta di organizzare un impianto sistemico costituito da moduli variamente componibili e adattabili alle esigenze dei singoli contesti. Sono proposte concrete, realizzabili in ogni scuola, in grado di attribuire valore aggiunto all’azione professionale e collegiale, e di rappresentare gli elementi da cui partire per realizzare percorsi di partecipazione e condivisione e dispositivi organizzativi in grado di qualificare i contesti e di aumentare i livelli formativi..
I 4 passi si propongono come ponti fra l’organizzazione e le relazioni e gli strumenti concettuali di ricerca. Ciascuno dei passi si realizza attraverso la forza e le potenzialità delle esperienze che prevede: discutere e decidere insieme, appartenere a diversi gruppi nella propria e con altre classi con impegni e sviluppi diversi, fare ricerca, possibilità di maneggiare e consultare una pluralità di testi e di fonti, collegarsi con classi di altre parti del paese e del mondo e la sensazione di condividere speranze e obiettivi, veder nascere e contribuire a un prodotto come il giornale il libro il video…
a cura di Giancarlo Cavinato
Il MCE propone 4 passi per una pedagogia dell’emancipazione. Si tratta di organizzare un impianto sistemico costituito da moduli variamente componibili e adattabili alle esigenze dei singoli contesti. Sono proposte concrete, realizzabili in ogni scuola, in grado di attribuire valore aggiunto all’azione professionale e collegiale, e di rappresentare gli elementi da cui partire per realizzare percorsi di partecipazione e condivisione e dispositivi organizzativi in grado di qualificare i contesti e di aumentare i livelli formativi..
I 4 passi si propongono come ponti fra l’organizzazione e le relazioni e gli strumenti concettuali di ricerca. Ciascuno dei passi si realizza attraverso la forza e le potenzialità delle esperienze che prevede: discutere e decidere insieme, appartenere a diversi gruppi nella propria e con altre classi con impegni e sviluppi diversi, fare ricerca, possibilità di maneggiare e consultare una pluralità di testi e di fonti, collegarsi con classi di altre parti del paese e del mondo e la sensazione di condividere speranze e obiettivi, veder nascere e contribuire a un prodotto come il giornale il libro il video…
Primo passo: gli strumenti di democrazia.
In una delle invarianti pedagogiche Freinet[1] afferma che un regime scolastico autoritario non può formare cittadini democratici. «La democrazia é impegno partecipativo nella costruzione dei valori che regolano la convivenza umana. In tale impegno, l’educazione svolge il ruolo fondamentale dello sviluppo dell’intelligenza, della comprensione, dell’esperienza, dell’apprendimento, della collaborazione e della difesa dell’uguaglianza.»[2] La democrazia si esercita mediante regole, procedure, strumenti e pratiche attraverso cui si costruiscono e si determinano scelte possibili e condivise. Le idee, le opinioni, i giudizi sulla realtà non sono preesistenti alla loro scoperta da parte dei soggetti, ma si formano attraverso una pratica e un’esperienza di relazionalità e socialità. L’istituzione ad hoc è l’assemblea di classe come iniziazione alla vita democratica, alla solidarietà. Un’assemblea con le sue routine e le sue suddivisioni di compiti. Chi presiede, chi verbalizza, chi dà i tempi degli interventi. Durante la settimana su cartelloni i bambini trascrivono le loro osservazioni, proposte, critiche, suggerimenti da analizzare nell’assemblea. Ogni aspetto della vita scolastica acquista così senso e giustificazione. La finalità gradualmente condivisa è l’uguaglianza di diritti e il successo formativo di tutti. Le forme di partecipazione risultano tanto più efficaci quanto più ai ragazzi viene data parola e possibilità di progettare estendendo il raggio della loro progettualità alla città attraverso l’organizzazione di consulte e consigli.[3] Continua a leggere ![]()

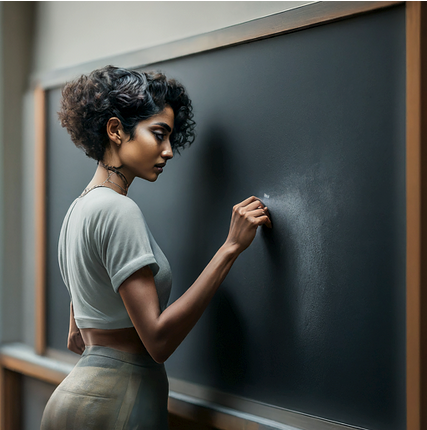 Immagine realizzata con Google Bard[/caption]
di Marco Guastavigna
Il tema della cosiddetta intelligenza artificiale è l’esempio più recente, ma certamente non il solo.
Sono davvero troppi gli insegnanti che, di fronte a qualsiasi accenno di novità si accontentano di esperienze limitate, brevi letture – tendenzialmente mediatiche e con approccio sensazionalista –, rapidi webinar e succinti scambi di opinioni (se non addirittura di slogan) e pensano di aver analizzato, classificato, capito in modo significativo.
E quindi di saper rifiutare o accettare con buona consapevolezza.
Lo scopo strategico, più o meno consapevole, di chi opta per il diniego è tornare serenamente a praticare ciò che si pensa di controllare pienamente, con modi, tempi, tecniche, procedure rassicuranti, perché note, consolidate, convenzionali, condivise da generazioni. Quello di chi fa la scelta opposta è cominciare serenamente a praticare la proposta di cambiamento del momento, con modi, tempi, tecniche, procedure a loro volta rassicuranti, perché innovative, accattivanti, creative, proiettate verso il futuro, spesso foriere di presenze in
Immagine realizzata con Google Bard[/caption]
di Marco Guastavigna
Il tema della cosiddetta intelligenza artificiale è l’esempio più recente, ma certamente non il solo.
Sono davvero troppi gli insegnanti che, di fronte a qualsiasi accenno di novità si accontentano di esperienze limitate, brevi letture – tendenzialmente mediatiche e con approccio sensazionalista –, rapidi webinar e succinti scambi di opinioni (se non addirittura di slogan) e pensano di aver analizzato, classificato, capito in modo significativo.
E quindi di saper rifiutare o accettare con buona consapevolezza.
Lo scopo strategico, più o meno consapevole, di chi opta per il diniego è tornare serenamente a praticare ciò che si pensa di controllare pienamente, con modi, tempi, tecniche, procedure rassicuranti, perché note, consolidate, convenzionali, condivise da generazioni. Quello di chi fa la scelta opposta è cominciare serenamente a praticare la proposta di cambiamento del momento, con modi, tempi, tecniche, procedure a loro volta rassicuranti, perché innovative, accattivanti, creative, proiettate verso il futuro, spesso foriere di presenze in 


 Immagine realizzata con Midjourney[/caption]
di Marco Guastavigna
Era dai tempi della
Immagine realizzata con Midjourney[/caption]
di Marco Guastavigna
Era dai tempi della