di Giovanni Fioravanti Per il Censis siamo affetti da sonnambulismo, precipitati nel profondo sonno della ragione che continuerà a generare mostri, se non ci riscuotiamo.
“Non sappiamo che cosa ci sta accadendo, ed è precisamente questo che ci sta accadendo” è la celebre frase di José Ortega y Gasset, che Edgar Morin ha posto, due anni or sono, ad epigrafe del suo Svegliamoci!
Per il filosofo francese è necessario trovare una bussola per orientarci nell’oceano dell’incertezza in cui vaghiamo come sonnambuli. Una bussola che ci aiuti a comprendere la storia che stiamo vivendo.
E qui sta la difficoltà. Ad uscirne dovrebbero aiutarci i nostri sistemi di istruzione i quali, benché rincorrano i cambiamenti del tempo, restano però nella sostanza identici a se stessi, ancora espressione di culture da noi ormai lontane, tanto da essere impotenti a generare nuovi modelli di pensiero, indispensabili al benessere e alla sopravvivenza dell’umanità.
Con l’ingresso nel nuovo secolo credevamo che si sarebbero aperti nuovi orizzonti, nuove prospettive fondate sulla potenza dei saperi e della scienza. Pensavamo che l’Antropocene potesse conoscere un’epoca di rigenerazione ambientale e sociale, di nuova umanizzazione, di solidarietà e coesione, un nuovo spirito comunitario come alternativa alla esclusione e alla devitalizzazione suicida del tessuto sociale. Continua a leggere
Per il Censis siamo affetti da sonnambulismo, precipitati nel profondo sonno della ragione che continuerà a generare mostri, se non ci riscuotiamo.
“Non sappiamo che cosa ci sta accadendo, ed è precisamente questo che ci sta accadendo” è la celebre frase di José Ortega y Gasset, che Edgar Morin ha posto, due anni or sono, ad epigrafe del suo Svegliamoci!
Per il filosofo francese è necessario trovare una bussola per orientarci nell’oceano dell’incertezza in cui vaghiamo come sonnambuli. Una bussola che ci aiuti a comprendere la storia che stiamo vivendo.
E qui sta la difficoltà. Ad uscirne dovrebbero aiutarci i nostri sistemi di istruzione i quali, benché rincorrano i cambiamenti del tempo, restano però nella sostanza identici a se stessi, ancora espressione di culture da noi ormai lontane, tanto da essere impotenti a generare nuovi modelli di pensiero, indispensabili al benessere e alla sopravvivenza dell’umanità.
Con l’ingresso nel nuovo secolo credevamo che si sarebbero aperti nuovi orizzonti, nuove prospettive fondate sulla potenza dei saperi e della scienza. Pensavamo che l’Antropocene potesse conoscere un’epoca di rigenerazione ambientale e sociale, di nuova umanizzazione, di solidarietà e coesione, un nuovo spirito comunitario come alternativa alla esclusione e alla devitalizzazione suicida del tessuto sociale. Continua a leggere
![]()

 di Carlo Baiocco
… Caronte … Caronte, uhm … chi era costui? E perché proprio Caronte? Caronte……ferocia illuminata! Caronte, il nocchiero di “uomini che furono”! Caronte, il traghettatore d’anime! Colui che conduce le anime nell’oltretomba! Caronte, psicopompo che trasporta i nuovi morti da una riva all’altra! Caronte, figlio di Tenebre e Notte!
Egli è nient’altro che un’entità neutrale, un “messaggero” di ciò che è al di qua e al di là, che collega mondo sensibile e mondo insensibile! Caronte non giudica, Caronte si limita a trasportare! E l’Acheronte non è altro che “il fiume del dolore”! Egli è demiurgo, egli, in fondo, è salvatore; egli è colui che accompagna nel passaggio, nella metamorfosi da vivo a morto, a morto per sempre! Solo pochi sono i vivi che ha condotto, solo pochi sono andati e, soprattutto, son tornati vivi, dopo che Caronte li ha depositati sull’altra riva! Caronte agisce, non fa domande e non si fa domande! Anch’egli, in fondo, è un dannato, dannato a ripetere sempre gli stessi gesti, lo stesso percorso! Egli, avido e crudele, guarda … sotto la lingua, guarda dentro gli occhi, alla ricerca dell’obolo! Ognuno sa, che senza l’obolo, senza le monete, non sarà accolto e vagherà tra le nebbie per cento e cento anni ancora! ………….
E tante, veramente tante sono le analogie con ciò che, purtroppo, è ora!
Tante le analogie con le cosiddette “tragedie del mare”.
Ehm … sì, perché poi, a pensarci bene, i toni lamentosi con cui quest’ultime vengono annunciate non sono altro che ipocrisia! Ma, in fondo, se nel profondo del Mediterraneo, che qualcuno (sigh!) vorrebbe e ritiene ancora “nostrum”, finiscono o continuano a finire migliaia di “anime perse”, a chi vuoi che gliene freghi qualcosa! Tutti a battersi il petto ed a gridare: “Vergogna!”, quando centinaia di corpi riemergono dal mare e centinaia di bare si allineano sulle spiagge.
di Carlo Baiocco
… Caronte … Caronte, uhm … chi era costui? E perché proprio Caronte? Caronte……ferocia illuminata! Caronte, il nocchiero di “uomini che furono”! Caronte, il traghettatore d’anime! Colui che conduce le anime nell’oltretomba! Caronte, psicopompo che trasporta i nuovi morti da una riva all’altra! Caronte, figlio di Tenebre e Notte!
Egli è nient’altro che un’entità neutrale, un “messaggero” di ciò che è al di qua e al di là, che collega mondo sensibile e mondo insensibile! Caronte non giudica, Caronte si limita a trasportare! E l’Acheronte non è altro che “il fiume del dolore”! Egli è demiurgo, egli, in fondo, è salvatore; egli è colui che accompagna nel passaggio, nella metamorfosi da vivo a morto, a morto per sempre! Solo pochi sono i vivi che ha condotto, solo pochi sono andati e, soprattutto, son tornati vivi, dopo che Caronte li ha depositati sull’altra riva! Caronte agisce, non fa domande e non si fa domande! Anch’egli, in fondo, è un dannato, dannato a ripetere sempre gli stessi gesti, lo stesso percorso! Egli, avido e crudele, guarda … sotto la lingua, guarda dentro gli occhi, alla ricerca dell’obolo! Ognuno sa, che senza l’obolo, senza le monete, non sarà accolto e vagherà tra le nebbie per cento e cento anni ancora! ………….
E tante, veramente tante sono le analogie con ciò che, purtroppo, è ora!
Tante le analogie con le cosiddette “tragedie del mare”.
Ehm … sì, perché poi, a pensarci bene, i toni lamentosi con cui quest’ultime vengono annunciate non sono altro che ipocrisia! Ma, in fondo, se nel profondo del Mediterraneo, che qualcuno (sigh!) vorrebbe e ritiene ancora “nostrum”, finiscono o continuano a finire migliaia di “anime perse”, a chi vuoi che gliene freghi qualcosa! Tutti a battersi il petto ed a gridare: “Vergogna!”, quando centinaia di corpi riemergono dal mare e centinaia di bare si allineano sulle spiagge. 
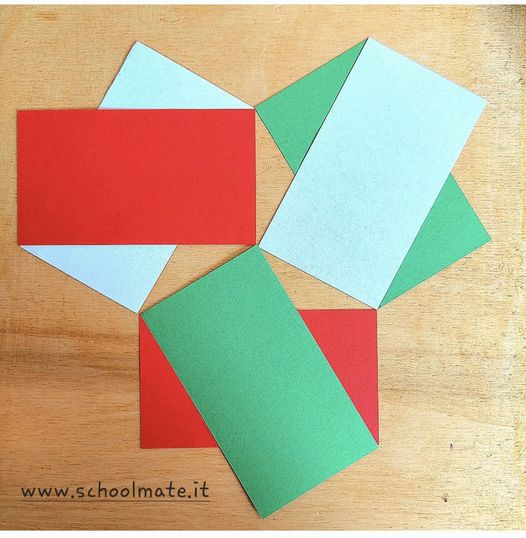

 disegno di Matilde Gallo, anni 10[/caption]
di Raimondo Giunta
La scuola non è solo un servizio sociale; la scuola è anche una istituzione. Come servizio la sua qualità si misura dalla soddisfazione degli utenti; come istituzione la qualità si misura dalla capacità di conservare e sviluppare i valori di una comunità; come servizio si regge sull’attenzione agli interessi individuali; come istituzione si regge sul principio del bene comune. Il bene comune della scuola è costituito dai saperi e dalle conoscenze che è tenuta a tramandare, alcuni dei quali sono fondamentali per la coesione della comunità: lingua, storia, cultura nazionale, valori costituzionali. Saperi necessari.
Saperi che appartengono a tutti e non a pochi privilegiati.
Per definizione.
Principio questo che non ha bisogno di dimostrazione, perché altrimenti non ci sarebbe motivo per finanziare la scuola con risorse dello Stato.
Come istituzione la scuola non può darsi nessuna regola d’esclusione, anche perché il suo costo sociale grava di più su chi meno ne trae beneficio. Ne verrebbe meno il valore; se ne macchierebbe la dignità. Nell’apertura della scuola a tutti sta scritto il meglio della nostra civiltà. Possono essere posti limiti al possesso di beni materiali, non al bisogno e al desiderio di conoscenza e al diritto di formazione. I meccanismi di esclusione a scuola fanno impropriamente del sapere una delle più offensive giustificazioni delle posizioni sociali privilegiate.
La scuola come istituzione non può essere diversa da regione a regione, dal centro alle periferie delle città, dalle grandi città ai piccoli comuni. La scuola come istituzione dovrebbe lavorare per unire e per proporre una valida e riconosciuta gerarchia dei saperi e delle attività, in grado di contrastare la deriva relativistica degli interessi individuali e dei curricoli à la carte. Purtroppo dura da troppo tempo la lotta per ridimensionare l’aspetto istituzionale della scuola, con la complicità forse inconsapevole di parte del personale scolastico, per ridurla alla pura logica del servizio a clienti.
Lo scopo, nemmeno sottinteso, è quello di degradare la funzione del sapere da bene pubblico a mero privato possesso strumentale.
]]>
disegno di Matilde Gallo, anni 10[/caption]
di Raimondo Giunta
La scuola non è solo un servizio sociale; la scuola è anche una istituzione. Come servizio la sua qualità si misura dalla soddisfazione degli utenti; come istituzione la qualità si misura dalla capacità di conservare e sviluppare i valori di una comunità; come servizio si regge sull’attenzione agli interessi individuali; come istituzione si regge sul principio del bene comune. Il bene comune della scuola è costituito dai saperi e dalle conoscenze che è tenuta a tramandare, alcuni dei quali sono fondamentali per la coesione della comunità: lingua, storia, cultura nazionale, valori costituzionali. Saperi necessari.
Saperi che appartengono a tutti e non a pochi privilegiati.
Per definizione.
Principio questo che non ha bisogno di dimostrazione, perché altrimenti non ci sarebbe motivo per finanziare la scuola con risorse dello Stato.
Come istituzione la scuola non può darsi nessuna regola d’esclusione, anche perché il suo costo sociale grava di più su chi meno ne trae beneficio. Ne verrebbe meno il valore; se ne macchierebbe la dignità. Nell’apertura della scuola a tutti sta scritto il meglio della nostra civiltà. Possono essere posti limiti al possesso di beni materiali, non al bisogno e al desiderio di conoscenza e al diritto di formazione. I meccanismi di esclusione a scuola fanno impropriamente del sapere una delle più offensive giustificazioni delle posizioni sociali privilegiate.
La scuola come istituzione non può essere diversa da regione a regione, dal centro alle periferie delle città, dalle grandi città ai piccoli comuni. La scuola come istituzione dovrebbe lavorare per unire e per proporre una valida e riconosciuta gerarchia dei saperi e delle attività, in grado di contrastare la deriva relativistica degli interessi individuali e dei curricoli à la carte. Purtroppo dura da troppo tempo la lotta per ridimensionare l’aspetto istituzionale della scuola, con la complicità forse inconsapevole di parte del personale scolastico, per ridurla alla pura logica del servizio a clienti.
Lo scopo, nemmeno sottinteso, è quello di degradare la funzione del sapere da bene pubblico a mero privato possesso strumentale.
]]> 

