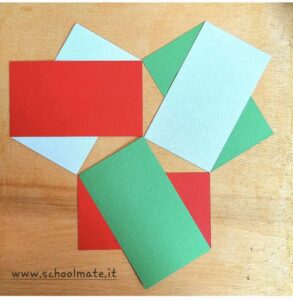 Composizione geometrica di Gabriella Romano[/caption]
di Raimondo Giunta
E’ difficile sperare che della scuola si possa parlare con giudizio e razionalità sulla base di una adeguata conoscenza della sua realtà, dei suoi meccanismi, della sua cultura, delle sue finalità e anche del suo personale. Ogni occasione è buona per parlarne come di un mondo modesto e bizzarro in balia di se stesso, sempre pronto a scandalizzare per quello che vi succede platee affollate di immancabili censori ora per l’incuria delle sue strutture, ora per la supposta imperizia dei docenti, ora per l’incorreggibilità degli studenti, ora per l’arretratezza dei curricoli, ora per l’avversione al mondo aziendale.
Non può sfuggire in questo genere di letteratura l’occasione offerta annualmente dalla differenza tra i dati emersi nell’ indagine INVALSI e quelli riscontrati negli esami di maturità appena conclusi. Nelle regioni del Sud, nelle quali gli studenti dell’ultimo anno nell’indagine INVALSI avevano denunciato carenze in più discipline, si sono avuti agli Esami di Stato risultati ampiamente diversi e migliori.
E allora ci si chiede quali dati siano davvero affidabili sulla preparazione degli studenti e ancora se un esame che fa tutti promossi dappertutto sia davvero un esame che può darci informazioni sul funzionamento dell’attività didattica delle scuole. Mettere in contrasto i dati INVALSI e quelli degli Esami è un gioco facile e si sa in anticipo come va a finire.
Va a finire con la demonizzazione del lavoro degli insegnanti, con la riprovazione della loro incerta etica professionale, con la perorazione di nuove e più incisive forme di valutazione della scuola e degli insegnanti. Per il bene della scuola, invece, vanno migliorati sia gli scopi e i metodi delle indagini INVALSI, sia soprattutto l’architettura degli Esami di Stato.
Il vizio di fondo degli Esami di Stato, che compromette qualsiasi buona intenzione e che va cancellato, è costituito dalla composizione delle commissioni. Fino a quando le commissioni saranno composte paritariamente tra membri interni e membri esterni; fino a quando i commissari devono essere scelti solo tra gli insegnanti della provincia in cui ha sede un istituto i risultati saranno sempre gli stessi. Tutti promossi e tutti con voti più o meno alti, soprattutto dove è difficile e complicato sottrarsi all’ambizione di potere documentare un ricco palmares della propria scuola e talvolta alle sollecitazioni interessate di autorevoli patrocinatori delle sorti degli alunni.]]>
Composizione geometrica di Gabriella Romano[/caption]
di Raimondo Giunta
E’ difficile sperare che della scuola si possa parlare con giudizio e razionalità sulla base di una adeguata conoscenza della sua realtà, dei suoi meccanismi, della sua cultura, delle sue finalità e anche del suo personale. Ogni occasione è buona per parlarne come di un mondo modesto e bizzarro in balia di se stesso, sempre pronto a scandalizzare per quello che vi succede platee affollate di immancabili censori ora per l’incuria delle sue strutture, ora per la supposta imperizia dei docenti, ora per l’incorreggibilità degli studenti, ora per l’arretratezza dei curricoli, ora per l’avversione al mondo aziendale.
Non può sfuggire in questo genere di letteratura l’occasione offerta annualmente dalla differenza tra i dati emersi nell’ indagine INVALSI e quelli riscontrati negli esami di maturità appena conclusi. Nelle regioni del Sud, nelle quali gli studenti dell’ultimo anno nell’indagine INVALSI avevano denunciato carenze in più discipline, si sono avuti agli Esami di Stato risultati ampiamente diversi e migliori.
E allora ci si chiede quali dati siano davvero affidabili sulla preparazione degli studenti e ancora se un esame che fa tutti promossi dappertutto sia davvero un esame che può darci informazioni sul funzionamento dell’attività didattica delle scuole. Mettere in contrasto i dati INVALSI e quelli degli Esami è un gioco facile e si sa in anticipo come va a finire.
Va a finire con la demonizzazione del lavoro degli insegnanti, con la riprovazione della loro incerta etica professionale, con la perorazione di nuove e più incisive forme di valutazione della scuola e degli insegnanti. Per il bene della scuola, invece, vanno migliorati sia gli scopi e i metodi delle indagini INVALSI, sia soprattutto l’architettura degli Esami di Stato.
Il vizio di fondo degli Esami di Stato, che compromette qualsiasi buona intenzione e che va cancellato, è costituito dalla composizione delle commissioni. Fino a quando le commissioni saranno composte paritariamente tra membri interni e membri esterni; fino a quando i commissari devono essere scelti solo tra gli insegnanti della provincia in cui ha sede un istituto i risultati saranno sempre gli stessi. Tutti promossi e tutti con voti più o meno alti, soprattutto dove è difficile e complicato sottrarsi all’ambizione di potere documentare un ricco palmares della propria scuola e talvolta alle sollecitazioni interessate di autorevoli patrocinatori delle sorti degli alunni.]]>
![]()



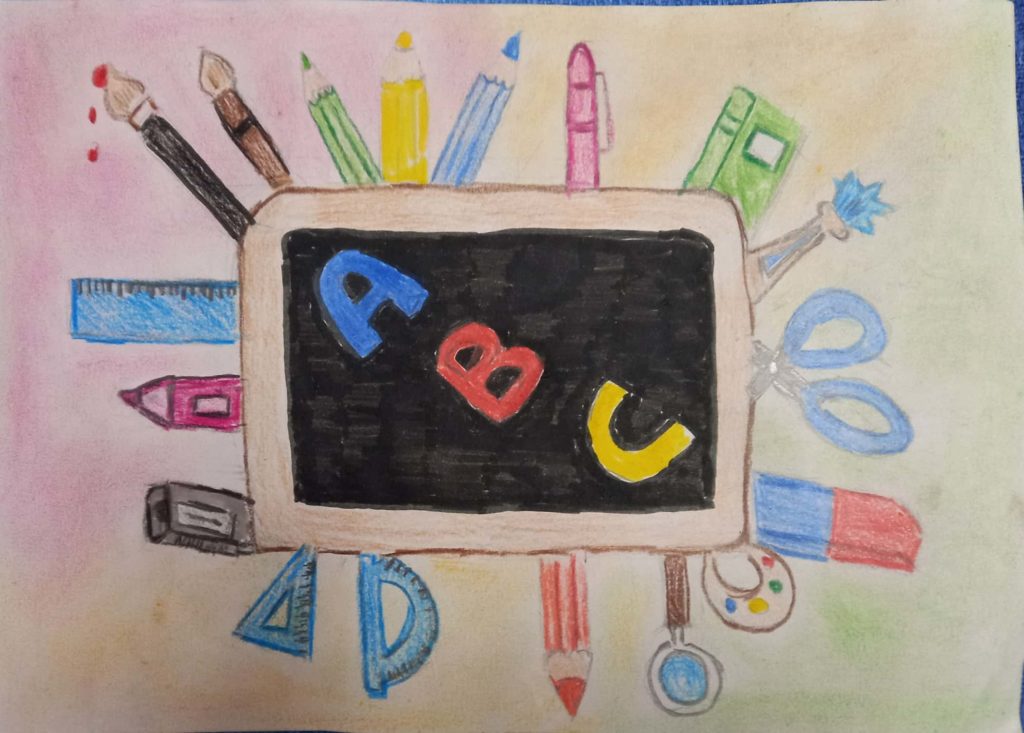 La valutazione degli studenti, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche rispetto all’efficacia delle comunicazioni alle famiglie, pertanto deve rispondere a criteri di coerenza, trasparenza, motivazione e documentabilità.
A tal proposito si richiama l’art.1 del Regolamento sulla valutazione, secondo cui l’allievo ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Proponiamo in proposito un
La valutazione degli studenti, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche rispetto all’efficacia delle comunicazioni alle famiglie, pertanto deve rispondere a criteri di coerenza, trasparenza, motivazione e documentabilità.
A tal proposito si richiama l’art.1 del Regolamento sulla valutazione, secondo cui l’allievo ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Proponiamo in proposito un