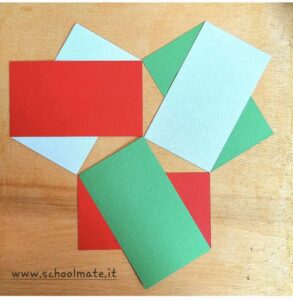Con il PNRR molti soldi per molti progetti, ma manca un progetto
di Nicola Puttilli
Sta crescendo la sensazione che anche per la scuola la valanga di risorse che si sta riversando con il PNRR sia, appunto, soltanto una valanga, una massa imponente e inattesa destinata a sciogliersi nel tempo senza, praticamente, lasciare traccia. In questi mesi assistiamo al paradosso di dirigenti scolastici che lamentano l’arrivo massiccio e continuativo di finanziamenti, quasi sempre vincolati alla digitalizzazione, manifestando quasi il pudore di dover continuare a spendere per materiali e servizi di cui già si ha ampia disponibilità o, comunque, considerati non prioritari. Senza dubbio una singolare constatazione per un sistema che ha visto un progressivo e inesorabile depauperamento di risorse nell’ultimo trentennio.
Ma il paradosso che colpisce maggiormente, nell’epoca della moltiplicazione dei progetti e dei progettifici, è proprio la mancanza di progetto.
Il più grande problema della scuola italiana, sia in termini di equità sociale sia di freno allo sviluppo economico del Paese, è quello della dispersione scolastica e della forte disomogeneità nell’acquisizione di competenze fra i diversi territori (nord-sud, centro-periferie, ecc).
Basta dare uno sguardo ai paesi che più e meglio di noi hanno risolto questo problema per capire che la chiave sta tutta in una didattica attiva, modulare, laboratoriale, attenta alla qualità della relazione. L’esatto contrario della didattica frontale e trasmissiva, inesorabilmente uguale per tutti, da sempre imperante nelle nostre scuole. Del resto c’è poco di che stupirsi, né più né meno di ciò che, dall’inizio del secolo scorso, hanno sostenuto tutti i pedagogisti più illustri , da John Dewey alla nostra Maria Montessori, fino a Célestin Freinet che ha, fra l’altro, ispirato quel Movimento di Cooperazione Educativa che ha fortemente contribuito all’unica vera riforma dal basso, la sola possibile, della nostra scuola.
Trasformazione in senso democratico e ugualitario, suggellata ed enfatizzata dalla lettera di Don Milani, ma che ha avuto insormontabili limiti di natura storica e geografica. Ha infatti dato il meglio di sé tra i primi anni ‘60 e la fine degli anni ’70, soprattutto in alcuni comuni del nord decisi a investire in educazione nelle scuole materne, allora non ancora di competenza statale, con esiti di assoluta eccellenza (Reggio Emilia, Torino, Milano, Bologna, per citarne alcuni) e nella scuola elementare, di nuovo principalmente al nord, fino a produrre fondamentali provvedimenti legislativi come la legge 820 sul tempo pieno e la 517 sulla valutazione formativa e l’inserimento dei disabili.
A distanza di molti anni non appare un semplice caso se negli ordini di scuola e nelle zone del Paese maggiormente toccati dall’innovazione didattica si registrano, ancora oggi, gli esiti migliori per la scuola italiana, anche nelle comparazioni internazionali per la primaria. Resta, d’altro canto, la percezione di come la forte spinta innovatrice di quegli anni abbia sicuramente lasciato tracce ben presenti nelle nostre scuole, ma non le abbia tuttavia modificate nel profondo e, soprattutto, in modo generalizzato.
Sull’onda della destra governante assistiamo sempre di più a un’opinione pubblica che attribuisce, ideologicamente e senza alcun dato di fatto, al post ’68 tutti i mali, o quasi, della nostra scuola. Verrebbe da rispondere che di ’68 ce n’è stato troppo poco o che è finito troppo presto, non che ce n’è stato troppo. Al di là, infatti, di una buona dose di massimalismo e di velleitarismo, sicuramente controproducente ma quasi fisiologica in un movimento così massiccio e dall’esordio così tumultuoso, furono poste allora le premesse per un rinnovamento complessivo della nostra scuola che non hanno purtroppo trovato seguito nei decenni a venire.
Ciò che è mancato, e che continua clamorosamente a mancare, è stata la canalizzazione delle molteplici spinte riformatrici in una visione di insieme e la sua traduzione in un progetto di medio- lungo termine. I principali nodi problematici della nostra scuola sono nodi storici e soprattutto fortemente interrelati, non si possono sciogliere singolarmente ma solo attraverso un approccio sistemico.
- Gli spazi di apprendimento: quasi tutte le nostre scuole sono predisposte per una didattica trasmissiva e frontale, spazi tutti uguali per ripetere all’infinito il rito della lezione collettiva, una palestra (non sempre e spesso inadeguata) per l’attività fisica, qualche spazio rimediato qua e là per i laboratori e un locale mensa nei casi più fortunati, quasi mai al sud. Le scuole italiane sono per lo più vecchie e insicure, nella maggioranza manca perfino il certificato antincendio. Non è procrastinabile un piano nazionale di rinnovamento e messa in sicurezza certamente molto impegnativo sul piano finanziario, ma di cui il PNRR può costituire un primo, importante tassello. La costruzione di nuove scuole o la riconversione e messa a norma di quelle esistenti dovrebbe considerare le esigenze di una didattica attiva e rinnovata; esperienze molto significative in questo senso, alle quali fare riferimento, esistono nel nostro Paese e soprattutto all’estero.
A metà degli anni ’70 a Torino, dove vivo e ho lavorato, furono costruiti alcuni plessi scolastici con caratteristiche molto innovative sulla scorta dell’esperienza della scuola a tempo pieno, nato nel quartiere popolare delle “Vallette”, che cominciava ad avere in città una certa diffusione: pareti delle aule mobili per diversificare gli spazi, buca per il teatro, spazi esterni dedicati agli orti, ecc. Dopo una decina d’anni le pareti erano diventate fisse, la buca per il teatro ricoperta, gli spazi esterni restituiti alla libera ricreazione. Spazi innovativi di apprendimento rischiano di essere una spesa inutile se non affiancati da un serio piano di formazione.
- La formazione del personale: la legge definisce la formazione come strutturale, obbligatoria e permanente ma, di fatto, non è così. I vincoli contrattuali limitano fortemente queste caratteristiche fino a ridurla a una sorta di benemerito volontariato. Le risorse, pur cospicue in questa fase, arrivano alle scuole in modo disorganico rischiando di convergere su iniziative non proprio prioritarie o nelle mani delle realtà più virtuose che meno ne avrebbero bisogno. Un serio piano nazionale richiederebbe obiettivi espliciti e dichiarati, finanziamenti adeguati e valide strutture di supporto alle scuole in grado di fornire progettazione ed esperti di qualità. C’erano una volta gli IRRSAE (Istituti Regionali per la Ricerca la Sperimentazione e l’Aggiornamento Educativo), a un certo punto qualcuno ha cominciato a sostenere che fossero inutili e costosi carrozzoni. Per quello che può valere l’esperienza personale ne ho avuto una percezione totalmente diversa e resto convinto che la loro soppressione fosse principalmente dovuta a mere ragioni di risparmio, piccola parte di quel taglieggiamento partito a metà degli anni ’90 e che ha portato, in quasi un trentennio, a praticamente dimezzare la quota di PIL destinato al sistema nazionale di formazione. Strutture simili, ovviamente rivisitate e adattate alle esigenze attuali, sarebbero invece di grande utilità.
Un serio e qualificato piano di formazione, inserito in un progetto di rinnovamento partecipato e credibile, potrebbe anche essere motivante per il personale docente ma comporterebbe nuovi carichi lavorativi e comporterebbe il superamento degli attuali vincoli contrattuali, si tratterebbe realisticamente di porre in essere un altro contestuale e massiccio intervento.
- Gli stipendi e la carriera dei docenti: nella primavera del 2019 la commissione europea inviava una formale raccomandazione al governo italiano affinché provvedesse sollecitamente ad aumentare gli stipendi degli insegnanti, di gran lunga fra i più bassi di Europa. Da allora nulla è cambiato, i previsti e rituali aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti non hanno in alcun modo colmato il divario, né introdotto alcuna realistica possibilità di carriera. Difficile pensare che una categoria frustrata sul piano stipendiale, oggetto di scarso riconoscimento sociale e lontana dalle attenzioni della politica possa partecipare con entusiasmo a un grande processo di cambiamento come quello che sarebbe necessario e senza gli insegnanti, l’esperienza lo dimostra, non si va da nessuna parte.
Molti altri sono evidentemente i problemi irrisolti della scuola italiana ma quelli sopra delineati sono passaggi obbligati se si vuole tentare seriamente di recuperare il “gap” con i paesi europei più evoluti. I ritardi accumulati sono enormi ma non esistono alternative anche se, al punto in cui siamo, i costi potrebbero sembrare proibitivi. Ancora una volta sono decisive la “capacità di visione” e la volontà della politica, quelle che sono mancate negli ultimi decenni e che sembrano oggi più che mai assenti se è vero che, nel Paese con il maggior tasso di abbandono scolastico e di analfabetismo funzionale, il governo in carica si preoccupa di inserire il merito nella propria intestazione istituzionale. Si inseguono la cronaca e il facile consenso inserendo le ore di educazione civica se il bullismo diventa argomento televisivo, l’orientatore se il tema del giorno è il disallineamento tra l’offerta formativa e il mercato del lavoro e già si prospettano le ore di contrasto al femminicidio, mentre il problema reale è l’innalzamento generale delle competenze dei nostri ragazzi, tutti i nostri ragazzi, in quanto cittadini attivi e responsabili in primo luogo e in quanto lavoratori adeguatamente inseriti nel processo di crescita del Paese.
Lavorare a un grande e condiviso progetto per il raggiungimento di questi fondamentali obiettivi potrebbe contribuire a dare un senso e una visione anche all’azione quotidiana dei nostri insegnanti e dei nostri dirigenti scolastici. Per la classe politica si tratterebbe di una scelta strategica sulla quale far convergere risorse in buona misura provenienti dalla scuola stessa, dal PNRR a quelle, ancora più ingenti, derivanti dal calo demografico, fino a raggiungere gradualmente una quota di PIL destinata al sistema di formazione paragonabile a quella degli anni ’90, in linea con quella dei paesi europei. Si tratterebbe, senza dubbio, di un grande impegno e di un grande investimento, inevitabile se si vuole evitare l’ulteriore declino della nostra scuola e, a stretto giro di posta, dell’intero Paese.