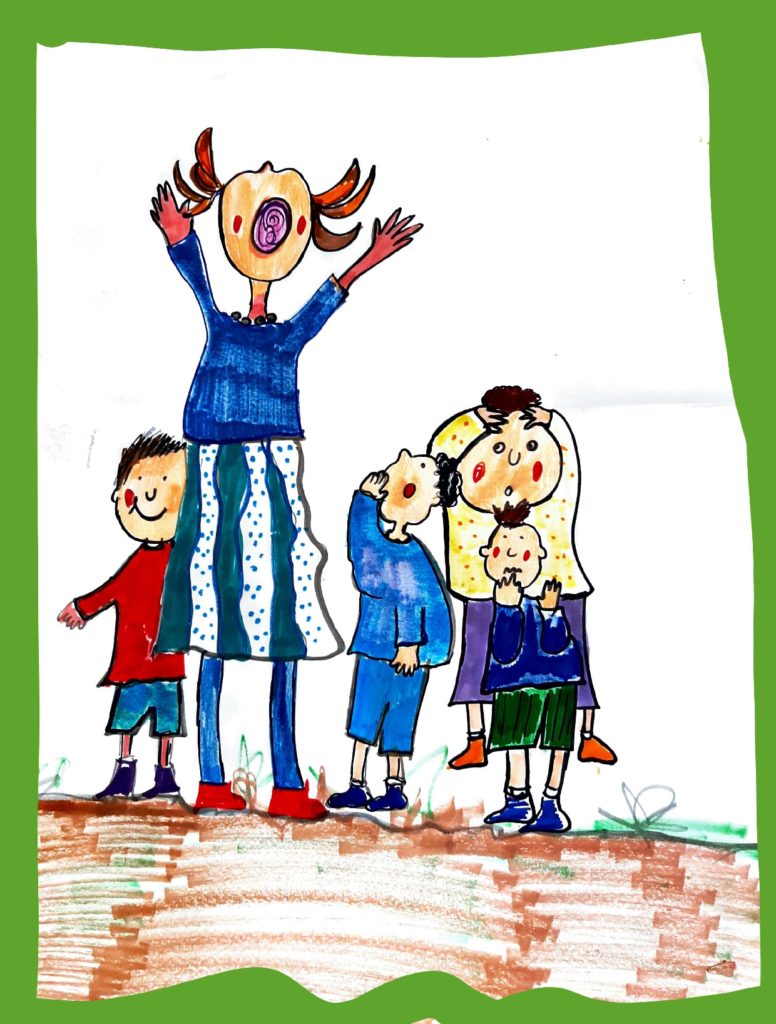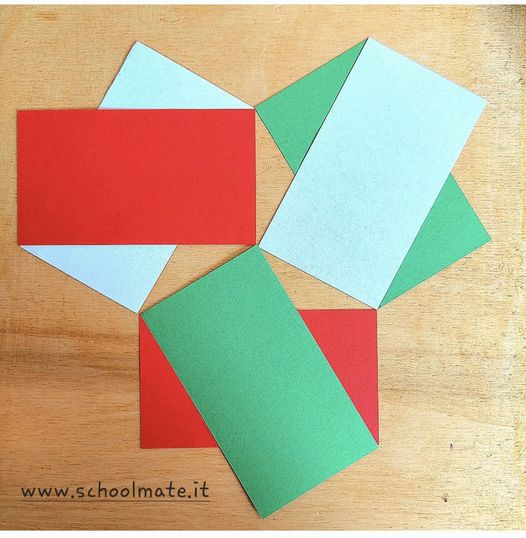di Luigi Saragnese
di Luigi Saragnese
Come un fiume carsico, che scorre nascosto nel sottosuolo, dove manifesta solo effetti indiretti, per poi emergere apertamente in superficie a intervalli più o meno regolari, la questione dell’insegnamento del latino, e della sua affermata “centralità” formativa, riemerge periodicamente nei dibattiti sullo stato della scuola italiana.
È quanto accaduto anche stavolta con l’intervista del ministro Valditara a Il Giornale del 15 gennaio[1]. Nell’annunciare le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo – assieme ad “innovazioni” quali la “comprensione della civiltà musicale sin dalla prima elementare”, l’”insegnamento della letteratura (comprensiva della Bibbia) e della grammatica”(dalla quale ha inizio – precisa il ministro – la cultura della regola), e della Storia “come una grande narrazione”, priva di “sovrastrutture ideologiche” che privilegi “la storia d’Italia, dell’Europa, dell’Occidente”, Valditara ha posto l’accento su quella che si appresta ad essere uno degli assi portanti del suo progetto: l’apertura all’eredità di “un vasto patrimonio di civiltà e tradizioni” attraverso la reintroduzione del Latino a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Continua a leggere
![]()