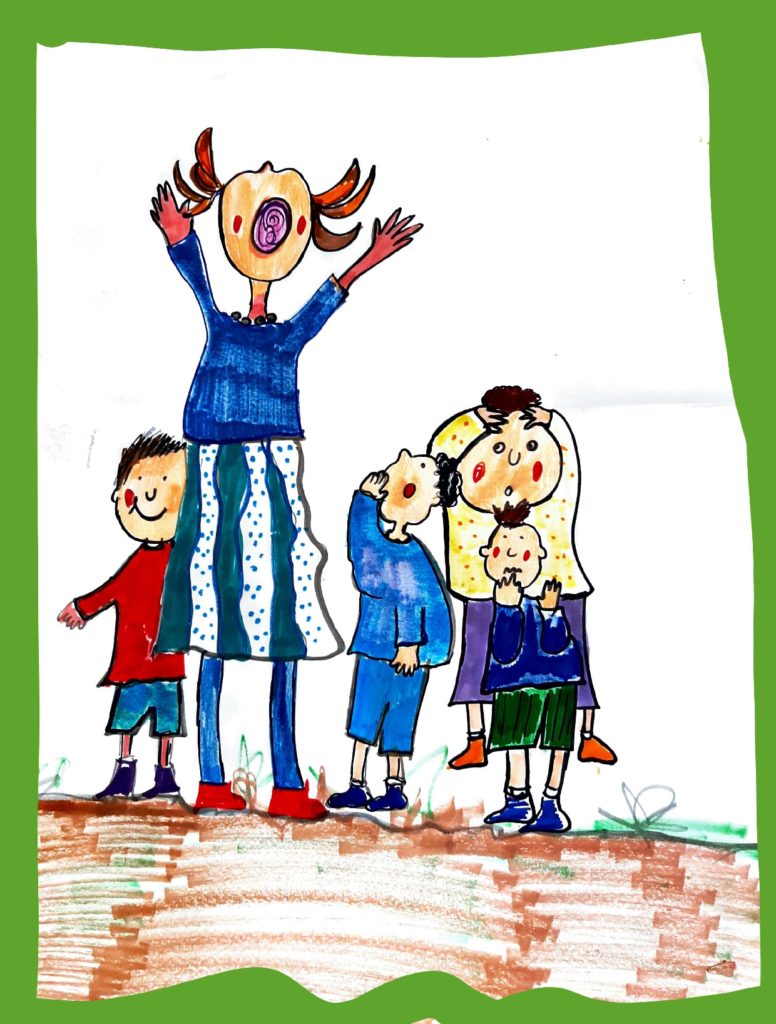di Raffaele Iosa
di Raffaele Iosa
Ho aspettato fino alla riapertura delle scuole, sperando che qualcosa si dicesse. Capisco la complicata situazione italiana di questi ultimi tre mesi, dal caldo torrido, alla crisi di governo, al rincaro delle bollette. Capisco tutto, ma il silenzio del Ministero Istruzione sui bambini e ragazzi ucraini accolti nelle nostre scuole da marzo scorso è sconcertante. Per carità, non sempre è necessario che il Ministero dica qualcosa perché le scuole lavorino con buon senso (anzi!), ma toccano a lui gli accordi internazionali con il governo ucraino per eventuali collaborazioni pedagogiche sul destino dei ragazzi da noi accolti, in attesa del ritorno.
E’ dunque per me necessario risollevare la questione, per comprendere se il neologismo “pedagogia del ritorno”, condiviso da molti come chiave di questa accoglienza, fosse ancora vivo o se si pensasse che ormai, da questo autunno, si dovesse accoglierli come emigranti definitivi o peggio lasciarli in un limbo.
Un doveroso promemoria
Facciamo prima di tutto il punto sulla situazione ucraina, con le notizie di questi ultimi mesi.
Si conferma che questi bambini e ragazzi (e le loro mamme) si sentono solo di passaggio dal fatto che un buon numero è tornato a casa in estate, soprattutto se provenienti dal zone nord e ovest ucraino, e dal 1 settembre sono tornati a scuola, magari in locali di fortuna se le scuole sono state distrutte.
L’arrivo di nuovi profughi ucraini si è fermato. Resta quindi non elevato il numero di scolarizzati in Italia, già basso a primavera perché preferivano fermarsi in paesi confinanti (in primis la Polonia).
Anche questo un segno del desiderio del ritorno.
Il nostro governo ha prestato a tasso zero all’Ukrajna circa 200 milioni di euro per pagare gli insegnanti ucraini. Un buon segno che il nostro paese non invia lì solo armi.
Intanto ci arrivano notizie dure dalle aree ucraine di sudest ancora occupate militarmente dai russi. Sono stati licenziati molti insegnanti locali, sostituiti da “colleghi” russi; dal 1 settembre i ragazzi iniziano le lezioni con l’alzabandiera bianca blu rossa di Mosca, hanno libri importati dalla Russia con le “cose giuste” da insegnare e si parla-scrive rigorosamente solo in russo. Ma c’è di più: alcune migliaia di orfani sociali degli internati sono stati deportati (altro termine non trovo) in Russia in modo forzato. Uno dei tanti modi che ha la terra di Putin di sopperire al suo deserto demografico. Penso con dolore a questi bambini, spesso con babbi e mamme fragilissimi e poveri ma viventi. Bambini portati via dagli orfanotrofi senza rispetto, con fratture esistenziali lancinanti. E ancora: non si sa più nulla di centinaia di preadolescenti portati con la forza in Crimea durante l’estate (le vacanze “coatte”) e non più tornati. Nelle zone di campagna tornano i cd. besprizornye, ragazzi randagi che vivono alla macchia. Un lascito noto nella storia sovietica che si ripete, nato nei primi anni della rivoluzione d’ottobre, di cui ci resta memoria in “Poema pedagogico” del pedagogista ucraino Makarenko e della sua colonia Gorky.
Si rifletta su cosa voglia dire essere bambini e ragazzi da quelle parti in questo settembre: se non si muore per le bombe, si sopravvive in un contesto allucinato col rischio del negarsi la memoria e l’identità. Effetti non collaterali ma voluti di una guerra che non è solo distruzione materiale, ma esistenziale.
Ricapitoliamo ora la nostra memoria sull’Italia. Sono uscite in primavera tre note del Ministero italiano sull’accoglienza dei ragazzi ucraini.
Una prima nota di marzo 2022 li chiama erroneamente “esuli” e invita ad accoglierli, seguendo le solite regole amministrative e di collaborazione a livello locale tra servizi.
La seconda nota n. 576 del 24 marzo li chiama finalmente “profughi” (come sono), e invia ottime riflessioni di carattere pedagogico. Si suggerisce accoglienza mite, riconoscimento dell’ identità di bambini e ragazzi “di passaggio” con il forte desiderio del ritorno, un impegno di ascolto rispettoso della loro condizione esistenziale. Notevole è l’idea di “cura pedagogica” non diversa dall’ Y CARE donmilaniano, operando con una pedagogia che aiuti al ritorno. Appunto, il ritorno. Finalmente un respiro alto.
La terza e ultima nota, invece, la 781 del 14 aprile, scade in uno sconcertante formalismo. A fronte del “canone” scolastico italico sul rito valutativo e curricolare (altro che autonomia scolastica) si suggerisce di considerare questi ragazzi come BES stranieri appena arrivati, quindi con dispense e compense, consolando i buro-pedagoghi del formalismo cartaceo. Ma c’è di peggio: circa la questione della loro straordinaria Dad che, nonostante la guerra, i loro insegnanti coraggiosamente realizzato da marzo a giugno da laggiù (con immensa gioia dei ragazzi che si sentono così un po’ a casa), la terza nota suggerisce con un linguaggio senz’anima di considerarla come “eventuale arricchimento dell’offerta formativa” in aggiunta (solo in aggiunta) alle tradizionali lezioni italiche, e sempre che i docenti italici vogliano. Dunque, la più straordinaria avventura pedagogica di questi mesi (la Dad sotto le bombe) non trattata per il giusto rango di un’esperienza educativa arricchente tutti, in primis loro, e con la quale iniziare un dialogo pedagogico tra colleghi coinvolti qui e lì, ma un mero accessorio transitorio.
Questa sconcertante nota mi ha fatto sospettare una sottovalutazione della fase in un’attesa astratta di cosa sarebbe accaduto della guerra, lasciando ad un indefinito tempo il trattare cosa fare dal settembre.
E infatti sul che fare da settembre il più allarmante silenzio. Il nulla.
Ricordiamo infine che i nostri amici ucraini accolti sono stati in tutto circa 30.000 (molto meno del previsto), che i mesi da marzo a giugno sono stati una sorta di accoglienza d’attesa, la migliore possibile. Adesso, invece, con un anno scolastico intero davanti, le cose si fanno ben più serie.
Restiamo in attesa, o ripartiamo con l’autonomia?
Ricevo numerose telefonate da colleghi e scuole di diverso tipo che mi chiedono cosa fare adesso. Ho scritto molto in primavera sulla pedagogia del ritorno e svolto affollati webinar, quindi molti mi conoscono. I loro racconti non sono sempre felici: ci sono bambini e ragazzi ancora scossi dagli eventi, qualcuno in estate è diventato orfano, di un buon numero di loro non si sa se è rimasto o no. Fortunatamente l’accoglienza racconta anche segni di umanità e solidarietà. Ma le domande sull’oggi sono molte, soprattutto (e non è un caso) sulla loro Dad ucraina: continua o no? Come e se collegarla alle lezioni italiane? Ricevo anche richieste sulla dimensione pedagogica delle relazioni e sul tema della guerra. L’incertezza è anche nelle famiglie ucraine che chiedono notizie alla scuola italiana.
Finchè non arriva la notizia che scuote le famiglie ucraine e che l’Italia non ha ancora dato: le scuole ucraine intendono proseguire anche quest’anno con la loro Dad sia sincrona che asincrona, in tutti i modi possibili e per il miglior tempo possibile. E quindi prendono contatto virtuale con i singoli bambini e ragazzi di cui hanno un indirizzo telefonico o elettronico. Insomma, non intendono perderli.
Ho fatto un giro di telefonate a colleghi ucraini con cui ho ancora contatti e confermano: “si riparte, non li abbandoniamo. In tutti i modi possibili e nei tempi possibili”. Ma chiederebbero, anche, di sapere un po’ di più su cosa accade ai loro ragazzi in Italia. D’altra parte ho rarissimi racconti di contatti tra colleghi italiani e ucraini in primavera: è sembrata a molti un’esperienza quasi “privata”, di cui non si è sempre colto il valore educativo e anche un’opportunità solidaristica su cui meritasse costruire rapporti. Se poi il Ministero italiano aggiunge che la loro Dad è solo un “accessorio”, lo scadimento nella banalità è naturale.
Proposte realistiche e rigorose: per un curricolo binario
Non è necessario, come dicevo all’inizio, che il Ministero mandi per forza chissà quali norme o stringenti indicazioni operative. Le scuole hanno (avrebbero) ampi spazi di autonomia didattica e organizzativa per poter costruire ognuna una propria positiva pedagogia del ritorno. Basta volerlo e crederci.
Per queste ragioni, rompo lo sconcertante silenzio romano con alcune proposte di lavoro aperte a diverse soluzioni, per offrire alle scuole una proposta pedagogica per far crescere con quest’esperienza solidale la capacità di farsi soggetto progettuale libero e creativo.
Suddivido queste proposte in quattro passi, con un passo zero necessario.
- Niente BES
Una premessa necessaria. Si eviti di trattare questi ragazzi nella categoria BES, anche per i rimandi simbolici che questa determina con frequenti effetti iatrogeni e di abbassamento delle attese.
Sono infatti bambini e ragazzi come i nostri, ce n’è di bravi e meno bravi, di più sicuri e più timidi, di più aperti e più chiusi, con mamme e papà non tutti eguali. Vivono il dolore del profugo in diversi modi.
Li lega però l’uno all’altro il fatto che sono dentro una tragedia più grande di loro, stanno vivendo una grande incertezza sul futuro, nell’ansia che il padre non muoia in guerra.
Hanno voglia di tornare a casa e voglia di vivere. Desideri terribilmente normali.
Guai a noi farne una categoria generale psico-pedagogica di sindrome da profuganza educativa di guerra. Non hanno bisogno di insegnanti di sostegno post-traumatico, né di sacerdoti scientifici del trattamento obbligatorio del trauma. Hanno invece bisogno di vicinanza educativa, di rispetto, di ascolto. E soprattutto di riprendere a credere nel futuro, per il quale un pezzo di scuola fatta bene anche in Italia è un primo mattone utile per ricostruire. Non cura pietosa ma speranza. La stessa speranza che esprimono i nostri coraggioso colleghi ucraini che non abbandonano i loro ragazzi sparsi per l’Europa, ma stanno loro dietro in tutti i modi possibili. Possiamo scindere in modo autistico le ore di scuola in Italia dal loro encomiabile impegno via etere? A me pare una bestemmia . Ecco perché la pedagogia del ritorno.
- Un necessario dialogo scuola-genitori di prospettiva
In questo primo mese di scuola è importante che vi sia un colloquio riflessivo e serio tra i nostri insegnanti e le mamme o i parenti che accolgono il nostro alunno o studente ucraino.
E’ un momento necessario per fare il punto di come va la scolarizzazione e di cosa fare a scuola, soprattutto comprendendo la prospettiva in cui si sta muovendo la famiglia per il ritorno in Ukrajna.
Ci sono mamme che pensano di tornare per capodanno: il babbo sta mettendo a posto la casa (Kjiv).
Ci sono mamme rimaste vedove che pensano di tornare dai genitori-nonni in campagna a rifarsi una vita l’estate prossima (Karkiv). Ci sono mamme ancora per aria perché la loro città è distrutta (Mariupol) e attendono dove risistemarsi. Storie molto diverse tra loro, fatte spesso di molti se…allora, che senza morbose curiosità dobbiamo condividere per tarare bene quale sia la più corretta scolarizzazione per questo anno e quali elementi della pedagogia del ritorno siano da perseguire.
Soprattutto dobbiamo sapere dalle mamme di Kjiv, Karkiv, Mariupol, ecc.. se prevedono per il loro figlio/la loro figlia la prosecuzione del contatto Dad con gli insegnanti ucraini, quanto e come.
Quest’ultimo aspetto è decisivo per armonizzare la nostra offerta educativa. So infatti di numerosi casi in cui i genitori ucraini, magari all’oscuro delle offerte della nostra scuola, preferiscono tenerli a casa e fare tutta la scolarità via Dad. Perdendo così quegli elementi di socialità, relazione, apertura culturale che invece potrebbe dare la frequenza nelle nostre aule, convivendo con bambini e ragazzi italiani senza perdere il filo della loro carriera scolastica in patria.
E’ ovvio che i diversi obiettivi di vita per le diverse situazioni rendono diversa la domanda educativa. Una buona pedagogia del ritorno non può che considerarli centrali per il nostro impegno.
- Il contatto con la scuola ucraina
Nel caso (frequentissimo dalla classe 4 alle 11/12) di desiderio dei ragazzi e delle loro famiglie di mantenere la Dad ucraina è opportuno che la scuola cerchi il più possibile un contatto con i nostri colleghi ucraini.
E’ molto meno difficile di quanto si pensi. So peraltro che sarebbe molto attesa: gli insegnanti ucraini vorrebbero entrare in un circuito collaborativo. Lavorare insieme, insomma. Nella speranza del ritorno.
Quasi tutti gli zvitelky (insegnanti) ucraini parlano bene l’inglese, un buon numero anche l’italiano (meno bene), ma hanno tutti skype e la mail, a volte gli manca solo l’elettricità. Pensate alla loro condizione e alla solitudine di avere le scuole vuote e distrutte, pensate al desiderio di rivedere i loro ragazzi. Pensate all’epoca delle passioni generose nel primo duro lokdown italiano di primavera 2020, in cui migliaia di insegnanti italiani senza aver bisogno del Ministero hanno creato spontaneamente un qualche intenso contatto con i loro ragazzi, anche loro chiusi in casa. In modo ancora più drammatico, sotto le bombe e con le case sfasciate, lo stesso spirito educativo muove i colleghi ucraini, non i comandi ministeriali. Non prendono una grivna in più per la Dad, ma nessuno si è tirato indietro. Almeno chi è ancora vivo.
A cosa serva questo contatto tra docenti e scuole è perfino superfluo spiegare: condividere un comune programma di lavoro, spartendosi un possibile curricolo e soprattutto creando anche ai ragazzi l’emozione di sapere che (Italia o Ukrajna che sia) gli insegnanti si pre-occupano di loro con dedizione e collaborazione. Le straordinarie potenzialità del digitale sono in questo terribile caso, un evento straordinario di pedagogia attiva. Un’esperienza che matura scambi professionali di avvincente valore formativo anche per gli adulti. E fa sentire i genitori dei nostri ragazzi anche loro meno soli in un paese straniero.
- Il curricolo binario
Chiamo “curricolo binario” il possibile esito di questo “dialogo professionale” tra colleghi italiani e ucraini. Può realizzarsi anche se saranno difficili i contatti. Il sito del Ministero ucraino abbonda di materiale virtuale, e potrebbe essere seguito da professionisti ucraini in Italia.
Nella logica della pedagogia del ritorno, visto che ai ragazzini ucraini vengono offerte in contemporanea due opportunità curricolari, tanto vale non separarle o ignorarsi l’un l’altra. Nei casi più felici, si potrebbe quindi immaginare, caso per caso (i ragazzi non sono nella stessa classe in Italia) cosa potrebbe fare l’insegnante ucraino e cosa l’italiano. Va tenuto conto che chi è in difficoltà (anche materiali) sono loro, non noi. E dunque, buona cosa a partire dalle disponibilità della Dad ucraina, costruire con flessibilità e intelligenza un curricolo personale di Alioscia, Dimitri, Eugenj, Katiuscia, ecc.. nel quale si possano sviluppare alcune attività curricolari in lingua ucraina e altre nella scuola italiana. Le opzioni sono le più vaste e differenti tra loro. Facciamo alcuni esempi per capirci.
Non c’è dubbio che l’insegnamento della lingua ucraina sia basilare che continui. Qualche ora di ucraino alla settimana sarebbe solo salutare. Sulla storia e geografia forse un insegnamento misto sarebbe interessante, sia per i ragazzi ucraini che italiani, perchè aprirebbe la mente alla scoperta di altri mondi, altre storie, altri luoghi, come de-centramento dal nostro comune solipsismo. Potrebbe invece essere meno significativo l’insegnamento dell’inglese perché più o meno si fa simile sia qui che lì, ma merita eventualmente confrontare le metodologie e gli obiettivi previsti di anno in anno. Per quanto conosco le scuole post-sovietiche penso che l’insegnamento della matematica potrebbe essere affidato alla scuola ucraina, che ha una lunga eccellente tradizione. Il che non vuol dire non mescolare eventualmente i metodi, che potrebbero persino essere utili ai nostri italiani.
Forse le discipline artistiche potrebbero essere meglio affidate alla scuola italiana. Ma non voglio dire di più, perché ogni scuola e ogni classe è diversa, e credo nella creatività e sensibilità degli insegnanti.
- Bagatelle formali
Naturalmente un curricolo binario apre questioni “formali” di cui la nostra scuola italica abbonda per eccessi burocratici spesso inventati. Ricordo a chi mi legge che l’art. 4 del DPR 275/99 Regolamento Autonomia prevede esplicitamente la flessibilità didattica, che l’art. 8 dello stesso DPR prevede il curricolo locale, che sempre l’art. 4 prevede forme particolari di valutazione diverse da scuola a scuola. Cose presenti e legittime ma dimenticate nel noioso tran tran di una scuola che non cambia mai.
Per quanto riguarda la valutazione, ricordiamo che i ragazzi ucraini desiderano diplomarsi in patria, non in Italia, e che la nostra valutazione deve diventare nel tempo un aiuto alla scuola collega quando torneranno a casa, non a fare scale e misure formalistiche. Quindi anche su questo un dialogo con i colleghi ucraini sarebbe quanto mai utile per crescere reciprocamente.
Infine, una questione delicata riguarda la classe di frequenza dei nostri ragazzi, perché in primavera si sono fatti molti pasticci per la fretta e per la non conoscenza della loro scuola. Sempre nella logica della pedagogia del ritorno, dobbiamo tener conto che la loro scuola primaria termina alla classe 4 e che dalla classe 5 alla 9 c’è una lunga scuola media unitaria. Poi ci sono 2/3 anni di scuola superiore. Tutti questi 11/12 anni obbligatori. Quindi i ragazzi ucraini hanno l’obbligo fino a 17/18 anni ed entrano all’università un anno o perfino due prima dei 19 enni italiani. Possiamo farli rallentare solo perchè sono in Italia? Per questo ho suggerito spesso di utilizzare con lucidità quello che le norme italiane sugli studenti stranieri al loro accesso in Italia prevedono: che siano inseriti anche o in una classe prima o in una dopo dei cicli tradizionali italiani. In particolare per quanto conosco delle loro scuole e dei diversi curricoli, penso che sia delicata la situazione dei bambini di classe 5, che in Ukrajna è la prima classe della serednja skola (scuola media) e da noi invece è ancora nella primaria. L’esperienza mi ha fatto proporre spesso un “salto” in avanti di un buon numero dei nostri arrivati in primavera, perché palesemente adeguati ad inserirsi nella nostra prima media. Ogni caso va visto a sé, anche questo è tema da considerare con le loro famiglie.
Lascio qui altre questioni, per esempio quella dei mediatori linguistici se sono o meno necessari (ovviamente dipende), o se sia possibile utilizzare studenti universitari (o insegnanti anch’essi profughi) ucraini per svolgere il curricolo binario qui proposto come adattamento della loro scuola in Italia nel caso non sia possibile un qualche collegamento con la scuola ucraina. Caso che può essere residuale visto l’impegno dei nostri colleghi laggiù.