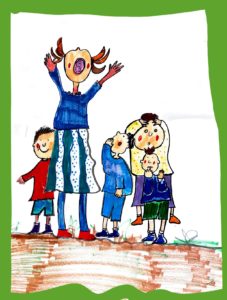Il dibattito sulla valutazione formativa, i richiami alla valorizzazione del merito, l’idea che lo studente migliore è quello che studia sulla carta e solo se autorizzato va sul web, il concetto di apprendimento inteso come forma guidata di conoscenza, i miliardi riversarti sul digitale ma collegati ad una cultura proibizionista sull’uso dei dispositivi di proprietà, il concetto vago di divari territoriali collegato ad azioni di recupero finanziate prima ancora di essere decise, la richiesta di finalizzare il sapere al proprio futuro anche se nessuno sa indicare quale sarà sono tutti elementi dell’attuale contemporaneità che cozzano contro lo scoglio da aggirare: la pedagogia.
In teoria disciplinarismo e pedagogia dovrebbero essere strettamente collegate: se voglio insegnare qualcosa devo avere a che fare con un contenuto e questo contenuto sta per forza dentro una disciplina, che, a sua volta, richiede un determinato metodo per essere insegnata, cioè la pedagogia dovrebbe servire per transitare contenuti (e abilità e competenze che ne seguono) dalla mente di un sapiente alla mente di un non sapiente. Difficilmente vado ad imparare qualcosa che già so, difficilmente qualcuno mi insegna ciò che pensa io sappia o ritenga io debba sapere (i prerequisiti).
Da oltre cento anni la pedagogia è stata considerata una “materia” a sé stante, non necessariamente collegata al suo compito: far apprendere. Infatti, in alcune scuole si studia la pedagogia come una forma di pensiero filosofico minore, interessante, ma con valore più storico-sociale che metodologico. Il problema, però, è un po’ più complesso e va a toccare le discipline così come sono state codificate e così come si sono imposte, le uni a scapito delle altre. Da questo punto di vista Le parole e le cose di Michel Foucault ha dimostrato che le discipline sono strumenti di potere (politico) e che talune hanno preso il sopravvento, mentre altre vivono nell’ombra. In Italia questa evidente stortura ha dato vita al costrutto artificiale delle “classi di concorso”, una struttura di sapere che è diventata struttura di potere con un valore economico molto forte, strettamente collegato ai posti di lavoro che è in grado di farsi riconoscere.