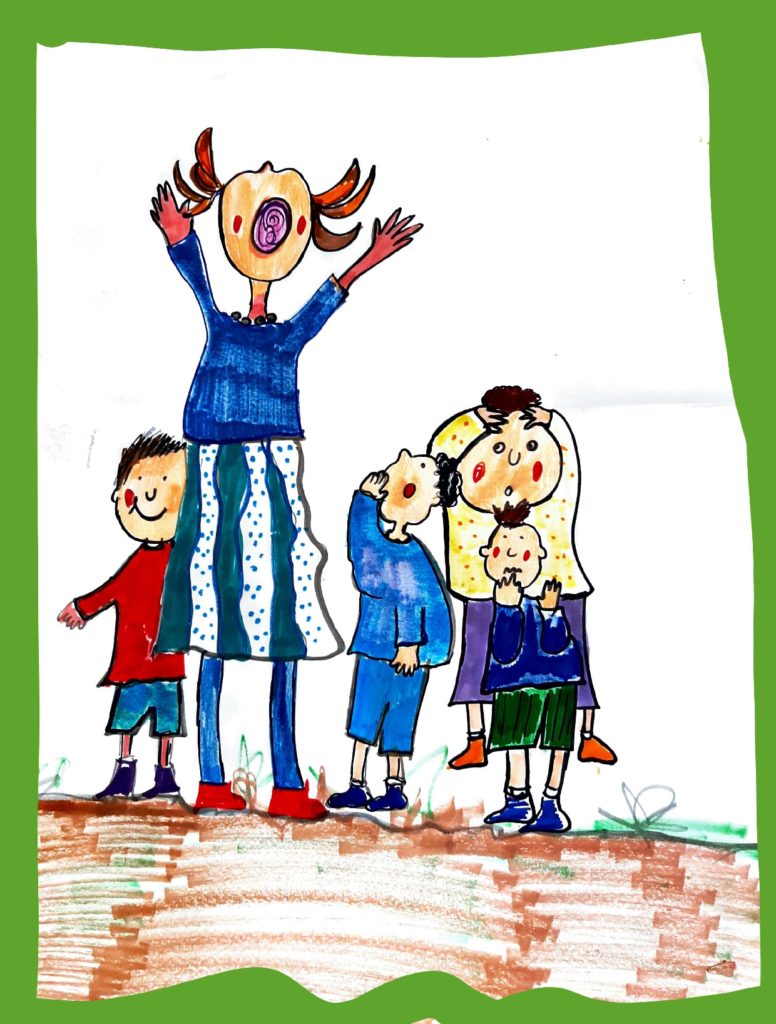 di Gianni Giardiello
Ossia: …. che cosa c’entra il premio al merito per alcuni, per una scuola che deve essere per tutti e per ciascuno.
Intanto cominciamo a chiarire che la nostra Costituzione dice che tutti i cittadini, a prescindere dalle differenti condizioni economiche e sociali e dalle possibili differenze di genere, di razza, di lingua, di credo, ecc. hanno diritto all’istruzione. La legge che stabilisce l’obbligo scolastico per tutti i cittadini dai 6 ai 16 anni di età, per 10 anni, conferma questo primo fondamentale principio costituzionale.
Il diritto all’istruzione deve essere assicurato a tutti i cittadini dal sistema scolastico pubblico nazionale al cui funzionamento presiede il Ministero dell’Istruzione.
Ebbene il primo problema che si pone è che il sistema scolastico cosi come sta funzionando non riesce a soddisfare questo compito primario che la Costituzione gli affida.
Le cifre ufficiali degli abbandoni scolastici e della dispersione scolastica nel segmento dell’obbligo e nel triennio superiore e nell’università lo dimostrano ampiamente.
Questa è la questione più rilevante. Credo che il bisogno primario non sia quello di premiare ulteriormente chi già è bravo o più bravo, quanto piuttosto di contrastare le politiche ancora molto in voga nella scuola pubblica, orientate a “respingere” (bocciare) o “abbandonare” i più deboli e meno attrezzati.
Il secondo problema nasce dalla considerazione, condivisa da molti, che bisogni dare a tutti le stesse opportunità di partenza e poi vinca il migliore. Quasi che il percorso di istruzione fosse simile ad una qualunque gara podistica.
Continua a leggere
di Gianni Giardiello
Ossia: …. che cosa c’entra il premio al merito per alcuni, per una scuola che deve essere per tutti e per ciascuno.
Intanto cominciamo a chiarire che la nostra Costituzione dice che tutti i cittadini, a prescindere dalle differenti condizioni economiche e sociali e dalle possibili differenze di genere, di razza, di lingua, di credo, ecc. hanno diritto all’istruzione. La legge che stabilisce l’obbligo scolastico per tutti i cittadini dai 6 ai 16 anni di età, per 10 anni, conferma questo primo fondamentale principio costituzionale.
Il diritto all’istruzione deve essere assicurato a tutti i cittadini dal sistema scolastico pubblico nazionale al cui funzionamento presiede il Ministero dell’Istruzione.
Ebbene il primo problema che si pone è che il sistema scolastico cosi come sta funzionando non riesce a soddisfare questo compito primario che la Costituzione gli affida.
Le cifre ufficiali degli abbandoni scolastici e della dispersione scolastica nel segmento dell’obbligo e nel triennio superiore e nell’università lo dimostrano ampiamente.
Questa è la questione più rilevante. Credo che il bisogno primario non sia quello di premiare ulteriormente chi già è bravo o più bravo, quanto piuttosto di contrastare le politiche ancora molto in voga nella scuola pubblica, orientate a “respingere” (bocciare) o “abbandonare” i più deboli e meno attrezzati.
Il secondo problema nasce dalla considerazione, condivisa da molti, che bisogni dare a tutti le stesse opportunità di partenza e poi vinca il migliore. Quasi che il percorso di istruzione fosse simile ad una qualunque gara podistica.
Continua a leggere
![]()


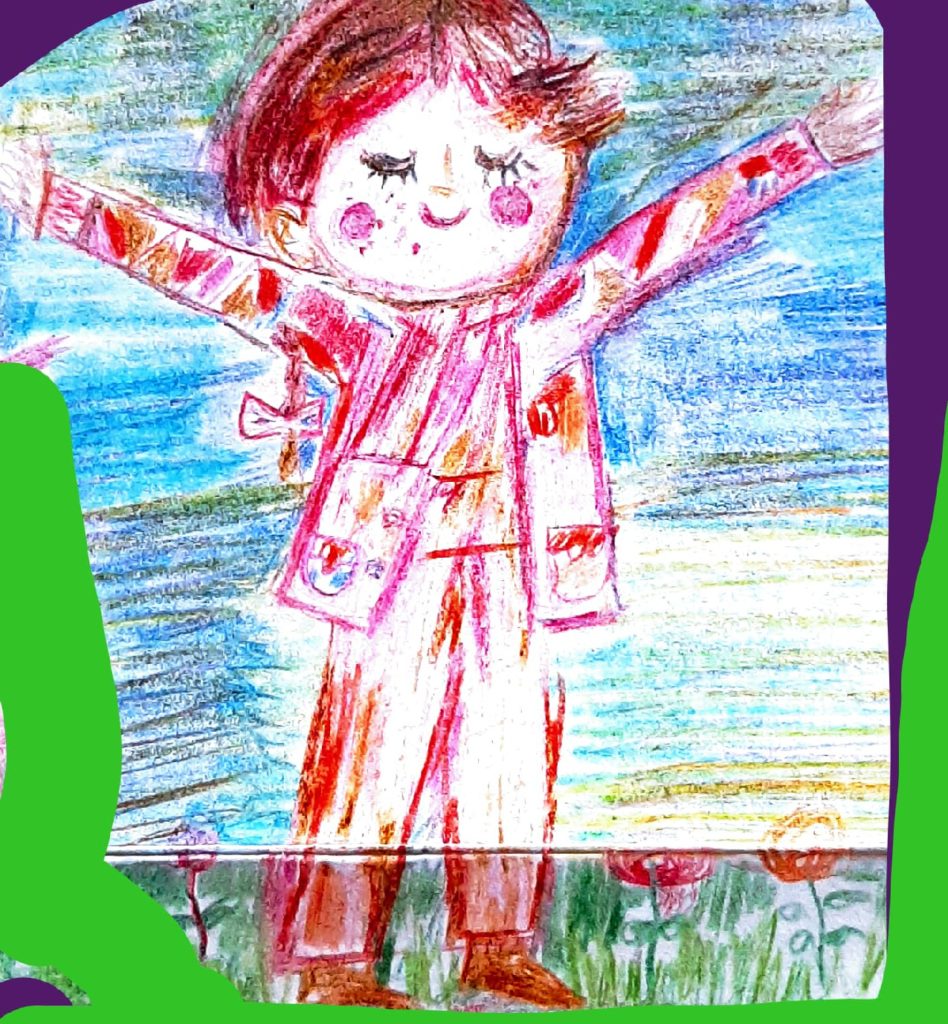 di Mario Maviglia
Chissà quanto costerà alla finanza pubblica (ossia a tutti noi) la nuova denominazione di numerosi Ministeri voluta dal nuovo Governo.
Occorre infatti cambiare l’intestazione delle carte (anche se buona parte della comunicazione oggi avviene on line), i timbri non più in regola, le targhette ai vari uffici. E questo per tutti i Ministeri coinvolti e per le loro diramazioni territoriali.
Gli istituti scolastici, ad esempio, dovranno subito darsi da fare per aggiungere “e del Merito” subito dopo “Ministero dell’Istruzione. E dire che molte di loro avevano da poco finito di aggiornare la vecchia denominazione di “Ministero dell’Istruzione e della Ricerca”. (Ma se fate un giro in rete, ci sono ancora istituzioni scolastiche che utilizzano ancora la vecchia denominazione di “Ministero della Pubblica Istruzione”. Nostalgici…).
Può darsi (ma è alquanto improbabile) che gli inventori del nuovo nome abbiamo pensato all’art. 34 della nostra Costituzione, dove, in riferimento alla scuola aperta a tutti, viene citato il merito (“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”).
Non sappiamo per quale motivo, ma ci sembra che nel caso che stiamo trattando si faccia riferimento ad altri paradigmi valoriali (chiamiamoli così). E allora su questo punto conviene essere sfacciatamente espliciti e politicamente scorretti. Da molti anni in Italia (da sempre?) quando si parla di “merito” significa che si vogliono “sistemare” amici o amici degli amici (o familiari o parenti vicini e lontani o affini, con tutta la filiera genealogica del caso) in posti chiave o comunque ambiti, utilizzando (qui sta l’ingegnosità del paradigma) la parola magica del “merito”. È quello che succede quasi ordinariamente in ambito universitario, o nella nomina dei dirigenti pubblici ex art. 19 commi 5bis e 6 del DLvo 165/2001; o quello che succede quando si confezionano bandi ad hoc per la nomina di esperti/consulenti/formatori presso le pubbliche amministrazioni. Un ulteriore esempio è la cosiddetta fuga di cervelli dall’Italia, ossia quei talenti che non hanno alcuna possibilità di vedere riconosciute le loro competenze in quanto non adeguatamente “imparentati” con lobby o gruppi di potere.
di Mario Maviglia
Chissà quanto costerà alla finanza pubblica (ossia a tutti noi) la nuova denominazione di numerosi Ministeri voluta dal nuovo Governo.
Occorre infatti cambiare l’intestazione delle carte (anche se buona parte della comunicazione oggi avviene on line), i timbri non più in regola, le targhette ai vari uffici. E questo per tutti i Ministeri coinvolti e per le loro diramazioni territoriali.
Gli istituti scolastici, ad esempio, dovranno subito darsi da fare per aggiungere “e del Merito” subito dopo “Ministero dell’Istruzione. E dire che molte di loro avevano da poco finito di aggiornare la vecchia denominazione di “Ministero dell’Istruzione e della Ricerca”. (Ma se fate un giro in rete, ci sono ancora istituzioni scolastiche che utilizzano ancora la vecchia denominazione di “Ministero della Pubblica Istruzione”. Nostalgici…).
Può darsi (ma è alquanto improbabile) che gli inventori del nuovo nome abbiamo pensato all’art. 34 della nostra Costituzione, dove, in riferimento alla scuola aperta a tutti, viene citato il merito (“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”).
Non sappiamo per quale motivo, ma ci sembra che nel caso che stiamo trattando si faccia riferimento ad altri paradigmi valoriali (chiamiamoli così). E allora su questo punto conviene essere sfacciatamente espliciti e politicamente scorretti. Da molti anni in Italia (da sempre?) quando si parla di “merito” significa che si vogliono “sistemare” amici o amici degli amici (o familiari o parenti vicini e lontani o affini, con tutta la filiera genealogica del caso) in posti chiave o comunque ambiti, utilizzando (qui sta l’ingegnosità del paradigma) la parola magica del “merito”. È quello che succede quasi ordinariamente in ambito universitario, o nella nomina dei dirigenti pubblici ex art. 19 commi 5bis e 6 del DLvo 165/2001; o quello che succede quando si confezionano bandi ad hoc per la nomina di esperti/consulenti/formatori presso le pubbliche amministrazioni. Un ulteriore esempio è la cosiddetta fuga di cervelli dall’Italia, ossia quei talenti che non hanno alcuna possibilità di vedere riconosciute le loro competenze in quanto non adeguatamente “imparentati” con lobby o gruppi di potere.



