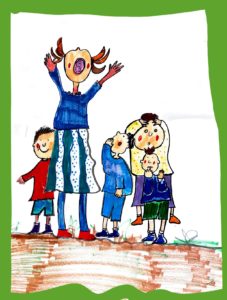di Antonio Valentino
di Antonio Valentino
Alcune ragioni per parlarne.
La percezione diffusa, mi sembra, è che la nostra scuola sia stata poco coinvolta dal dibattito e da esperienze legati alla Comunità di Pratica (d’ora in avanti: CdP). Prima della pandemia è stato oggetto di interesse soprattutto nei convegni e nelle sedi universitarie dove si coltivano questioni riguardanti le teorie dell’apprendimento. Non sono mancate tesi di laurea e pubblicazioni [1] – molto più numerose di quanto si possa credere – che hanno approfondito l’argomento proponendo anche esperienze maturate in Italia[2]. Però la loro risonanza era e continua ad essere ancora modesta.
Nello stesso sito dell’Indire, alla voce ‘Comunità di pratica’ , vengono riportate poco più di un centinaio di iniziative e studi, che però si riferiscono, nella stragrande maggioranza dei casi, a progetti italiani ed europei di School Improvement (progetti di miglioramento delle scuole), che solo tangenzialmente toccano questioni riconducibili specificamente alle CdP e alle ricerche ed elaborazioni al centro di queste riflessioni.
Però, a ben vedere, non poche, nè di poco conto sono le ragioni che spingono anche e soprattutto le persone di scuola ad avvicinarsi a tali questioni, in quanto volte a capire più e meglio la natura dell’apprendimento come fenomeno sociale collettivo e a coltivare quindi luoghi e strategie che ne permettono lo sviluppo.
Recuperare la dimensione collettiva dell’apprendere e la sua centralità nella pratica scolastica.
In primo luogo non è ancora adeguatamente diffusa – mi sembra – la consapevolezza
- che i singoli apprendimenti acquisiti sul lavoro, se non sono partecipati e condivisi, raramente diventano patrimonio culturale e didattico dell’intera comunità scolastica in cui si sono sviluppati; e difficilmente quindi ne possono favorire sviluppi e miglioramenti;
- che l’efficacia dell’azione educativa è garantita soprattutto dalla dimensione collettiva dell’insegnare che si concretizza negli spazi istituzionali e non (Consigli, Dipartimenti, aggregazioni diverse), vissuti come comunità di intenti e di pratiche condivise); e che raramente – tale efficacia – è invece assicurata dal singolo docente.
A queste consapevolezze si lega l’idea che appropriarsi opportunamente del costrutto di Comunità di pratica rappresenti / possa rappresentare per le nostre scuole non solo uno stimolo ad approfondire e aggiornarne la conoscenza sui processi di apprendimento – questione comunque centrale – ma anche un’occasione per attrezzarsi a superare la cultura dell’isolamento professionale e dell’autoreferenzialità ancora diffusa nell’insegnamento, e a promuovere e mettere al centro pratiche di cooperazione e coordinamento.
L’apprendimento organizzativo in primo piano.
L’apprendimento organizzativo è concetto centrale nelle ricerche e negli studi sulla Comunità di pratica. Denominazione coniata da Etienne Wenger e Jean Lave, due studiosi dell’apprendimento (filone di ricerca di matrice sociologica) che agli inizi degli anni ’90 cominciano a pensarlo non più come una semplice acquisizione mnemonica di nozioni astratte e formali proposte dall’esterno (l’idea tradizionale), ma come un processo di natura attiva, caratterizzato dalla partecipazione e dal coinvolgimento dell’individuo all’interno di un determinato contesto d’azione.
E lo ripensano sulla base di ricerche sulle organizzazioni e di studi sulle teorie dell’apprendimento nei vari ambiti disciplinari e su una varietà di altre teorie (della pratica, del significato, dell’esperienza situata, della soggettività …) – che hanno loro permesso di elaborare sulla base di una interpretazione multidimensionale dei processi di apprendimento, anche apprezzate elaborazioni per una efficace riprogettazione delle organizzazioni orientate alla conoscenza[3].
La comunità di pratica è il campo tematico a cui i due ricercatori dedicano più energie all’interno di questi loro interessi e studi. Il loro senso e fondamento rinvia ai seguenti due aspetti dei processi di apprendimento in parte accennati che vale la pena di puntualizzare:
- L’apprendimento, non più come esperienza esclusivamente individuale e mentale, ma come fenomeno sociale e collettivo, e quindi come inscindibilmente collegato a fattori come il clima, le relazioni e le interazioni dei contesti in cui si sviluppano. L’approdo delle ricerche su tale fenomeno sono le teorie dell’“apprendimento situato” e del “practice-based theorizing”, che enfatizzano appunto la dimensione situata ed esperienziale dell’apprendere, visto come processo costruttivo (nel senso che costruisce conoscenza attraverso la sperimentazione di pratiche e comportamenti condivisi), ma anche sociale e contestualizzato.
- L’apprendimento soprattutto come risultato delle pratiche, in risposta a bisogni e attese dei singoli e dei gruppi e delle organizzazioni in cui questi bisogni emergono (apprendimento situato[4]); e quindi elemento motore nella formazione di una conoscenza collettiva, oltre che risorsa in grado di arricchire il patrimonio di know-how dei contesti in cui in cui esso si costruisce[5].
Di questa riscoperta che recupera prime elaborazioni di Vygotskij e Schön, soprattutto Wenger ha cercato applicazioni e conferme inizialmente nelle organizzazioni di tipo aziendale e successivamente, nelle amministrazioni pubbliche e in ambiti altri (come, ad esempio, l’associazionismo e la formazione).
Da richiamare qui soprattutto il concetto di apprendimento organizzativo che Wenger e Lave mutuano da Argyris e Schön e che sviluppano attraverso un approccio che guarda a chi opera nelle organizzazioni non soltanto come soggetto di azione, ma anche come soggetto di apprendimento ‘organizzativo’; di un apprendimento, cioè, in grado di trasformare il modo di vedere la realtà del contesto organizzativo e di individuare e intervenire sulle sue criticità con un coinvolgimento collettivo.
Il modello[6] wengeriano della CdP come promettente ipotesi di lavoro
Entrando nello specifico del modello di CdP – come proposto in termini definitivi da Wenger, soprattutto nelle pubblicazioni del 1998 e del 2002[7] – vanno qui richiamati in primo luogo i suoi cardini: la comunità e la pratica. A cui va aggiunto l’elemento motore – e quindi prioritario e fondamentale – che spinge un insieme di persone a aggregarsi: il campo tematico (termine originario: domain) – traducibile anche come l’interesse in comune tra soggetti – che spinge a sentirsi e costituirsi come comunità.
Le parole chiave
Comunità, il primo elemento che connota le CdP, è qui nozione che va oltre l’idea di “un insieme di persone che fanno lo stesso lavoro e che operano in condizioni simili” (stesso contesto e identiche attività professionali). Per caratterizzarsi come “luogo di relazione (cooperazione, scambio, confronto), acquisendo una sua identità specifica legata alla capacità di sviluppare best practise” (I. Summa[8] ). È con questa connotazione che la comunità diventa comunità di pratica e di apprendimento.
Il peso specifico dell’dea di comunità nel concetto di CdP non risulta però particolarmente enfatizzato da Wenger e colleghi ; anche se è innegabile la sua forza evocativa (al pari della sua ambiguità)[9].
Il secondo elemento cardine: Pratica viene rappresentato essenzialmente come risultato di un processo potenzialmente arricchente, perché basato soprattutto su quattro fondamentali modalità operative: interazione, cooperazione, negoziazione e riflessività[10]. Comunque “non è solo il fare in sé e per sé”, ma è un ‘fare’ situato, negoziato e condiviso, diverso del tutto o in parte dal ’fare’ precedente. E comprende intese operative e cornici di significato, che sono esse stesse occasioni di apprendimento e nuova conoscenza.
Pratica quindi come espressione di cultura professionale e cultura tout court. E anche come risultato – in termini di know how – della sedimentazione del lavoro di riflessione e negoziazione del gruppo sulle esperienze maturate nello stesso ambiente o in ambienti simili.
Il terzo elemento alla base del modello delle CdP può essere ulteriormente esplicitato come l’interesse che spinge persone animate dalla passione per lo stesso tema specifico (il Campo Tematico – CT –) ad aggregarsi in una logica di reciprocità e condivisione. Il CT non è comunque un’area astratta di interesse, ma ruota sempre intorno questioni e problemi chiave[11].
Con riferimento a questi tre elementi cardine, le CdP si configurano pertanto come ambienti di apprendimento in cui dei professionisti decidono liberamente di interagire per migliorare la propria pratica professionale attraverso soprattutto la condivisione di esperienze e la individuazione delle pratiche più efficaci per i destinatari delle stesse. Particolarmente eloquente la definizione che ne dà Wenger in Apprendimento situato (2006): “…un’aggregazione informale di attori che, nelle organizzazioni, si costituiscono spontaneamente attorno a pratiche di lavoro comuni sviluppando solidarietà organizzativa sui problemi, condividendo scopi, saperi pratici, significati, linguaggi”[12].
La svolta: si cambia pagina
Il tutto – assicurano gli Autori in più passaggi del testo, nonostante la evidente forzatura – comunque dentro una cornice in cui flessibilità e modificabilità restano sempre principi basici, tesi a garantire l’equilibrio tra la sfera più libera e ‘autonoma’ delle CdP e quella formale dell’organizzazione (il suo contesto organizzativo di lavoro).
Con questa svolta, l’attenzione di Wenger e colleghi, dal campo della teoria dell’apprendimento si sposta su quella della progettazione ‘evolutiva’ delle CdP, e quindi sul ‘pianificare e lanciare’ CdP prevedendone strumenti, ruoli, risorse, partnership per contrastare i rischi della decadenza della sua vitalità e della sua scomparsa[14].
Le CdP continuano a collocarsi / si collocano ancora al di fuori dell’organigramma delle organizzazioni; queste però, nella nuova prospettiva, diventano soggetti in qualche modo cruciali per la ‘coltivazione’ e il supporto alle CdP. Questa previsione – che è anche una indicazione di lavoro – di un ruolo di partnership delle organizzazioni nella vita delle CdP, viene descritta come operazione promettente per entrambe. Volta a contrastare i rischi di cui sopra per le CdP, ma promettente anche per le organizzazioni che comincia a guardare in modo più consapevole alle CdP come possibile risorsa nella prospettiva del rinnovamento e dello sviluppo dei loro saperi organizzativi: condizione non ultima per vincere le sfide inedite del nostro tempo.
Anche sotto questo aspetto, la svolta prospetta discorsi di un certo interesse anche per il mondo della scuola.
Le prospettive per le scuole e il ruolo del DS in quattro punti
Si tratta, a questo punto, di capire in termini più compiuti quali potrebbero essere gli stimoli e l’interesse che queste elaborazioni possono offrire al nostro sistema scolastico:
uno, per contrastare le criticità legate alla sua cultura organizzativa e alla cultura professionale ancora egemone (sostanzialmente caratterizzata da individualismi e autoreferenzialità e scarsa responsabilità rispetto agli esiti);
due, per far crescere una cultura della formazione in itinere del personale fondata sulla dimensione ‘situata’ degli apprendimenti (da trasferire anche nel lavoro d’aula) e orientata alla promozione di comportamenti organizzativi (pratiche) decisivi per una didattica efficace (cooperazione, interazione, mutuo aiuto, coordinamento, negoziazione del senso);
tre, per alimentare una cultura associativa (delle associazioni professionali e scolastiche in generale) più mirata sul senso delle specifiche ‘mission’ e su pratiche coerenti e finalizzate;
quattro, per verificare la possibilità di ripensare le articolazioni collegiali della funzione docente (consigli, dipartimenti, gruppi di ricerca, commissioni di lavoro…) così da rendere possibile una contaminazione delle stesse con orientamenti, logiche, strumenti propri delle CdP.
Qui si cercherà di riprendere schematicamente, per economia di discorso, solo i punti 2 e 4.
Cominciamo dall’ultimo che potrebbe riformularsi così: le articolazioni collegiali tendono a strutturarsi e a viversi come CdP, sulla base di una lettura non restrittiva dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui agli articoli 6 e 12 del Regolamento (DPR 275/’99).
Si tratta concretamente di una prima approssimazione ad una ipotesi di lavoro che si pensa compatibile con lo sviluppo di CdP come emerge dagli studi indicati.
Abbiamo già visto che le CdP tendono generalmente ad attivarsi su base volontaria, eccetera; ma le pur diverse modalità di guardare alle CdP nelle fasi pre e post svolta, conservano, in entrambi i casi, un punto cardine così riassumibile: è la specificità delle situazioni di riferimento e dei contesti organizzativi che determina previsione e sviluppo dei processi più adeguati e agibili.
Nell’ipotesi che qui si prospetta, è la promozione e lo sviluppo degli apprendimenti ai diversi livelli (degli allievi, dei docenti e del DS, del personale ATA) che diventa la priorità in comune, il vero ‘campo tematico’ di ciascun organo collegiale. Che può eventualmente ridefinirlo autonomamente sulla base di propri interessi e bisogni.
Comunità di pratica si diventa comunque soprattutto attraverso a. la pratica maturata e messa in opera dentro ciascuna delle articolazioni collegiali (e di esse propria); b. la competenza professionale che si alimenta di conoscenza organizzativa nell’accezione prima precisata.
Garantire l’equilibrio tra sfera formale (la scuola come organizzazione) e quella più libera e ‘autonoma’ (le diverse aggregazioni previste o comunque attive negli Istituti scolastici), può diventare allora una strategia organizzativa possibile e promettente, a condizione – fondamentale – che le Istituzioni scolastiche si vivano come CdP quanto a modalità operative e relazionali e a pratiche condivise; dentro comunque spazi regolati dai riferimenti ordinamentali alla ragione sociale dell’essere Scuola.
In questa ipotesi diventa rilevante la figura del DS in quanto rappresentante della scuola/organizzazione, in base a come gioca il suo ruolo e al profilo che intende privilegiare.
Ma qui il discorso passa anche attraverso le figure di funzionamento organizzativo e didattico dell’istituto; e tra queste, in primo luogo, quelle di coordinamento, di collaborazione e di presidio delle aree più fragili e più strategiche nella vita della scuola. E richiede pertanto strategie adeguate che spostano ancora l’attenzione sul DS (e, prima ancora, su aggiornamenti contrattuali appropriati).
Tra le strategie possibili, quelle più funzionali al “coltivare CdP” mi sembrano quelle emerse recentemente in un gruppo di lavoro interregionale dell’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, in preparazione della sua prossima Conferenza Nazionale[15]; se ne richiamano qui i tratti più significativi opportunamente ripensati con riferimento alla CdP:
- assicurare una maggiore vicinanza al lavoro dei suoi insegnanti, anche per prevenire eventuali difficoltà e problemi professionali e facilitare il loro coinvolgimento nei lavori delle articolazioni collegiali e nel loro funzionamento anche come CdP;
- garantire supporto e vicinanza alle figure professionali impegnate nella conduzione dei gruppi gestiti come comunità, attraverso appositi momenti strutturati e programmati o impegnati in compiti di collaborazione e di presidio delle aree più bisognose di attenzione;
- favorire, anche in base a quanto previsto dal ‘modello’ wengeriano, un funzionamento della scuola come memoria collettiva da coltivare e valorizzare per evitare che vada dispersa (le esperienze migliori dei gruppi di insegnanti con una marcia in più, ‘passati’ dalla scuola) e come luogo in cui si raccoglie e si classifica – e si ‘deposita’ -, con criteri che facilitino la ricerca e la fruizione di quanto può risultare didatticamente stimolante per migliorarsi come singolo e come gruppo. Impresa certamente ardua, ma comunque promettente;
- favorire attraverso il Piano di formazione di Istituto (PFI) la realizzazione di momenti formativi nella logica e nello spirito dell’apprendimento ‘situato’ che riprendiamo subito dopo.
Per ultima, ma comunque centrale, la formazione.
Concludo sul punto 2. con alcune annotazioni di contorno sulla “formazione” in servizio, che rimane comunque un ‘campo tematico’ per eccellenza anche delle associazioni professionali che organizzano il personale scolastico (e non solo)[16].
Qui mi preme solo richiamare che le questioni relative a quella in servizio trovano nella teoria dell’apprendimento situato sollecitazioni utili perchè riportano in primo piano l’importanza
- della condivisione delle difficoltà e delle esperienze, delle pratiche e dei loro esiti, a partire dagli scambi di esperienze e conoscenze ‘indagate’ a più livelli e tradotte in schemi operativi ‘sensati’ e negoziati
- dei luoghi in cui essa matura con maggiore cognizione di causa: lo specifico contesto organizzativo (la scuola di appartenenza ed eventualmente quelle di ambito) e le sue specifiche articolazioni (dipartimenti, classi parallele o aggregazioni informali proprie delle CdP), dove è più facile sviluppare apprendimenti funzionali all’ambiente in cui si opera; luoghi da vivere come spazi di più libera ricerca, esplorazione di nuove pratiche che, opportunamente socializzate, arricchiscono il patrimonio di esperienze a disposizione della collettività[17].
NOTE
[1] Apprezzabile quella di Patrizia di Giovanni che riserva nella sua tesi (2006) Istituzioni del cambiamento e cambiamento delle istituzioni, un lungo capitolo “Le “comunità di pratica” come setting di apprendimento collettivo”, in https://www.tesionline.it/tesi/brano/Le-“comunità-di-pratica”-come-setting-di-apprendimento-collettivo
[2] Lipari D, P. Valentini P., Comunità di pratica in pratica, Edizioni Palinsesto 2016; Tommasini M., L’apprendimento organizzativo nella scuola dell’Autonomia, in L. Benadusi, R. Serpieri (a cura di), Organizzare la scuola dell’autonomia, Carocci, dic 2000 pp. 224 – 230; Fabbri L. (2007). Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Carocci: Roma; Alessandrini G. (a cura di) (2007). Comunità di pratica e società della conoscenza. Roma: Carocci; Gherardi, S. (1998). “Apprendimento come partecipazione ad una comunità di pratiche”. In «Scuola democratica», v. 1, 2, pp. 247-264.
[3] Lave, J & Wenger E, Situated Learning: Legitimate Peripherical Participation, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, tradotto in Italia col titolo L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti di apprendimento. Erickson, 2006.
[4] Non assimilabile comunque all’apprendimento al lavoro e, in particolare, alle forme storiche di apprendistato, come risulta dal testo sopra citato.
[5] Sull’importanza e il valore dell’imparare osservando e dei contesti in cui questo avviene, le botteghe artigiane del Rinascimento – che normalmente ruotavano intorno ad un artista noto, rappresentano a tutt’oggi un modello organizzativo sul quale, per alcuni aspetti di fondo, andrebbe ripresa la discussione (da noi aperta, almeno due decenni fa da Clotilde Pontecorvo). In queste esperienze infatti è possibile vedere in nuce il nucleo concettuale alla base delle teorie moderne dell’Apprendimento e dell’Organizzazione su cui ha lavorato Wenger. Delle quali sappiamo essere capitoli importanti per il mondo della scuola Learning by Doing (John Dewey), Learning Organization (Peter Senge ….), Cooperative Learning (che è soprattutto una strategia didattica alla cui definizione contribuirono in misura importante David e Roger Johnson), la ‘Pedagogia del fare’ di Maria Montessori.
[6] Modello qui non indica, coerentemente con quanto è proprio delle teorie che fanno riferimenti a esperienze ‘situate’, qualcosa da imitare, fatta di canoni definiti che si fanno norma operativa; ma qualcosa a cui ispirarsi, da assumere a riferimento per ‘fare meglio’ o ‘diverso’.
[7] E. Wenger, Communities of practice – Learning, meaning, and identity, Cambridge University Press. 1998; E. Wenger, R. MCDermott, & W. M. Snyder, Cultivating Communities of Practice, HBS Press 2002. Rispettivamente pubblicati in Italia coi titoli di ‘Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità’ (Franco Angeli editore, 2006) e ‘Coltivare Comunità di pratica. Prospettive ed esperienze di gestione della conoscenza’ (GueriniNEXT editore, 2007).
[8] I. Summa, Se il docente fa “comunità professionale, in Rivista dell’istruzione, n. 6 – 2013. V. anche al riguardo: A. Valentino, Gli insegnanti nella organizzazione della scuola, pp. 63-82 (Cap. 5 “Comunità di pratiche e leadership diffusa”), Edizioni Conoscenza 2015.
[9] Interessanti le annotazioni di Lipari-Valentini, cit. sul punto. Si chiarisce infatti che certamente l’idea di Comunità porta con sé suggestioni che possono funzionare come “potente veicolo di proselitismo per il bisogno di trovare forme elementari di solidarietà in un mondo (organizzativo) sempre più atomizzato, frammentato, anonimo e chiuso” (Cfr C. Bauman, La grande voglia, 2001)”. Però affermano che è difficile cogliere nell’elaborazione complessiva di Wenger e colleghi una qualche tentazione di indulgere a forme di retorica comunitarista (mai esplicitata ma sempre presente come tratto essenziale della maggior parte delle proposte circolanti), perché consapevoli che dietro di esse “si nascondono ipotesi di intervento che incidono poco sulle dinamiche reali e sulle concrete relazioni organizzative”, pg. 30.
[10] Sulla riflessività, si recuperano, come è evidente, gli studi di Schön che sin dagli anni 70 del secolo scorso ne aveva fatto oggetto importante della sua elaborazione nell’ambito delle teorie dell’apprendimento. Con Wenger gli apprendimenti e le pratiche diventano significativi quando si fanno oggetto di riflessione; altrimenti sono come “gocce d’acqua che scivolano su un vetro, senza lasciare traccia alcuna”.
[11] V. home page del sito ewenger.it (interessante) si dà rilievo soprattutto ai seguenti ambiti tematici: progettare organizzazioni orientate alla conoscenza, creare sistemi di apprendimento tra organizzazioni, la formazione permanente, ripensare il ruolo delle associazioni professionali.
[12] in E. Wenger, Apprendimento situato (2006)
[14] A queste voci corrispondono altrettanti paragrafi nel testo della svolta.
[15] V. in http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/5271/documento-dirigenza-e-organizzazione-scolastica-2.pdf
[16] Il ripensamento del ruolo delle associazioni professionali è un campo tematico a cui Wenger guarda con particolare attenzione (v. nota 12)
[17] Si segnala al riguardo, e più in generale sulla CdP, il recente contributo di M. Giacci, Formarsi nelle comunità di pratica, www.scuolaoggi.org (giugno 2021) che riprende anche il ‘modello’ per valorizzare le CdP come contesto di formazione e autoformazione di Lipari – Valentini, cit..
 di Antonella Mongiardo e Ferdinando Rotolo
di Antonella Mongiardo e Ferdinando Rotolo