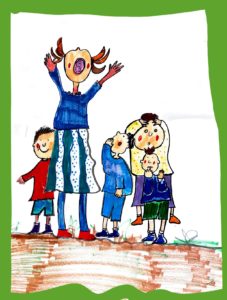di Aristarco Ammazzacaffè
di Aristarco Ammazzacaffè
“Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche …”.
È il titolo del ddl che la Camera ha approvato l’11 gennaio scorso e che ora tocca al Senato esaminare e approvare, se ne ha l’animo. I parlamentari firmatari, poco più di una decina (per la precisione, una Dozzina, con l’iniziale maiuscola per deferenza) appartengono ai diversi schieramenti politici del Parlamento, nessuno escluso. (Almeno 4 però di sola Forza Italia: con tutti nomi arcinoti agli ‘scolastici’. Gli altri parlamentari presentatori della proposta, con l’eccezione di un paio, sono associabili al mondo della scuola più o meno come la catalogna alla pasta al forno. Per dire.
Comunque un disegno di legge (ddl) sulle competenze non cognitive, se ci pensate, era proprio quello che ci voleva e soprattutto in questo periodo. Quando uno dice, le mancanze! E le attese!
Tranquilli, però. Gli articoli sono solo cinque e quasi tutti brevi. E non pochi passaggi, come accade spesso: acqua fresca e mica fresca.
Partiamo comunque fiduciosi.
L’articolo 1. L’inizio – molta nebbia padana anni ’60 (semplice annotazione d’ambiente; non critica) – dà per scontato che l’oggetto (le competenze non cognitive) sia chiaro a tutti.
‘Competenze non cognitive’? Cioè? Una declinazione esotica di competenza? Una proposta nuova e innovativa per la scuola che recupera il passato? Un’idea dirompente che apre al futuro, da parte di parlamentari attrezzati in teorie della conoscenza, che sfidano elaborazioni che vanno per la maggiore?
Perché no? Perché sì? Mah!
L’articolo si intitola opportunamente alle finalità del ddl.
Sulla prima delle quali: promuovere la cultura della competenza, si preferisce però passarci sopra, un po’ per le ragioni di prima (un discreto esempio di acqua fresca, ma di quella buona), un po’ per la curiosità di scoprire, il più presto possibile, come si sbroglia il ‘disegno’. E infatti nelle righe seguenti, già con la finalità – integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali – i parlamentari proponenti un qualche segnale sembrano lanciarlo: le competenze dei saperi disciplinari addirittura declassate a semplici abilità.
– Ma come si permettono?
Però siamo in democrazia e la cosa non può destare scandalo.
Comunque, una scivolata che uno non se l’aspetta.
Con la terza finalità – migliorare il successo formativo prevenendo (1) analfabetismi funzionali, (2) povertà educativa e (3) dispersione scolastica – siamo già veramente, sembra di capire, al top della visionarietà pedagogica, proprio. E questo grazie alle competenze specificamente non cognitive, chiamate a ‘migliorare’ il famoso successo formativo; abbattendo così in un sol colpo, come neanche Sandokan Sandokàan, le tre piaghe del nostro sistema di istruzione. Complimenti!
Dopo la prima terna di finalità non si precisa ancora di che si tratta, ma si specifica dove questa tipologia di competenze va individuata. Il chiarimento che ne segue è netto: nelle attività educative e didattiche delle scuole. Non all’osteria, ma neanche all’oratorio o al campo di calcetto del quartiere. Solo nella attività citate. Indubbiamente c’è occhio nella proposta.
Nel comma seguente però un primo succoso anticipo: la sperimentazione. Ci sarà una sperimentazione! Ma se ne parlerà però solo nell’articolo 3. Pazienza. Se ne preannunciano qui comunque Linee guida che lasciano presagire cose grosse: mica bucce di pomodoro per la salsa, per dire.
Infatti queste Linee guida si individuano – preparatevi! – nientemeno che in specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi specifici di apprendimento.
Esclamazioni tutt’intorno: – Ma veramente! Quando il banale girotondo diventa metafora di cose grosse.
Ma passiamo direttamente all’articolo 3, dopo aver solo ricordato – per compiutezza di quadro – che il 2 è dedicato alla Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
Articolo 3: finalmente si riprende il filo interrotto della Sperimentazione; che, come per la Formazione e per le Finalità degli articoli precedenti, ci ripete premuroso – nel caso ci si fosse distratti – che tutto quanto è previsto è in funzione – di che, secondo voi? – dello “sviluppo di competenze non cognitive”. Senza tale sviluppo – si aggiunge sentenziosamente – non c’è “recupero motivazionale degli studenti”; né – e qui il colpo d’ali – l’abbattimento della dispersione scolastica: sia quella esplicita, sia quella implicita.
Ammonimento chiaro con piglio intransigente. Così si fa.
La sfida lanciata alla nostra scuola diventa così: individuare buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di in segnamento che favoriscano – suspence – lo sviluppo delle competenze non cognitive, …. . Sfida difficilissima, come si vede. Praticamente, come inseguire lucciole in una notte tempestosa.
Ma, accettando le sfide, si vince: è il monito implicito che condividiamo. Penso all’unanimità.
Qui si permetta però un piccolo interrogativo: – ma prima di lanciare la sfida perché non specificare l’oggetto e chiarirne termini e portata? Nella stessa presentazione del ddl si parla delle competenze non cognitive in termini di “abilità non direttamente legate al processo di informazione” e di “caratteristiche individuali legate agli ambiti emotivi, psicosociali …” (che ci possono certo stare, per conto loro però), ma anche di “posture” (le posture no! La posture no, non le avevo considerate) come ‘l’amicalità [oddio!], la coscienziosità (anche? Qui si esagera!), la stabilità emotiva e l’apertura mentale’(E sì, tombola) . Tutte cose giuste, per carità. Ma, 1: cosa c’entrano con le competenze per come le abbiamo intese finora, anche sulla base delle Raccomandazioni dell’UE (del 2006 e 2018) sulla questione? 2. Qual è il loro senso in un ddl, trattandosi di abilità, caratteristiche e posture il cui sviluppo riguarda soprattutto le metodologie di insegnamento e, in modo particolare, la qualità della relazione educativa? 3. È poi del tutto vero che tali caratteristiche e posture appartengono al ‘non cognitivo’? Ricerche e studi accreditati sulle teorie della conoscenza e dell’apprendimento (dell’ultimo mezzo secolo almeno), dicono tutt’altro, credo.
Ma evidentemente la Dozzina (veri Capitani Coraggiosi, mi sembra) ha voluto giocare in proprio, a prescindere. Per passare alla storia? Per ambizioni personali? Orgoglio? Cosa possiamo saperne? Comunque è del tutto legittimo, ovvio, e forse anche ammirevole questa loro interessamento a fin di bene. Così.
Ma alla fine, questo ddl – potrebbe dire chi ne avesse voglia – è un castello costruito sulla sabbia?
Piano, per favore, con le deduzioni frettolose. Il discorso non sembra chiudersi qui. Che, se si opacizza (mamma! Che ho detto) l’oggetto del ddl, il suo senso – del ddl, intendo – è ancora tutto da scoprire, Whatson.
Nei commi finali dell’articolo infatti – un vero e fantastico labirinto concettuale -, si vanno a individuare e prospettare, come un miracoloso, intrecciato filo di Arianna, ben tre risorse / chiave che permettono di uscirne sensatamente (arrampicandosi comunque e felicemente sui vetri). Che sono, messe in ordine: uno, le competenze trasversali; due, l’orientamento; tre i progetti di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato.
Idea lampo: Ma vuoi vedere che in questa terna c’è la vera ragione del ddl n. 2493, trasmesso al Senato l’11 Gennaio 2022?
Che non riguarda certo l’individuazione delle competenze trasversali e l’orientamento, che nelle nostre scuole non solo sono state individuate da mo’, ma si si praticano anche (probabilmente è sul ‘come’ che in qualche caso casca l’asino).
E se la ragione del ddl – domanda – fosse proprio la decisione di riconoscere a soggetti privati, per quanto benemeriti – e quelli citati certamente lo sono – di essere parte in causa in progetti di partenariato? Decisione messa lì alla chetichella, quasi en passant; probabilmente anche per dare un segnale – sempre apprezzabile – di sobrietà e velocità comunicativa. Perché no? Pensiamoci. Però è che anche verosimile che sia stata messa lì con nonchalance “per vedere l’effetto che fa”. No? O sì? Mah.
Mini-dialogo tra il Relatore Autorevole della Dozzina (R.A.) e una Dirigente Scolastica Scettica (D.S.), informata dei fatti. Colto a volo, appena licenziato il ddl.
R.A. – BEL LAVORO. Credo che l’operazione sia ben congegnata e il riferimento ai progetti di partenariato, quasi non si nota. Non era il caso di dargli una evidenza che non devono avere.
D.S. – Beh, messi in quella selva di parole, è un’impresa accorgersene. Immagino comunque che, in questi progetti di partenariato, il ruolo strategico sarà delle scuole.
R.A. – E perché? Non è detto. Generalmente tale ruolo è dei partner privati. Ma gli obiettivi sono comunque prerogativa assoluta dei singoli Istituti scolastici.
D:S. – Veramente? Una conquista allora! E il caffè chi lo offre?
R.A. – Non mettiamo il carro davanti ai buoi! Aspettiamo la discussione al Senato, dove il testo è già stato inviato con sollecitudine.
D.S. – Veri strateghi della comunicazione. Fare presto e fare bene, senza inutili allarmismi, vero? Alla fine ne verrà fuori un pasticcio, vedrai.
R.A. Ma no. Se ne uscirà bene. ‘O famo strano’, e ‘Vedrai che passerà’. Ci aiuteranno Verdone e la Vanoni. E poi, diciamocela tutta e seriamente: calma con questa Autonomia scolastica! Si vorrà mica negare il contributo autonomo e imprescindibile del territorio?
D.S. (con sorriso da interpretare): Figuriamoci! Pensa: me ne stavo quasi dimenticando..