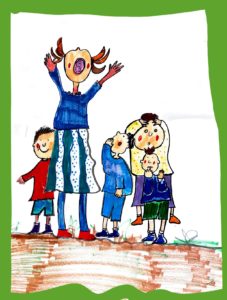di Marco Guastavigna
Sul pasticciaccio brutto brutto brutto del “docente esperto” si sono già espressi in molti e in modo sistematico, a partire da considerazioni complessive sull’organizzazione del cosiddetto “mondo della scuola”.
Io sono invece un po’ confuso e mi limiterò a proporre quanto mi si è affacciato alla mente in questi giorni, convinto (illuso?) di poter comunque dare un contributo alla riflessione, che mi auguro porti alla soppressione del provvedimento.
La prima considerazione è questa: mi sono immediatamente ricordato del “tempo potenziato”, dispositivo contrattuale previsto, esaltato e poi inattuato, tanto che non solo gli insegnanti più giovani, ma il fior fiore dei motori di ricerca lo confondono con l’organico di potenziamento. Per non parlare del “concorsone” di Luigi Berlinguer, che provocò una fortissima reazione della “categoria”, in quasi tutte le sue – variegate allora forse più di ora – componenti ideali e ideologiche, fino ad essere cancellato.
Potrei sbagliarmi, ma il mio reflusso professionale ha rigurgitato anche la figura del “docente senior”, che avrebbe riproposto nell’istruzione secondaria un modello qua e là usato in quella terziaria.
E poi ancora la vicenda della valutazione degli insegnanti in rapporto al riconoscimento di un presunto “merito” innescata dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 e via via depotenziata con provvedimenti e accordi con i sindacati. Le forzature per la differenziazione delle carriere degli insegnanti con lo scopo di introdurre gerarchizzazione – insomma – sono un evento frequente e hanno un trend di fallimento, anche grottesco.
La seconda considerazione: l’istruzione pubblica è devastata da decenni dalla cultura e dalla pratica della competizione tra e all’interno delle scuole con bandi, concorsi, premi, riconoscimenti, percorsi di formazione riservati, certificazioni private e simili.
La pandemia e il distanziamento delle operazioni didattiche hanno reso definitiva la colonizzazione delle aule e delle menti da parte del capitalismo cibernetico, assurto a sfondo inevitabile, syllabus adattivo universale.
Segmenti della formazione sono nominalmente e strutturalmente subordinati al mercato del lavoro (ovvero alla mercificazione dell’attività umana) come approccio generale e come dato di contesto spazio-temporale. Ma, storicamente, gli insegnanti si accorgono dei rapporti concorrenziali fondati sull’utilitarismo solo quando ne sono colpiti in forma diretta; e individuale. E davvero pochi sembrano cogliere ora che l’obiettivo del “docente esperto” servirà soprattutto a costruire e validare un’altra filiera della cultura intesa come potere e sottopotere.
Del resto, anche i più fieri oppositori di questo e di altri provvedimenti analoghi soffrono – è la terza considerazione – di un grave limite: ritengono che il pensiero critico, anziché intenzione e posizionamento espliciti, sia il frutto di un percorso di istruzione curriculare, fondato sulle certezze dei saperi disciplinari. Una neutra e rassicurante “capacità di esaminare nuove informazioni e idee concorrenti in modo spassionato, logico e senza preconcetti emotivi o personali”, come lo definisce Tom Nichols.
VAI ALLA PAGINA DEDICATA AL TEMA DEL DOCENTE ESPERTO
Continua a leggere
di Marco Guastavigna
Sul pasticciaccio brutto brutto brutto del “docente esperto” si sono già espressi in molti e in modo sistematico, a partire da considerazioni complessive sull’organizzazione del cosiddetto “mondo della scuola”.
Io sono invece un po’ confuso e mi limiterò a proporre quanto mi si è affacciato alla mente in questi giorni, convinto (illuso?) di poter comunque dare un contributo alla riflessione, che mi auguro porti alla soppressione del provvedimento.
La prima considerazione è questa: mi sono immediatamente ricordato del “tempo potenziato”, dispositivo contrattuale previsto, esaltato e poi inattuato, tanto che non solo gli insegnanti più giovani, ma il fior fiore dei motori di ricerca lo confondono con l’organico di potenziamento. Per non parlare del “concorsone” di Luigi Berlinguer, che provocò una fortissima reazione della “categoria”, in quasi tutte le sue – variegate allora forse più di ora – componenti ideali e ideologiche, fino ad essere cancellato.
Potrei sbagliarmi, ma il mio reflusso professionale ha rigurgitato anche la figura del “docente senior”, che avrebbe riproposto nell’istruzione secondaria un modello qua e là usato in quella terziaria.
E poi ancora la vicenda della valutazione degli insegnanti in rapporto al riconoscimento di un presunto “merito” innescata dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 e via via depotenziata con provvedimenti e accordi con i sindacati. Le forzature per la differenziazione delle carriere degli insegnanti con lo scopo di introdurre gerarchizzazione – insomma – sono un evento frequente e hanno un trend di fallimento, anche grottesco.
La seconda considerazione: l’istruzione pubblica è devastata da decenni dalla cultura e dalla pratica della competizione tra e all’interno delle scuole con bandi, concorsi, premi, riconoscimenti, percorsi di formazione riservati, certificazioni private e simili.
La pandemia e il distanziamento delle operazioni didattiche hanno reso definitiva la colonizzazione delle aule e delle menti da parte del capitalismo cibernetico, assurto a sfondo inevitabile, syllabus adattivo universale.
Segmenti della formazione sono nominalmente e strutturalmente subordinati al mercato del lavoro (ovvero alla mercificazione dell’attività umana) come approccio generale e come dato di contesto spazio-temporale. Ma, storicamente, gli insegnanti si accorgono dei rapporti concorrenziali fondati sull’utilitarismo solo quando ne sono colpiti in forma diretta; e individuale. E davvero pochi sembrano cogliere ora che l’obiettivo del “docente esperto” servirà soprattutto a costruire e validare un’altra filiera della cultura intesa come potere e sottopotere.
Del resto, anche i più fieri oppositori di questo e di altri provvedimenti analoghi soffrono – è la terza considerazione – di un grave limite: ritengono che il pensiero critico, anziché intenzione e posizionamento espliciti, sia il frutto di un percorso di istruzione curriculare, fondato sulle certezze dei saperi disciplinari. Una neutra e rassicurante “capacità di esaminare nuove informazioni e idee concorrenti in modo spassionato, logico e senza preconcetti emotivi o personali”, come lo definisce Tom Nichols.
VAI ALLA PAGINA DEDICATA AL TEMA DEL DOCENTE ESPERTO
Continua a leggere
![]()