 di Paolo Fasce
La legge 104 del 5 febbraio 1992 è una pietra miliare nell’ambito della tutela dei diritti delle persone con disabilità e il giorno in cui scrivo questo contributo intellettuale, sociale e civile della generazione che ha preceduto la mia nelle responsabilità operative del paese compie trent’anni.
Quando è stata emanata, Giulio Andreotti era presidente del Consiglio dei Ministri, la maggioranza parlamentare era quella del quadripartito (DC-PSI-PSDI-PLI) e il presidente della Repubblica era, nel suo declinare, Francesco Cossiga.
Il 17 febbraio di quell’anno, Antonio Di Pietro chiedeva l’arresto di Mario Chiesa e quello che si era appena avviato quale anno del centenario della fondazione del Partito Socialista Italiano, si sarebbe sostanzialmente rivelato essere l’ultimo di quella gloriosa esperienza.
Il 5 febbraio 1992 lo scrivente non aveva ancora compiuto 25 anni, non immaginava che sarebbe diventato insegnante e poi dirigente scolastico, progettava il proprio Programma Erasmus e assisteva alla trasformazione della propria città in polo turistico grazie all’esposizione universale delle colombiadi che regalavano il Porto Antico al mondo attraverso le celebrazioni del cinquecentenario della scoperta dell’America.
Scoperta da parte del mondo occidentale, beninteso.
Questa lunga premessa al semplice fine di inquadrare il contesto storico che mostra chiaramente come questo paese abbia viaggiato su due binari.
Continua a leggere
di Paolo Fasce
La legge 104 del 5 febbraio 1992 è una pietra miliare nell’ambito della tutela dei diritti delle persone con disabilità e il giorno in cui scrivo questo contributo intellettuale, sociale e civile della generazione che ha preceduto la mia nelle responsabilità operative del paese compie trent’anni.
Quando è stata emanata, Giulio Andreotti era presidente del Consiglio dei Ministri, la maggioranza parlamentare era quella del quadripartito (DC-PSI-PSDI-PLI) e il presidente della Repubblica era, nel suo declinare, Francesco Cossiga.
Il 17 febbraio di quell’anno, Antonio Di Pietro chiedeva l’arresto di Mario Chiesa e quello che si era appena avviato quale anno del centenario della fondazione del Partito Socialista Italiano, si sarebbe sostanzialmente rivelato essere l’ultimo di quella gloriosa esperienza.
Il 5 febbraio 1992 lo scrivente non aveva ancora compiuto 25 anni, non immaginava che sarebbe diventato insegnante e poi dirigente scolastico, progettava il proprio Programma Erasmus e assisteva alla trasformazione della propria città in polo turistico grazie all’esposizione universale delle colombiadi che regalavano il Porto Antico al mondo attraverso le celebrazioni del cinquecentenario della scoperta dell’America.
Scoperta da parte del mondo occidentale, beninteso.
Questa lunga premessa al semplice fine di inquadrare il contesto storico che mostra chiaramente come questo paese abbia viaggiato su due binari.
Continua a leggere
![]()



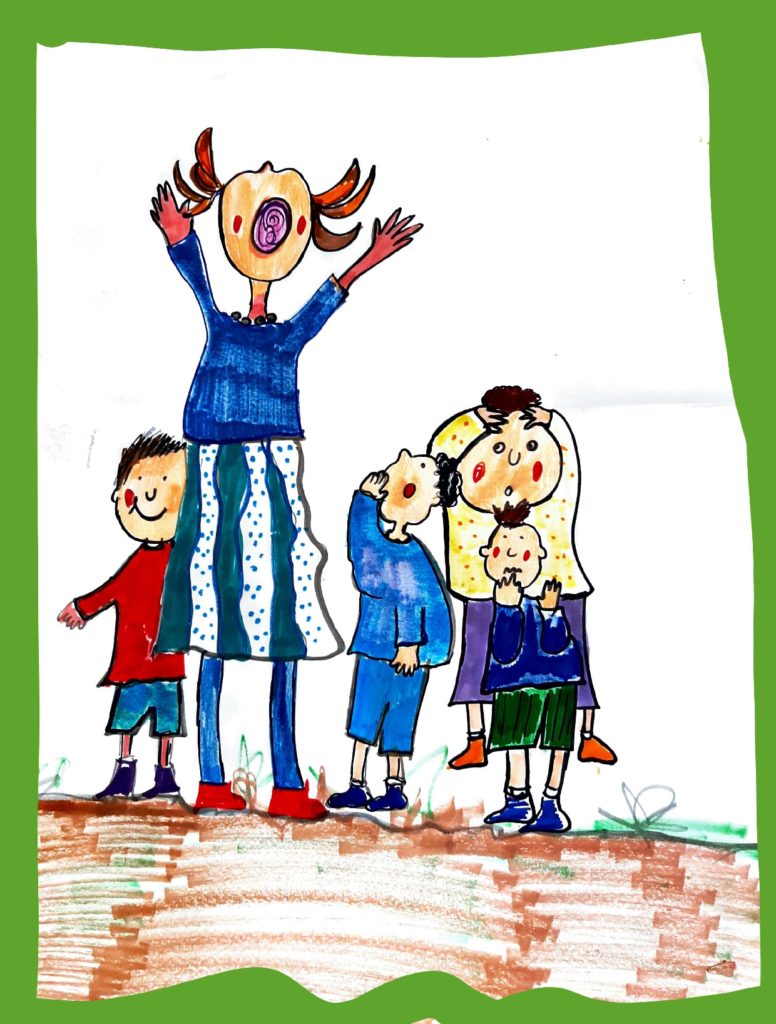

 di Evelina Chiocca
di Evelina Chiocca

