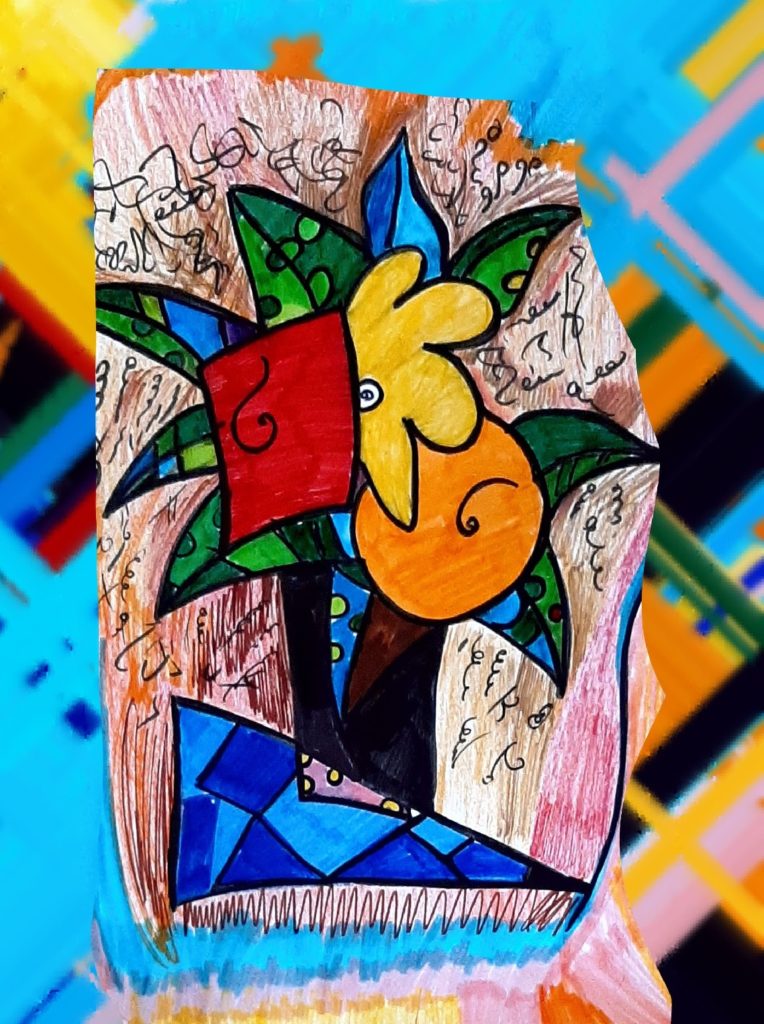disegno di Matilde Gallo, anni 10
di Antonio Valentino
La domanda delle Scuole in questa fase difficile e impegnativa è volta ovviamente a come fare al meglio la propria parte (ed essere aiutata a farla). Ma grande è anche il bisogno di orientamento e sostegno di fronte alle sfide importanti con cui sarà gioco forza misurarsi. Tra queste, in primis, la progettazione e le azioni per il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali, previste dal PNRR, assieme alla predisposizione della Rendicontazione sociale e del RAV per l’aggiornamento del PTOF: che richiederanno molto probabilmente ripensamenti di non poco conto sull’offerta formativa e le strategie per darle gambe.
1. Esperienze di Comunità Professionale (CP) durante la pandemia
Da considerare e sottolineare – delle scuole considerate in questa ricerca – le caratteristiche rilevate nel loro funzionamento durante la pandemia, sotto il profilo relazionale e organizzativo; caratteristiche così sintetizzabili:
- forte coinvolgimento degli insegnanti come collettivo;
- promozione e sostegno di pratiche collaborative
- la cura degli ambienti di apprendimento e l’attenzione al modello organizzativo, attraverso la valorizzazione delle figure di coordinamento delle diverse articolazioni del Collegio Docenti;
- leadership (condivisa) come “qualità distintiva” dell’intera comunità.
Sono queste caratteristiche – identificate come proprie delle “comunità professionali di apprendimento” – che, secondo l’analisi degli Autori dell’Editoriale, hanno permesso alle scuole ‘osservate’ – questo è l’assunto esplicito dell’Editoriale – di attraversare gli scombussolamenti dell’emergenza, garantendo comunque equità e qualità dell’offerta formativa.
-
Comunità Professionale. Si parte da lontano
Assunto questo che richiama e conferma ulteriormente, per più aspetti, l’importanza e il valore – e il metodo – delle ricerche e degli studi delle comunità scientifiche internazionali che – almeno dagli anni ’70 del secolo scorso – si sono interessate agli intrecci tra teorie dell’apprendimento e scienze organizzative. L’aspetto di maggiore interesse per queste loro ricerche va ricercato soprattutto nel nuovo approccio di carattere pluridimensionale, volto a studiare ed esplicitare le correlazioni tra fattori e capitoli di teorie coinvolte nei loro studi. E, ovviamente, a verificarne l’incidenza e l’efficacia.
E tutto questo, a partire da problematiche quali
- l’apprendimento nelle sue diverse forme (mnemonico e per imitazione, riflessivo e organizzativo, trasformativo e generativo, collettivo, individuale …),
- gli ambienti di lavoro (e come ci si sta dentro) e la cultura professionale, ma anche i modelli di funzionamento all’interno delle organizzazioni viste come organismi sociali,
- gli ambiti disciplinari a vario titolo chiamati in causa dalle ricerche (psicologia educativa, sociologia, pedagogia, economia, …)[2].
È quest’insieme di problematiche che entra in gioco, a partire da quegli anni, come intreccio di variabili che caratterizza le ricerche sulle Comunità Professionali, descritte, nell’accezione condivisa, come aggregazioni di professionisti che, all’interno di una organizzazione, ricoprono funzioni e ruoli identici. Studiarne il valore sociale e garantirne eventualmente tenuta, sviluppo e identità diventa l’obiettivo di questi studi.[3]
Perciò riportarne in primo piano i punti di forza, assieme agli interrogativi che pongono, e riappropriarsi delle sue parole chiave – e delle pratiche che le traducono operativamente – si assume qui come un’operazione che può aiutare a recuperare o a meglio sviluppare un’idea di scuola capace di aprirci a nuove prospettive in questa fase di incertezze e grandi sfide. Consapevoli che, senza una visione di insieme e un’idea di scuola condivisa, che orientino gli impegni e prospettino condizioni di rinnovamento e sviluppo, le stesse sfide prima richiamate (dalla lotta alla dispersione, all’apertura alle opportunità e alla collaborazione col territorio, eccetera ), sarà difficile affrontarle con qualche possibilità di successo.
3. Tra definizioni e approfondimenti[4]
Per recuperare al meglio l’idea di CP e metterla a fuoco – anche avvalendoci dei risultato di ricerche più recenti – può essere utile partire da una prima interessante definizione – forse la più nota – di due pionieri e protagonisti degli studi dei primi anni ’70 del secolo scorso, Donald Schön e Chris Argyris[5]; definizione che mette ben a fuoco gli aspetti caratterizzanti di una Comunità[6], intrecciati con elementi che hanno a che fare con la professionalità di chiunque operi in organizzazioni che funzionano come sistemi sociali di apprendimento. Di questi aspetti si citano soprattutto
- il senso di appartenenza (il percepirsi cioè come qualcosa di più grande che accomuna chi ne partecipa e li motiva in una logica di reciprocità);
- la percezione di essere dentro una rete di relazioni capace di fornire sostegno emotivo e professionale a chi ci sta dentro;
- la consapevolezza del proprio ruolo e del proprio sé professionale dentro la CP;
- un sistema comune di apprezzamento con cui distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è.
Si tratta, come è facile osservare, di caratteristiche che non si danno a priori e che richiedono quindi consapevolezza, esercizio e cura a più livelli, trattandosi di condizioni che interrogano la cultura e quindi la formazione professionale di chi partecipa a queste comunità. E non solo.
Va richiamato anche che ad arricchire e declinare più specificamente l’idea di CP di questi due studiosi concorrono anche i risultati di ricerche successive che riportano in primo piano gli aspetti più ricorrenti per definire e descrivere tali Comunità come specificamente professionali e permettere di riconoscerle attraverso appositi indicatori.
Tra questi, in primo luogo: una visione solidale e collaborativa del fare scuola, che si traduca in comportamenti contrari a chiusure e separatezze nell’esercizio delle diverse attività; e in secondo luogo: una cultura professionale fondata sull’assunto fondamentale che si apprende in modo socialmente significativo soprattutto attraverso il confronto e la condivisione delle pratiche lavorative e delle esperienze maturate.
L’accento posto sopra la dimensione collegiale e cooperativa, propria del costrutto di CP, tende piuttosto ad evidenziare opportunamente che, essendo la scuola una organizzazione-istituzione che ha responsabilità sociali, migliorarne la qualità è condizione che non può essere lasciata al caso o alla disponibilità del singolo, ma va opportunamente prevista e costruita, e anche curata e coltivata collegialmente nelle modalità più efficaci.
Conferme sulla fondatezza di questa visione arrivano tra l’altro anche dalle neuroscienze che evidenziano come l’apprendere in modo efficace non è attività puramente solitaria, ma un’azione sociale, in un contesto dato, che matura attraverso processi di interazione e negoziazione dei significati con altri soggetti con cui si è chiamati a interagire[7].
4. Dalle condizioni ai i primi punti di forza.
I tratti che, nelle elaborazioni condotte col nuovo approccio, qualificano una CP – e che si ripropongono come spunti promettenti di cui riappropriarsi -, mettono in primo piano e prioritariamente:
• una visione dell’apprendere non più come esperienza unicamente individuale e mentale, ma come fenomeno sociale e collettivo; non più esito quindi di pura trasmissione di nozioni (dalla lezione del docente o dalle pagine del libro di testo alla testa dello studente), ma come esperienza attiva e trasformativa;
• la valorizzazione dell’’apprendimento ‘organizzativo’ [8]: che si fonda sulla consapevolezza che in una organizzazione, il sapere professionale (e sociale) si crea, si sviluppa e si consolida, quando i contributi dei singoli o dei gruppi [in termini di risultati di esperienze, pratiche, attività] diventano parte del patrimonio di conoscenze della comunità [9]. Saldando così l’apprendimento individuale (o del gruppo) a quello collettivo e producendo cambiamenti migliorativi nel contesto lavorativo (Wenger) [10].
• l’idea di CP “come ambiente di apprendimento; dove apprendere è imparare a essere (learning to be) e ad agire come un membro della comunità (Brown e Duguid, 2000) [11] (Aspetto questo che si riprenderà successivamente).
5. La ‘pratica’, tra ricerca e riflessività
Una dimensione delle CP assolutamente centrale è anche Pratica che evidenzia l’importanza e il valore del conoscere basato sul fare e sull’esperienza. Importante per la nostra scuola, perché ancora non adeguatamente considerata, una prima definizione, ancora di Schön, di Pratica come “sistema di attività in cui il sapere non è separato dal fare” e “dove il pratico non è contrapposto al teorico”; e dove la conoscenza si precisa come attività contestualizzata, “situata” nei luoghi dove acquista significato e valore.
Ma forse può risultare ancora più stimolante recuperare con più evidente nettezza una seconda definizione dello stesso studioso che la descrive in questi termini:
“Attività di una comunità di professionisti che condividono (….) le tradizioni di un mestiere; e che acquista valore e senso (…) quando assume caratteristiche di ricerca e sa scavare in se stessa attraverso l’esercizio riflessivo e sa porsi domande, cercare coerenze, capire i presupposti delle azioni, cercare collegamenti con le teorie o tentare ipotesi teoriche nuove, insieme ai colleghi, mettendo a confronto i pensieri con le azioni”[12].
Assunto quest’ultimo del quale va soprattutto sottolineata l’importanza di due suoi aspetti caratterizzanti: la ricerca e la riflessività, considerate nella definizione come stimolanti indicatori di una CP.
Qui però si vuole soprattutto evidenziare il richiamo all’esercizio riflessivo come pratica-risorsa dell’organizzazione (e delle sue articolazioni) che porta a guardare dentro e oltre le azioni e i contenuti che esse esprimono, per cogliere la carica trasformativa delle conoscenze o generativa di nuove[13].
6. Le Comunità di Pratica (CdP)
A completamento di questa ricostruzione – necessariamente sintetica e per più versi approssimativa, volta soprattutto a evidenziare le caratteristiche promettenti delle CP – vanno recuperati i risultati degli studi e delle ricerche (ultimo decennio del secolo scorso) di due studiosi di origini svizzere, Etienne Wenger e Jean Lave, sulle Comunità di pratica (CdP).
Traendo spunti da Schön e Argyris, e più in generale dal filone di studi e ricerche che ruotano intorno alle CP, i due studiosi approfondiscono il senso e il valore dei luoghi di aggregazione (le CP) come ambienti di apprendimento dentro le organizzazioni, enfatizzando il concetto di pratica e dei suoi significati, su cui già Schön aveva offerto, come abbiamo visto, significativi contributi[14]; ma anche insistendo sulla specificità dei campi di interesse (Campi tematici) delle Comunità, che si configurano – questa è almeno la ricostruzione che tendo a privilegiare – come potenziali elementi di diversificazione identitaria rispetto al costrutto della CP in senso stretto.
Ma di Wenger va soprattutto richiamata la svolta (2002)[15], che lo porta ad allontanarsi dalla fase precedente strettamente teorica, per approdare ad una più pratica e operativa, che potrebbe essere probabilmente interessante riprendere e approfondire, perché offre stimoli per una più solida e innovativa configurazione del modello organizzativo per la componente docente delle Istituzioni Scolastiche (IS).
7. La formazione ‘situata’
Sintetizzando
A mo’ di sintesi, questo lo schema mentale e operativo dei ragionamenti svolti, che si propone come sguardo di insieme su un argomento complesso, ma certamente interessante soprattutto in questa fase.
La CP: idea di scuola che assume il punto di vista del funzionamento della Comunità dei docenti di una IS come ‘ambiente di apprendimento e di pratica’ finalizzato a garantire il successo formativo di tutti gli studenti, non uno di meno. Il che significa: cultura e sviluppo professionale, ambienti e rapporti di lavoro, tipo di relazionie modelli organizzativi conseguenti e coerenti.
Punto di vista quindi come espressione di un approccio multi dimensionale alle CP delle IS.
Il cui costrutto assume a riferimento:
- la dimensione collettiva dell’apprendere professionale (e non solo);
- l’apprendimento non tanto attività mentale, quanto operazione trasformativa della conoscenza;
- la pratica riflessiva come aspetto fondamentale della cultura professionale (apprendimento riflessivo)
- l’apprendimento ‘organizzativo’ come risorsa (pratiche, astuzie del mestiere, risultati di ricerche legati ai problemi del fare scuola) prodotta dai singoli o dai gruppi, che diventa patrimonio dell’intero collettivo della CP ed espressione della sua identità culturale e professionale;
- lo sviluppo professionale visto prioritariamente come formazione ‘situata’, espressione a. del confronto e della ricerca sui problemi aperti del proprio ambiente di lavoro e b. dei risulti, in termini di pratiche, di comportamenti, di strategie …, negoziati nel gruppo e in grado di affrontare problemi e difficoltà;
- gli ambienti e i contesti lavorativi come luoghi di collaborazione, negoziazione e intese;
- modelli organizzativi centrati: a. sull’autonomia di ricerca, b. sulla reciprocità delle relazioni, c. su una leadership distribuita, d. sulla dimensione reticolare delle articolazioni della Comunità professionale.
NOTE
[1] Titolo del numero monografico della Rivista dell’Università telematica IUL (26.06.2022): “Leadership, innovazione e cambiamento organizzativo. Promuovere comunità di apprendimento professionale”.
[2] Va doverosamente ricordato che il nuovo approccio recupera aspetti fondanti di teorie maturate nei decenni immediatamente precedenti, come il Learning by Doing (John Dewey), lo Sviluppo cognitivo di Piaget, l’Apprendimento come sviluppo sociale (Vygotskij), la Pedagogia scientifica e ruolo dell’ambiente di Maria Montessori; e include il Learning Organization (Peter Senge) e anche strategie formative come il Cooperative Learning.
[3] Cfr. I. Summa, Se il docente fa ‘Comunità professionale’, in ‘Rivista dell’istruzione’, n.6, 2014.
[4] Le riflessioni e alcune ipotesi di lavoro, che di seguito si propongono, recuperano, ripensate, tematiche ed elaborazioni maturate all’interno di un gruppo di lavoro interregionale, formato soprattutto da Ds dell’Associazione Nazionale Proteo Fare Sapere, in occasione del percorso di approfondimento delle Linee programmatiche per il Congresso Nazionale dell’Associazione (Ravenna, ottobre 2021).
[5] Riferimenti bibliografici fondamentali al riguardo sono: D. Schön – C. Argyris, Teoria in pratica: aumentare l’efficacia professionale . San Francisco: Jossey-Bass, 1974 ; Apprendimento organizzativo: una teoria della prospettiva dell’azione . Lettura, MA: Addison-Wesley, 1978; D. Schön, “L’epistemologia della pratica”, 1991
[6] Occorre chiarire che le CP su cui qui si riflette, non vanno identificate con le Comunità scolastiche indicate nell’ultimo CCNL scuola – novembre 2019 – (definite Comunità educanti), riferendosi queste ultime all’insieme delle articolazioni (‘le componenti’) delle Istituzioni Scolastiche (per le quali si possono ovviamente prevedere analoghi percorsi di ricerca). Le CP si riferiscono invece – qui e in genere negli studi sull’argomento che afferiscono specificamente al mondo della scuola – alla sola componente docenti (il Collegio che comprende anche il DS).
L’attenzione prioritaria alle CP dei docenti non vuol dire ovviamente sottovalutazione delle altre comunità professionali che operano nella scuola. Punta essenzialmente a riportare in primo piano la centralità dell’apprendere e del conoscere e quindi dei soggetti che istituzionalmente e prioritariamente sono investiti di questa funzione.
Perciò non penso sia esagerato affermare che l’idea di scuola a cui si tende passa in primo luogo attraverso l’idea di Comunità professionale dei docenti che si assume a riferimento; e quindi della cultura professionale di chi vi opera, della sua organizzazione, delle sue pratiche e dei suoi valori di riferimento.
[7] V. Pier Cesare Rivoltella, Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende, Cortina Editore, 2012.
[8] Organizational Learning, dove l’aggettivo è da intendere nel senso di ‘prodotto dai membri della comunità’.
[10] E. Wenger, ‘Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità’, Franco Angeli editore, 2006.
[11] V. sito Formez PA http://focus.formez.it/content/n10-comunita-pratiche apprendimento-e-professionali Focus tematico n. 10: Comunità di pratiche, di apprendimento e professionali, p. 22. Nel testo cit. – molto interessante e utile per orientarsi sull’argomento con una visione multidimensionale – il riferimento è nel paragrafo dedicato alle Comunità di Pratica.
[12] Le frasi virgolettate di questo paragrafo sono tratte da D. Schön, “L’epistemologia della pratica”, 1991.
[13] V. L. Mortari, Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci Editore, 2011, Fabbri L. (2007). Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Carocci: Roma e C. Mion, Riflessività, in www.edscuola.it/archivio/ped/riflessivita.htm, 2013.
[14] J.Lave, & E. Wenger, L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti di apprendimento. Erickson, 2006 – prima pubblicazione: Cambridge University Press, 1991;; E. Wenger, R. MCDermott, & W. M. Snyder, ‘Coltivare Comunità di pratica…, cit..
[15] Wenger, a seguito della ‘svolta’, formalizzata in ‘Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità’, del 2002 (nel 2006 in Italia. V. n 9) prevede che vi si possano costituire in autonomia dentro le, ‘costellazioni’ di CdP anche ‘promosse’ – le CdP – dalle Organizzazioni in quanto interessate alla promozione di organismi attivi e innovativi.
[16] V. S. Gherardi, D. Nicolini, cit., pp. 56-57.