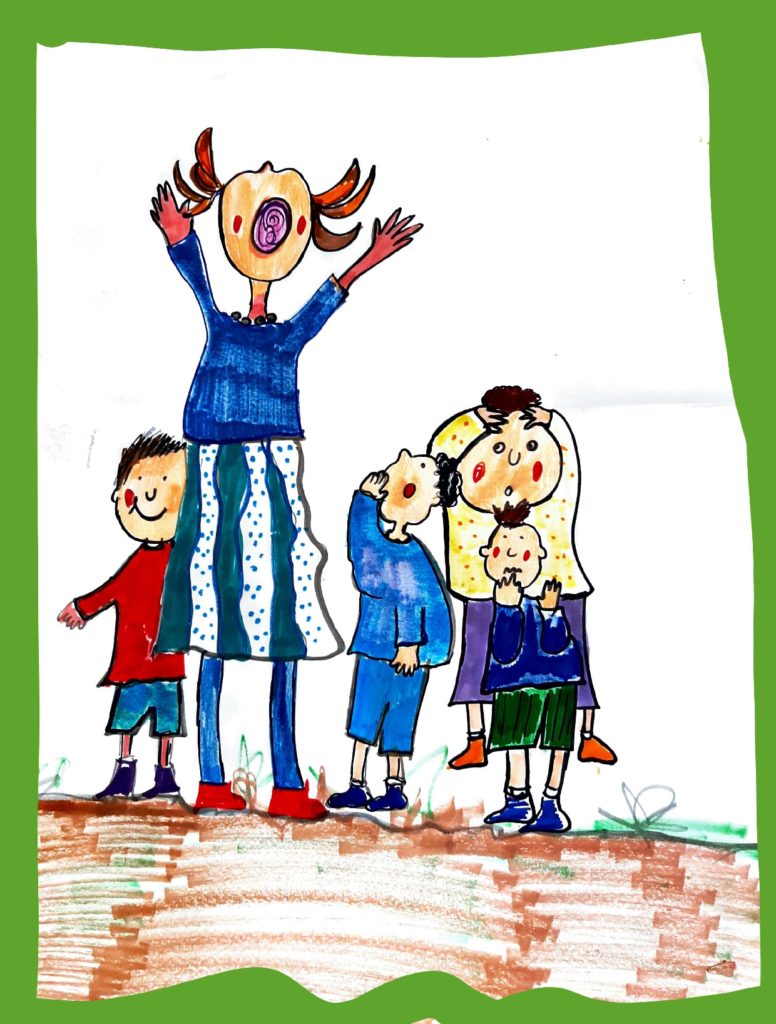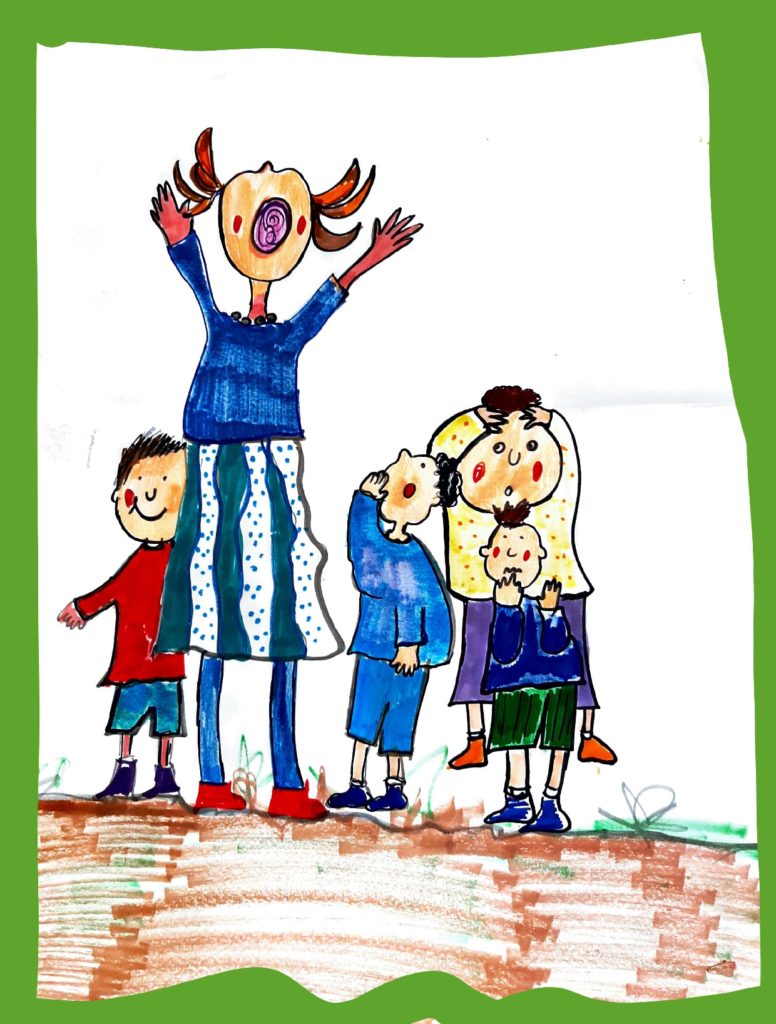 di Paola Di Michele
di Paola Di Michele
C’è un quadro bellissimo, arcinoto, di Pellizza Da Volpedo che rappresenta il Terzo Stato in marcia. Fatto di gente povera, vestita male ma con lo sguardo dignitoso e deciso proteso al futuro di chi cerca di conquistare il proprio pezzetto di dignità. E c’è un movimento nascente di lavoratori, operatori del sociale, che comincia adesso a prendere coscienza di condizioni lavorative diventate ormai al limite della sopportazione.
Per capirci, mi riferisco alle Cooperative Sociali di tipo A, cui l’ISTAT assegna un totale di lavoratori di circa 380.000 unità, per un indotto di più di 8 miliardi di euro, e che si suddivide in servizi scolastici educativi, servizi domiciliari socioassistenziali, socioeducativi, sociosanitari, centri diurni, centri di accoglienza, case-famiglia, nidi, e altro. Fondi che lo Stato stanzia alle Cooperative Sociali e che per meno della metà giungono nelle mani dei lavoratori.
Facciamo un piccolo passo indietro. Quando nasce questa situazione? Alla fine degli Anni Settanta, in un lasso di tempo brevissimo, appena un biennio, si può collocare la nascita del moderno Stato Sociale in Italia.
A fare da spartiacque sono una serie di leggi: la Legge 517/77, che abolisce le classi differenziali nelle scuole italiane e introduce le figure dell’insegnante di sostegno e dell’assistente all’autonomia e la comunicazione; la Legge 833/78, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, introducendo un modello universale di tutela della salute, intesa come stato di «completo benessere psico-fisico», perseguendo gli obiettivi di equità, partecipazione democratica, globalità degli interventi, coordinamento tra le Istituzioni, attraverso la territorializzazione dei servizi di assistenza sanitaria (oggi ASL); la Legge 180/78, cosiddetta “Legge Basaglia”, che abolisce le strutture manicomiali, e rimane riforma a metà anche a causa della morte dello stesso Basaglia che la voleva più compiuta, con le strutture territoriali di accoglienza che avrebbero sostituito l’istituzione totale manicomiale.
Si tratta di norme giuste, necessarie, avanzatissime sotto un profilo giuridico, etico e morale. Tuttavia, a “pentole bellissime”, lo Stato Italiano dimenticò i “coperchi”. Tutto questo splendore, infatti, richiedeva strutture, personale, fondi. Che lo Stato Italiano non aveva, o non aveva predisposto. O forse si era solo distratto, chissà. Forse pensava bastasse annunciare la “Rivoluzione dei Diritti”, per vederla realizzata come d’incanto.
Quello che successe fu che lo “spontaneismo” dettato dalla voglia di impegno, politico, sociale e culturale dei tempi, portò alla nascita del Terzo Settore. Persone, amici che si associarono per creare dal nulla quei servizi, condividendo un’idea di impegno civile e solidaristico che avrebbe portato alla nascita delle prime Cooperative Sociali, Associazioni Non Profit in cui i lavoratori erano anche soci e condividevano tutto, oneri e onori, decidendo insieme. Lo Stato fu ben lieto di delegare e ringraziò. Tutti facevano una magnifica figura.
Ma cosa ne è stato di quel movimento, a più di quarant’anni di distanza? Tanto per cominciare, la Legge che regola le caratteristiche delle Cooperative Sociali è stata promulgata solo nel 1991 (Legge 381/91), introducendo il concetto di volontariato (discorso su cui, volontariamente, preferisco non soffermarmi); è stata poi integrata dalla Legge 142/01 che definisce le Cooperative Sociali come Enti senza scopo di lucro e rispondenti ai dettami del diritto privato, sottolineandone la natura determinata dal «rapporto mutualistico [che] abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio». Inoltre, «i soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda».
Democrazia interna e partecipazione dei soci-lavoratori, dunque. Ebbene, una magnifica utopia! Una tale visione rimanda all’idea di un circolo di amici che discute del benessere proprio e altrui. Ma è proprio così?
C’è ad esempio una Cooperativa lombarda che ha decine di migliaia di lavoratori e opera, oltre che in Lombardia, in Liguria, Toscana, Abruzzo, Lazio, Puglia e Sardegna.
Senza fini di lucro e con la partecipazione mutualistica di quasi 20.000 soci (non è dato sapere quanti non siano soci, per altro…)? Almeno bisognerebbe porsi il dubbio se si tratta di non profit o di un’azienda vera e propria.
Ma chi sono i lavoratori del Terzo Settore? È necessario precisare che, sin dagli albori, queste professioni erano prive di normativa, percorsi di formazione nazionale e di riconoscimento, e tali restano in moltissimi casi, come accade per gli assistenti specialistici per l’autonomia e la comunicazione che operano nelle scuole e che attendono, invano, un Profilo Nazionale dal 2017.
Si tratta di una variegata umanità composta da laureati delle discipline di aiuto (psicologi, pedagogisti, educatori, assistenti sociali) o studenti delle stesse che fanno, spesso, questo lavoro “per farsi le ossa” in attesa ( o meglio, nella speranza) di fare di meglio, nonché di operatori di “vecchia data” che hanno iniziato con titoli svariati e, nel tempo, hanno seguito una quantità assolutamente stupefacente di corsi, come ad esempio i corsi OSS [Operatori Socio Sanitari, N.d.R.], che, inizialmente erogati da Enti Pubblici, hanno finito per essere “privatizzati”, arrivando a costi proibitivi. C’è poi una parte di lavoratori, per lo più stranieri, cui spesso vengono delegati (e questo non dovrebbe stupire…) i servizi più faticosi o poco specializzati, come, ad esempio, il Servizio SAISH a Roma (Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione della Persona Disabile).
Ciò che accomuna la maggior parte di questi lavoratori è un’attitudine agli altri, una volontà precisa di occuparsi di chi è più in difficoltà, di portare aiuto dove serve. Con tutto il carico di responsabilità, impegno morale, ma anche senso di colpa e impotenza, di fronte a situazioni dinnanzi alle quali si comprende di poter portare solo piccolo sollievo. Ciò determina quello che notoriamente viene definito come burnout, ossia una condizione di “esaurimento affettivo”, demotivazione e afflizione da cui raramente si torna indietro, con stati di prostrazione anche importanti.
Si aggiunga a questo stipendi che sono la metà esatta di quelli di un dipendente pubblico (800/900 euro retribuite “a ore”), con tutele bassissime, periodi di interruzione lavorativa “involontaria” (part-time ciclici verticali utilizzati diffusamente per i lavoratori delle scuole), che non prevedono alcun tipo di ammortizzatore sociale, una disciplina contributiva che determina pensioni ridicole, corsi di formazione e riqualificazione onerosi e frequenti e, infine, una condizione di precarietà lavorativa strutturale, determinata dai bandi pubblici a ripetizione, spesso con il solo criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, con operatori sociali che fanno il giro delle Cooperative come turisti sperduti senza mappa né itinerario.
In un Libro Bianco sulla condizione degli assistenti educativi scolastici, ricerca che condussi a Roma nel 2019, il 64% dei colleghi dichiarava di avere cambiato Cooperativa negli ultimi tre anni (“turisti senza mappa”, appunto). Dato ancora più impressionante, solo il 29% dichiarava di essere socio-lavoratore (dunque, dipendente privato a tutti gli effetti e non mutualisticamente coinvolto nella Cooperativa). A livello nazionale, la situazione è di poco migliore, come emerge dalla ricerca nazionale effettuata dalla sottoscritta durante la pandemia, con un dato del 40% di soci-lavoratori. Dunque, che ne è del lavoratore che concorre democraticamente alla gestione della Cooperativa?
Farò un esempio che spero dirimente. Annualmente, l’Assemblea dei Soci (quei pochi che ci sono) si riunisce per approvare il bilancio, dividere eventuali utili (sic), decidere i piani programmatici e rivedere il regolamento interno, che deve rispettare alcune normative fisse dalle quali non si può derogare.
Negli ultimi anni ho lavorato in una Cooperativa di cui ero socia (nell’ultimo cambio appalto, cambiando Cooperativa, non lo sono più, in attesa che la Presidenza decida «se ne sono degna», parole testuali). Le Assemblee si facevano in estate inoltrata, mai visto un bilancio, e si svolgevano in orario lavorativo, che non consentiva ai più di partecipare. Morale della favola: vi si presentavano venti/trenta persone di cui una metà con decine e decine di deleghe di altri lavoratori. Qualunque cosa la Presidenza proponesse veniva così approvata, anche in spregio ai diritti minimi (ad esempio: abolizione degli scatti di anzianità o malattia pagata solo al 50%).
Sia chiaro, è la mia esperienza, ma da ciò che mi è dato sapere parlando con moltissimi colleghi del Bel Paese, si tratta di esperienza piuttosto comune.
È cosa nota come, specie nel settore dei servizi sociali, che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali abbiano perseguito, negli ultimi vent’anni, una politica indiscriminata di esternalizzazione dei servizi essenziali affidati, a seconda dei casi, ad aziende private o a enti del Terzo Settore. Quali controlli le stazioni appaltanti abbiano messo in atto è sotto gli occhi di tutti, con evidenti ripercussioni specialmente nel settore sanitario, socioassistenziale ed educativo, come la pandemia in corso ha messo impietosamente a nudo in questo ultimo anno. In sintesi:
° ospedali privi di personale (molte Cooperative appaltano anche servizi infermieristici);
° utenti del domiciliare sia sanitario che sociale abbandonati a se stessi (e operatori privi di sistemi di protezione individuale e degli aggiornamenti del documento di valutazione del rischio lavorativo);
° centri diurni chiusi;
° alunni e alunne con disabilità privati dell’assistenza educativa scolastica cui avevano diritto.
Il sistema, così com’è concepito, determina:
° bandi pubblici legati al criterio del massimo ribasso, con conseguente decadimento del servizio e nocumento della continuità assistenziale ed educativa per la continua mobilità degli operatori;
° contratti Collettivi Nazionali di Lavoro discriminanti rispetto a quelli del settore pubblico per diritti e retribuzioni;
° spesa pubblica lievitata fra costi per le procedure di indizione, verifica e aggiudicazione dei bandi, con un’ampia parte dei finanziamenti utilizzata per la gestione delle strutture amministrative degli enti aggiudicatari, tale per cui la spesa reale destinata all’utente finale del servizio (e a chi di fatto lo attua, ossia l’operatore sociale) si assottiglia fino all’estremo;
° mancata applicazione della Legge 328/00 (i Progetti Individuali, questi sconosciuti…) e scarsità cronica di personale pubblico, ciò che determina un collegamento assai difficoltoso fra le strutture territoriali di coordinamento (ASL e Comuni) e gli operatori che, di fatto, “sono sul campo” spesso senza strumenti reali per incidere significativamente sulle situazioni di disagio;
° meccanismi di controllo degli enti appaltanti assolutamente deficitari e inconsistenti, spesso chiamati in causa solo dalle parti danneggiate da gestioni perlomeno dubbie (la punta dell’iceberg emersa con il caso “Mafia Capitale”).
Caso mai tutto questo non fosse sufficiente a mostrare un sistema che, così concepito, non tutela né gli utenti, né gli operatori, la questione andrebbe posta su un piano anche normativo.
Lo Stato, esternalizzando i servizi sociali ed educativi essenziali, ha sostanzialmente delegato al Terzo Settore la gestione, progettazione, messa in atto e verifica del cosiddetto Stato Sociale.
Soffermiamoci sull’etimologia della parola delega, ossia “mandare con un incarico”. Potrebbe leggersi anche come il leggendario “armiamoci e partite”. Sinonimo di “delegare”, poi, è affidare o anche demandare. Cosa significa, dunque, demandare? Che lo Stato, e per mano sua gli Enti Locali, da oltre vent’anni ha assegnato compiti e funzioni che gli erano propri per mandato costituzionale, ad altri soggetti privati, delegando la propria oggettiva responsabilità riguardo al benessere dei propri cittadini, e in particolar modo di quei cittadini che necessitano di particolare cura e protezione.
Se lo Stato delega e demanda, determinando spreco di risorse, situazioni professionali nebulose, carenza in qualità e quantità dei servizi, e producendo un vero e proprio “esercito” di lavoratori, operatori sociali di tutti i tipi (psicologi, educatori, assistenti specialistici scolastici, assistenti domiciliari, educatori domiciliari e così via) che di fatto portano sulle proprie fragili spalle la realizzazione del welfare in Italia, forse un sistema siffatto non risponde più a criteri non solo di efficacia e di efficienza dei servizi (oltre che di costituzionalità, mi verrebbe da dire), ma anche semplicemente di giustizia sociale. Un sistema che così com’è, significa, sinteticamente, “mettere i Penultimi ad occuparsi degli Ultimi”. Bisognerebbe, forse, ripensare lo Stato Sociale. Pubblico, come lo voleva Basaglia.
(*) Paola Di Michele è psicologa clinica, formatrice, assistente specialistica all’autonomia e alla comunicazione