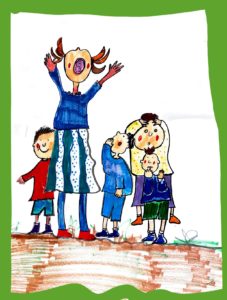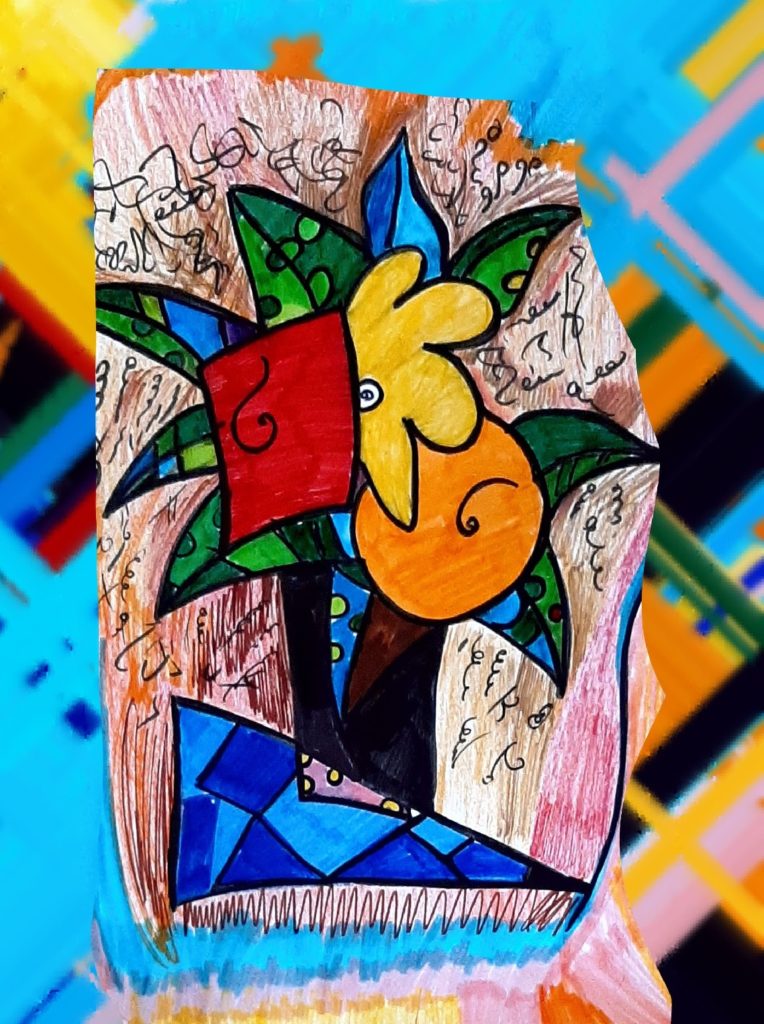Come uccidere la formazione senza essere scoperti
Questo intervento vuole offrire una serie di utili suggerimenti a coloro che, a vario titolo, si occupano di formazione del personale della scuola e che sono mossi dalla comprensibile volontà di sopprimere ogni tentativo di renderla attuabile.
Parliamoci chiaro: la formazione in servizio è una inutile perdita di tempo (e di soldi), soprattutto se riferita ad un sistema scolastico sano, avanzato, produttivo, eccellente come quello italiano, caratterizzato da risultati fuori dal comune, come emerge dalle classifiche internazionali (e infatti i risultati migliori si registrano al di fuori dei comuni italiani…), dalla grande cura che viene dedicata per far sì che nessuno si perda per strada (la dispersione scolastica in Italia è a livelli quasi zero…; il motto di tutte le scuole italiane infatti è No one left beynd), e da un corpo docente che sprizza salute da tutti i pori pedagogici ed esprime una preparazione professionale mediamente straordinaria e comunque non equiparabile a quella dei docenti degli altri Paesi avanzati.
Esiste anche da noi, ovviamente, qualche mela marcia, qualche docente che non sa fare il suo mestiere, ma il sistema è così solido che si riesce a risolvere queste criticità senza grandi difficoltà (ad esempio “sollecitando” il docente inadeguato a chiedere trasferimento ad altra scuola, e poi ad un’altra ancora e così fino all’età pensionabile. Il motto Nessuno resti indietro è da riferire ai docenti… ).
Tornando a noi, ci sono vari modi per uccidere la formazione senza farsi scoprire e lasciando credere alla UE e agli altri partner internazionali che nutriamo una profonda fiducia sul valore aggiunto della formazione e che quindi ci impegniamo a mettere in atto piani formativi di grande valenza pedagogica e didattica che contribuiscono in modo determinante ad innalzare il già altissimo livello di preparazione dei nostri docenti bla bla bla, bla bla bla… (cfr Greta Thunberg).
Questi metodi di soppressione della formazione sono il risultato di tanti studi svolti sul campo a vari livelli e di una continua sperimentazione in situazione. Ad esempio, per lunghi anni abbiamo detto che la formazione è un diritto/dovere dei docenti, una locuzione, questa, bellissima per dire tutto (ossia niente) e per scansare in modo rigoroso e scientifico l’inutile zavorra della formazione. Infatti, nella titanica (e bizantina) discussione riguardante quanto dovere e quanto diritto ci debba essere nella formazione, intere generazioni di docenti sono riusciti ad andare tranquillamente in pensione facendo poche o zero ore di formazione e potendo dire ai nipoti, con orgoglio: “Io non c’ero!” oppure, quelli più esterofili, “Not in my back yard!”
Questa situazione assolutamente idilliaca e tranquilla è stata proditoriamente e sciaguratamente sconvolta dalla legge 107/2015 che ha stabilito che la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Panico nel mondo scolastico e sindacale! Non tutti hanno però colto la sottile e intelligente strategia utilizzata dal nostro legislatore nel far credere che la formazione diventasse qualcosa di stabilizzato nella vita delle istituzioni scolastiche. In realtà questa volontà il decisore politico non l’ha mai avuta! E il decisore amministrativo ancora meno! Il tutto, infatti, rientrava in una sorta di teatrino politico escogitato appositamente per confondere l’UE e far sembrare che in Italia la formazione è tenuta in grande considerazione. E in effetti, con visione lungimirante, la stessa Amministrazione scolastica si è ben guardata dal tradurre quella “obbligatorietà” in un monte ore definito e a sancirlo nel CCNL.
Anzi con una nota applicativa (n. 2915 del 15/09/2016), degna della migliore scuola sofista, il Ministero precisava che “il principio della obbligatorietà della formazione in servizio” [va considerato] “come impegno e responsabilità professionale di ogni docente” [e dunque] “l’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano”.
Insomma, non esiste alcun monte-ore obbligatorio. Il sospiro che si è sentito in Italia al momento dell’emanazione della nota era quello di sollievo da parte di molte scuole e dei loro sindacati. Questo concetto veniva ribadito con commovente iterazione con una nota successiva (la n. 25134 dell’1/06/2017) la quale stabiliva che “l’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.
Leggasi: ognuno fa quello che vuole. D’altro canto non poteva essere diversamente: la nostra è una matura democrazia liberale. La tua libertà finisce dove comincia la mia. Tu non vuoi fare formazione? No problem! Non costringere me a farla. Anzi, mettiamo insieme le nostre forze per costruire una formazione eterea, incorporea, leggera, quasi impalpabile.
Ma ci sono altri modi per uccidere la formazione senza essere scoperti: per esempio ricorrendo all’utilizzo di termini contrastanti o dando fiducia al tempo. Per quanto riguarda il primo aspetto, il gioco è abbastanza semplice: prendete una qualsiasi legge (ad esempio la n. 178 del 30/12/2020) e stabilite che viene avviata una formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso (i docenti, non gli alunni…) del titolo di specializzazione sul sostegno.
Il principio dell’obbligatorietà lo ribadite anche in un successivo decreto applicativo (ad esempio il DM n. 188 del 21/06/2021).
Ma (attenzione! attenzione! A me gli occhi!) con una circolare che reca istruzioni in materia (ad esempio la n. 27622 del 6/09/2021) il personale docente interessato viene “invitato” a partecipare alle attività formative. Non “obbligato”, capite? E in effetti molti docenti, educatamente e con l’appoggio degli onnipresenti sindacati, hanno risposto al ministero: “Grazie dell’invito, mi ha fatto molto piacere riceverlo, ma non intendo parteciparvi. Ho altro da fare. Sarà per un’altra volta. Non perdiamoci di vista, però.”
Per quanto riguarda il tempo, c’è da ricordare innanzi tutto che esso è galantuomo; e mai massima fu più azzeccata come nel presente esempio. Infatti con la già citata nota 27622/2021 il Ministero ha fornito un’articolata proposta di organizzazione dei corsi di formazione sulla disabilità La nota reca la data del 6 settembre 2021; nel testo viene detto che “per consentire l’effettiva erogazione delle risorse finanziarie entro l’a.f. 2021, le scuole saranno invitate a fornire rendicontazione entro e non oltre la data del 30 novembre p.v.” Avete capito? Più veloce della luce! Il nostro Ministero certe volte è di una efficienza e tempismo mostruosi. (Di solito quando si tratta di far lavorare gli altri…).
In poco più di due mesi le scuole dovranno progettare le attività formative, trovare i formatori, stipulare i contratti (mi raccomando: non si trascuri di chiedere il consenso per il trattamento dati, l’antimafia, l’anticorruzione, i dati anagrafico-fiscali, la dichiarazione di insussistenza/incompatibilità, il CV in formato UE, e gli atri 15 atti previsti…), realizzare le attività formative a livello di ambito e fornire rendicontazione al Ministero entro il 30 novembre! Non ci si lasci però impressionare da questa veemenza decisionista; le ragioni in realtà sono molto serie e impongono un impegno solerte e senza indugi da parte delle scuole interessate alla formazione: infatti, se le scuole non rendicontano entro il 30 novembre potrebbe succedere qualcosa di grave al nostro Paese, qualcosa di irreparabile e catastrofico, qualcosa che in confronto lo scoppio della Terza Guerra Mondiale rappresenterebbe una bazzecola di second’ordine.
Vi chiederete che cosa; è presto detto: i ragionieri del Ministero dell’Istruzione non avrebbero i dati a disposizione per fare il conteggio di quanto è stato speso e di quanto resta da spendere! E questo è di palmare evidenza che non ce lo possiamo permettere! La pandemia è stata devastante per la scuola e per il Paese; non riusciremmo a sopportare un’altra sciagura se i dati non arrivano prima del 30 novembre a viale Trastevere!
Naturalmente questa oltremodo tempestiva mossa del Ministero nasconde un secondo fine, molto astuto e coerente con quanto abbiamo detto sopra: con tempi così ridotti molte scuole non riusciranno ad organizzare la formazione e quindi, ancora una volta, si riuscirà a farla franca rispetto al famoso vincolo della “obbligatorietà” della formazione. L’Italia è un Paese magnifico: ad ogni problema trova sempre una non soluzione.