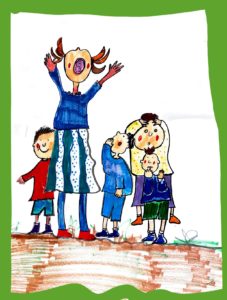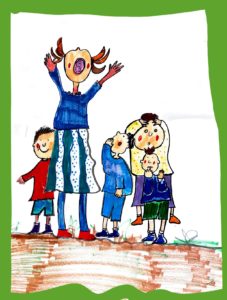 di Franco De Anna
di Franco De Anna
La cultura sociale del nostro Paese è singolarmente percorsa da un costrutto di lutto e mancanza. Il Risorgimento è una “rivoluzione mancata”; la Vittoria è “mutilata”, la Resistenza è “tradita”; la Costituzione è “irrealizzata”…
E’ un costrutto che in parte proviene da una (datata) riflessione storica, ma viene rielaborato nel senso comune dalla vulgata della riproduzione politica e dell’informazione. Non è questa la sede per approfondire, ma certo questo costrutto sembra proiettare l’intera collettività in una dimensione di irrealizzato che, scontando il riflesso del lutto e dell’abbandono della memoria dolorosa, consente alla cultura politica un paio (almeno) di abusati strumenti di comunicazione di massa.
Il primo è il lusso di predicare come sempre nuove (di moda il termine “epocale”) ipotesi riformatrici in realtà già esplorate e di cui si tralascia sia la memoria, sia la necessità di valutarne rigorosamente i fallimenti e le loro ragioni. Ne viene favorito un opportunismo implicito, variamente interpretato, nei caratteri del “nuovismo”.
Il secondo vantaggio politico di tale opportunistica elaborazione è che “tutti sono riformatori”; anzi, quale che sia il colore politico ciascuno proclama la propria autenticità e radicalità riformistica. In questo paese, sostanzialmente e prevalentemente conservatore, nessuno (pochissimi) dichiara di esserlo.
Potremmo offrire a qualche lacaniano, che pare interessato alla scuola, il destro per una riflessione psicanalitica sul rapporto tra tale paradigma della mancanza e dell’irrealizzato, e il fatto che la psicologia collettiva del nostro Paese non abbia mai rielaborato la “patria” (il padre) ma la sua consistenza collettiva sia da “matria”. Il “collettivo nazionale” è in realtà “mai nato”. Un cordone ombelicale mai reciso.
Una dannazione ed una salvezza congiuntamente, operanti nelle fasi più critiche della storia nazionale: ci aiutò ad uscire dalla “morte della patria” nel 1943; ci impedisce di costruire un assennato sistema di welfare di cittadinanza, “paterno e non materno” …
Al precedente elenco dei lutti storici potremmo aggiungere (si parva licet…) l’Autonomia delle Istituzioni scolastiche che è congiuntamente normata da strumenti di legge (dalla 59/97 al Regolamento) e richiamata della Costituzione (titolo V, art. 117).
Autonomia, buona scuola e autovalutazione Il pensiero si innesca inevitabilmente nella lettura comparata de “La buona scuola” laddove parla di autonomia e valutazione, come coppia concettuale fondante della filosofia valutativa proposta, e della Direttiva Ministeriale sulla valutazione, la circolare applicativa corrispondente, i caratteri del protocollo autovalutativo che si preannunciano e in parte sono stati sperimentati. La filosofia enunciata ne “La buona scuola” richiama esplicitamente l’autonomia come valore fondante del “sistema di istruzione”.
A tale valore connette organicamente (e correttamente) le problematiche della responsabilità e della valutazione e quella del sistema di governance (sia pure con il limite del considerare la governance interna: organi collegiali, Dirigenza, partecipazione ecc… ma non la governance esterna. Si tenga conto del “sintomo”, costituito da tale assenza..).
Sembrerebbe cioè riprendere gli elementi di un disegno radicalmente innovativo di destrutturazione e ricostruzione del sistema di istruzione, tentato all’inizio del secolo: il passaggio da un modello piramidale assimilato alla pubblica amministrazione e governato dal diritto amministrativo (produzione di atti…) e percorso da un flusso di comando algoritmico dal centro alla periferia, ad un modello decentrato, ma soprattutto caratterizzato dalla pluralità di “produttori del servizio” operanti in rapporto con gli “utenti” (i cittadini, le comunità locali..), con autonomia operativa e dunque con una duplice responsabilità.
In primo luogo, verso i cittadini portatori non solo di “interessi” ma (soprattutto) di diritti (istruzione come diritto di cittadinanza). E in secondo luogo verso lo Stato come garante sia della fruizione di quel diritto, sia della “uguaglianza” dei cittadini rispetto ad essa. Quel “progetto” aveva riferimenti sia nazionali che internazionali di grande portata: dal decadere dei tradizionali modelli di stato sociale (la crisi fiscale dello Stato che investiva tutto l’Occidente), al nodo specifico costituito dalla necessità della riforma della Pubblica Amministrazione nazionale.
Elementi portanti di quella ipotesi riformatrice sono (sarebbero) i seguenti.
– Il passaggio dallo Stato “produttore” diretto di servizi, a soggetto “regolatore” e “finanziatore” del servizio affidato a una pluralità di “produttori” (le scuole autonome). Da producer a provider. (visto che qualcuno ama il lessico anglosassone). Nella versione “di destra” e “privatistica” da producer a customer ..(vedi ispirazioni politiche Regione Lombardia. Il soggetto pubblico come “committente” di servizi offerti alla popolazione-cliente).
– Compito dello Stato (garante dei diritti di cittadinanza) diviene (diverrebbe) dunque quello di definire le “prestazioni essenziali” dovute a tutti i cittadini. Tale repertorio è di natura “politica e istituzionale” (i diritti) ma anche tecnico e scientifica (il contenuto delle prestazioni e i relativi protocolli validati tecnicamente e scientificamente: i Livelli Essenziali di Prestazione). Vi sono in proposito sentenze della Corte Costituzionale (riferite al Servizio Sanitario Nazionale, ma con buon isomorfismo rispetto alla produzione di servizi alla persona. Non tocca esclusivamente alla politica definire il repertorio ma occorre il contributo della ricerca tecnico scientifica ed il costante adeguamento ad essa.
– Il repertorio delle prestazioni essenziali ha un riflesso anche sul profilo dei costi e dei finanziamenti. I “costi standard” sono infatti il corrispettivo economico delle prestazioni essenziali (la cui determinazione richiede qualche cosa di più che individuare la media dei costi). I costi standard rappresentano il riferimento, l’ancoraggio del meccanismo di finanziamento pubblico, dallo Stato alla pluralità dei produttori autonomi del servizio. Non “l’unico” criterio di finanziamento (si pensi al valore della solidarietà, della compensazione delle differenze e delle diseguaglianze…) ma la “base” del meccanismo di finanziamento pubblico. La combinazione tra finanziamento a costi standard, autonomia organizzativa e produttiva dei servizi, padronanza delle risorse economiche, umane e organizzative, verificata dalla garanzia della qualità del prodotto, rappresenta (rappresenterebbe) la garanzia di una ricerca costante della “migliore efficacia” (ottimizzazione costi/risultati), supportata, oltre che dall’etica pubblica, proprio dalla convenienza della padronanza delle risorse. (se la produzione di un servizio pubblico, a parità di qualità erogata, avviene costi inferiori a quelli standard, si recuperano all’autonomia risorse per lo sviluppo innovativo o per la incentivazione del personale…)
– La decostruzione del modello amministrativo tradizionale mette capo ad un sistema di governance (governo misto) che coinvolge nella determinazione della strategia pubblica e nella sua realizzazione una pluralità di soggetti e responsabilità (nel sistema di istruzione lo Stato e le Regioni, titolari di podestà legislativa e le istituzioni scolastiche autonome titolari di responsabilità “produttiva”, il sistema delle autonomie locali, legato a quello regionale con responsabilità gestionali strutturali, dall’edilizia ai servizi). I vincoli delle prestazioni essenziali, dei costi standard, dei livelli di qualità (valutazione) sono (dovrebbero) comuni e condivisi da tutti i titolari della governance (Che dire, però, dei lavori della Conferenza Unificata sui temi scolastici?!)
– Un corollario di quel modello è rappresentato dal fatto che la preoccupazione della “tenuta sistemica” (appropriata ai compiti dello Stato) deve esprimersi nella capacità di definire con accuratezza i “vincoli essenziali” cui sono tenuti i produttori, in termini di risultati e di rendicontazione, e non (come da modello tradizionale) le specifiche dei processi di produzione. Ai “produttori” vanno indicati i 5 o 6 elementi che “non possono non essere” nelle prestazioni e nei prodotti realizzati, a garanzia della comparabilità di sistema. Sui processi concreti va invece lasciata, ma anche promossa, incentivata, la padronanza e la responsabilità produttiva della scuola autonoma.
– Il carattere dell’operare dello Stato e della Pubblica Amministrazione, si sposta (si sarebbe spostato) dunque, dalla veicolazione del comando amministrativo alla predisposizione di “servizi” (ricerca, documentazione, elaborazione dei repertori di prestazioni essenziali, meccanismi di finanziamento coerenti e promotori di eguaglianza) e, conseguentemente, del servizio di valutazione a garanzia della qualità del “prodotto pubblico”.
Dal comando amministrativo alla produzione di services. Una “rivoluzione” del paradigma amministrativo classico, e del modo di organizzare i servizi del welfare.
Una transizione incompiuta
In questo senso, l’affermazione ne “La buona scuola” della connessione del trinomio autonomia, responsabilità, valutazione, sarebbe assolutamente coerente a quel modello. Ma se ci si provasse a capire che cosa da oltre un quindicennio si è opposto alla sua realizzazione, quali interessi, quali culture, quali meccanismi auto riproduttivi, forse si potrebbero individuare strategie di realizzazione finalizzate e indirizzate su bersagli specifici. Come sono stati governati i meccanismi di finanziamento delle scuole, per assicurare effettiva padronanza delle risorse? Quali regole nella classificazione, gestione, destinazione del personale per dare effettiva padronanza organizzativa alle scuole autonome? Quali interventi sul sistema della Ricerca Educativa e dei suoi Istituti (quelli regionali, chiusi, e i due nazionali INDIRE e INVALSI, per 10 anni in ristrutturazione/transizione..); come si sono riconfigurati i presidi territoriali del MIUR, e il MIUR stesso, (Dipartimenti, direzioni, USR, Uffici territoriali…), per costruire un effettivo sistema di services all’autonomia? Per ciascuna domanda (e sono solo alcune..) vi sarebbe un giudizio valutativo da esplicitare: e non si stratta di un giudizio politico (non solo), ma di una elaborazione tecnico-politica di quanto realizzato in funzione delle strategie dichiarate.
Se l’attività di valutazione non investe prima di tutto la “politica pubblica” e le sue realizzazioni (e, insisto, non si tratta di un mero giudizio politico, ma di corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati ed i risultati) sarà difficile abilitare il principio del nesso responsabilità/valutazione sugli altri livelli e contesti (le organizzazioni, il personale, i dirigenti). In merito basterebbe considerare la coerenza con la quale si applica, nella nostra amministrazione, il criterio dello spoil system (ideologicamente rivendicato) alla alta dirigenza amministrativa: funziona in entrata, non in uscita. L’incompiuta sembra un destino nazionale. Ma ha una griglia più o meno complessa di responsabilità sia politiche che tecnico-politiche, e, questione cruciale, culturali. Il vero imputato dell’incompiutezza è la cultura della cosa pubblica. E nel caso dell’autonomia scolastica la sostanziale estraneità e sotterranea opposizione manifestata della Pubblica Amministrazione del MIUR.
Si tratta, come si vede, di un nodo possente e di difficile scioglimento: emerge in evidenza proprio sulla topica della valutazione delle scuole e della sua “premessa e allegato” (così vorrebbe il modello del Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione) costituito dalla autovalutazione.
Lo specchio e la fotografia: il significato dell’autovalutazione
“Evidentemente entrambi avevamo una fame terribile. Il guscio dell’aragosta era già vuoto e il cameriere venne sollecito. Ordinammo altre cose, a sua scelta. Cose leggere, specificammo, e lui annuì con competenza. “Qualche anno fa ho pubblicato un libro di fotografie”, disse Christine.” Era la sequenza di una pellicola, fu stampato molto bene, come piaceva a me, riproduceva anche i denti della pellicola, non aveva didascalie, solo foto. Cominciava con una fotografia che considero la cosa più riuscita della mia carriera, poi gliela manderò se mi lascia il suo indirizzo, era un ingrandimento, la foto riproduceva un giovane negro, solo il busto; una canottiera con una scritta pubblicitaria, un corpo atletico, sul viso l’espressione di un grande sforzo, le mani alzate come in segno di vittoria: sta evidentemente tagliando il traguardo, per esempio i cento metri”. Mi guardò con aria un po’ misteriosa, aspettando una mia interlocuzione.
“Ebbene ?” chiesi io, ”dov’è il mistero?” “La seconda fotografia”, disse lei.
”Era la fotografia per intero. Sulla sinistra c’è un poliziotto vestito da marziano, ha un casco di plexiglas sul viso. Gli stivaletti alti, un moschetto imbracciato, gli occhi feroci sotto la visiera feroce. Sta sparando al negro. E il negro sta scappando a braccia alzate, ma è già morto: un secondo dopo che io facessi clic era già morto”. Non disse altro e continuò a mangiare.”
(Da “Notturno indiano” di Antonio Tabucchi)
Un autorevolissimo interlocutore con ruolo fondamentale nella direzione del MIUR presentando l’autovalutazione delle scuole ad una platea di Dirigenti Scolastici della mia Regione (Marche), all’inizio della “avventura del RAV; con grande, ma forse inconsapevole, efficacia comunicativa disse “Noi vi daremo una fotografia… voi deciderete cosa migliorare… poi nel triennio…”. Si riferiva al fatto che alle scuole vengono resi disponibili dati rielaborati dal “superiore” ministero (da INVALSI…) e che costituiranno il punto di riferimento per l’analisi autovalutativa (le scuole potranno aggiungere proprie informazioni e propri indicatori, ma, nella filosofia del dettato della norma, in chiave “residuale” e aggiuntiva”). I report di informazione su se stesse (la fotografia) verranno da “altri” (il Ministero, l’INVALSI…).
Non desidero discutere sulla pertinenza tecnico scientifica di tali “raccolte di dati” (le contraddizioni anche tecniche sono numerose: basterebbe valutare la chiarezza e trasparenza dei dati di “Scuole in Chiaro” riferiti alle risorse economiche delle scuole e la loro capacità di rendere leggibile un bilancio ad un comune cittadino, che per altro dovrebbe poterlo consultare a livello di singola scuola e probabilmente con maggiori chiavi di lettura e possibilità interpretative). Mi interessa invece il significato profondo, politico e culturale, di tale approccio, esemplare delle diverse concezioni e pratiche dell’autonomia.
Su questo piano maturano le contraddizioni più significative tra le affermazioni ripetute nel confronto politico corrente, relative al nesso autonomia e valutazione, e le proposte fin qui delineate nello specifico del Sistema Nazionale di Valutazione.
Segnalo quali siano, a mio parere, gli elementi più significativi di tale “stratificato” di contraddizioni, ribadendo che la loro origine sta proprio nella criticità di quel nesso autonomia/valutazione che viene a parole enfatizzato.
- Viene delineata una concezione (e ovviamente una pratica..) dell’autovalutazione che sposta e attenua significativamente il peso specifico dell’autoanalisi (organizzativa, gestionale, delle strategie e dei risultati) della singola organizzazione.
Il valore aggiunto dell’impegno alla raccolta sistematica ed analisi dei propri dati, nella scelta degli indicatori, nelle aree da sottoporre a verifica consiste nel fatto che su tale comune impegno di una organizzazione si misura la sua “propensione” al miglioramento.
E’ questo il terreno fondamentale del nesso tra autonomia, responsabilità, valutazione. Nel modello proposto invece, la scuola in autovalutazione dovrà esaminare dati (per altro da essa stessa provenienti) rielaborati dal MIUR stesso (Scuole in Chiaro), risultanti da questionari (rielaborati da INVALSI) che coinvolgono il personale, i genitori e gli studenti, oltre cha i dati relativi alle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento.
La scuola viene invitata a fare autoanalisi su dati offerti da “fuori”. Apparentemente una comodità: si esenta la scuola da un impegno ed una fatica; si uniformizza il protocollo. In realtà una sostanziale mortificazione della stessa autonomia. Alla scuola non si propone di “guardarsi allo specchio”, e di provarsi a fare i conti con se stessa, opportunamente giovandosi di un “amico critico” capace di valorizzare lo specchio e impedendo il “narciso”. Si propone invece di guardare una sua fotografia, scattata da altri (vedi brano di Tabucchi…)
La preoccupazione “sistemica” di tenuta unitaria e di comparabilità, in un contesto di autonomia valorizzata, richiederebbe esattamente di invertire l’approccio: il “cuore” del processo è l’autoanalisi della singola organizzazione; il ruolo indispensabile della dimensione sistemica si esercita indicando un plafond ristretto e essenziale di rilevazione di dati che “non possono non esserci” a garanzia della comparabilità. L’esame dei modelli di autovalutazione implementati dalle scuole sarebbe allora davvero una misura delle loro “propensione” al miglioramento, e la valutazione esterna avrebbe un campo significativo (certo non esclusivo) sul quale esercitarsi. Io comprendo le esigenze di “unità” sistemica; ma così la garanzia di unità del sistema è fondata sul fatto che tutti si “si mettano in divisa”.. Non è un “inedito”: si pensi al processo con cui si è provveduto ad affrontare e risolvere il problema della trasparenza nei servizi on line delle scuole. Anche in tal caso invece di indicare in modo vincolante le informazioni essenziali da assicurare nei rispettivi siti, si è provveduto a trasformarli in “fotocopie”. L’unità si interpreta come “uniformità”. L’identità si interpreta come “identicità”. Il doppio slittamento semantico è proprio della Pubblica Amministrazione e segnala il modo proprio di declinare l’autonomia.
La realtà però si vendica di questo riduzionismo; e in due modi possibili: vi saranno scuole (quelle che hanno sperimentato modelli e protocolli propri) che si batteranno per ampliare e complessificare, falsificare, la “fotografia” ricevuta. Ve ne saranno altre e probabilmente la maggioranza, che, dopo il primo impatto e fatica, assolveranno all’adempimento, compileranno le schede, rispondendo alle domande, assemblando il report… e lasciando sullo sfondo le dinamiche reali della propria identità di organizzazione, i caratteri della propria cultura organizzativa. E così, fuori bersaglio, andrà proprio l’obiettivo di raggiungere una “valutazione autentica”. Non credo sia questo il senso del lavoro di tanti ricercatori che operano all’INVALSI. Né che ciò sia utile allo stesso decisore amministrativo e politico la cui razionalità decisoria dovrebbe essere alimentata proprio dalla “valutazione autentica”
- Entro tale schema interpretativo, il significato della rendicontazione sociale slitta. Il suo valore sostanziale è quello di essere una “filosofia” della produzione dei servizi in rapporto alla domanda dei cittadini, della comunità locale di riferimento, e del diritto di cittadinanza concretamente esercitato. Una “filosofia” che si materializza in un documento (Il Bilancio Sociale) che diventa oggetto di tale confronto. La rendicontazione sociale non può limitarsi a coincidere con la mera “pubblicità” degli atti. Nulla da eccepire ovviamente (mancherebbe: le scuole sono Enti Pubblici…e che pubblichino loro bilanci è obbligatorio: magari in modo che siano effettivamente leggibili dai cittadini. Che dite dall’aggregato Z01 per esempio?…Lo spiegherà ai cittadini “Scuole in Chiaro”?). Ma la rendicontazione sociale è altro: l’interfaccia dell’autonomia e della sussidiarietà, nel rapporto con la comunità locale, della verificata congruenza tra l’offerta formativa e la domanda… Anche in tal caso il medesimo “scarto” nella filosofia amministrativa. La tenuta sistemica e le preoccupazioni di comparabilità, in un sistema che vede operare una pluralità di produttori autonomi, richiede che siano rigorosamente definite le informazioni essenziali che non possono non esserci; valorizzando, e rendendo semmai oggetto di valutazione “esterna”, proprio le espressioni autonome che, rispettando ciò che non può non essere detto, sviluppino invece fino in fondo la specificità della propria identità.