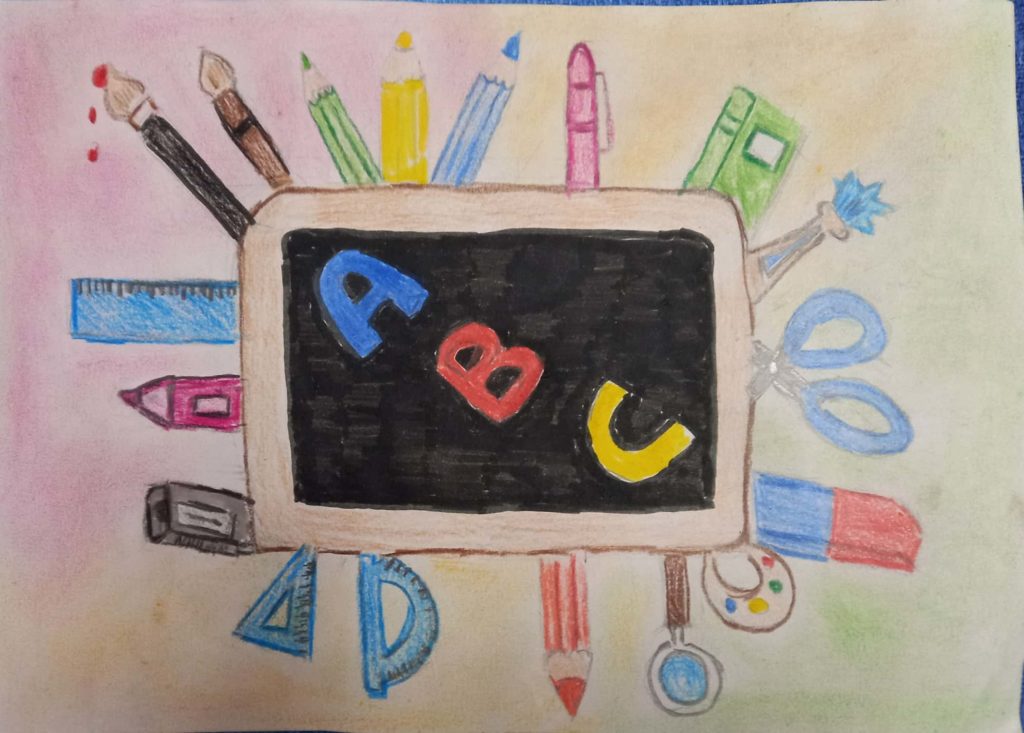disegno di Matilde Gallo, anni 10
di Clara Alemani
Come è noto, le scuole stanno ricevendo cospicui finanziamenti legati al PNRR. Appare quindi necessario che la progettualità di istituto (ri)trovi spazi e modi adeguati agli investimenti, così da scongiurare il rischio di spese poco oculate e creare invece le condizioni per utilizzare al meglio quanto viene assegnato.
La progettualità, intesa come attività del progettare[1], deve innanzi tutto assumere la trasparenza come riferimento imprescindibile, non soltanto per quanto attiene gli atti amministrativi e contabili, ma soprattutto come principio per documentare quanto via via si realizza. Tradizionalmente nella scuola si lavora molto, ma si documenta poco: in parte perché gli strumenti adottati sono percepiti come appesantimenti burocratici da molti docenti (e da alcuni DS); in parte perché spesso le scuole sono chiamate a operare in situazioni cosiddette di emergenza, in cui conta agire rapidamente e appare quasi impossibile ricavare spazi e tempi per progettare e pianificare le azioni che verranno realizzate. C’è inoltre una ragione culturale, retaggio di una visione di scuola in parte romantica, in parte legata alla cultura gentiliana, che identifica qualunque documento ufficiale redatto dentro la scuola come una indebita perdita di tempo, un’attività che deve essere compiuta, un dovere da adempiere, che, nei fatti, non interessa a nessuno. Il pensiero ancora prevalente per molti docenti identifica il buon insegnante come colui (solo in parte colei) che, dotato di una solida cultura (rigorosamente umanistica), di carisma personale e di una certa dose di istrionismo, è capace di improvvisare le proprie lezioni affascinando e incantando alunni e alunne. Redigere il piano di lavoro o un’unità di apprendimento rappresenta, in questa visione, un tempo sottratto ad attività considerate più nobili. Anche molti tra i nuovi giovani docenti non sfuggono a questa logica dell’adempimento e non sembrano disponibili a interrogarsi su altre ipotesi possibili. Al contrario, la capacità di documentare può diventare una risorsa professionale per i/le docenti, con funzioni diverse e variegate, come illustra Barbara Balconi[2].
Anche i documenti di istituto ricadono spesso nella medesima logica dell’adempimento, configurandosi così, non come risorse operative utili per chi lavora a scuola, bensì come atti da chiudere in un cassetto fino alla scadenza successiva. Riesaminare la progettualità di istituto può servire proprio ad avviare una riflessione collettiva sui documenti della scuola, sulla loro struttura, sulle modalità con cui vengono redatti, sulla scelta delle persone che se ne occupano.
È necessario, preliminarmente, interrogarsi sul significato che in ogni scuola si attribuisce al termine progetto: sotto questo comodo e rassicurante umbrella term abitano iniziative molto diverse tra loro che variano da incontri di poche ore, di una o più classi, con esperti su tematiche specifiche, a iniziative che negli anni hanno perso il loro carattere prototipico e si sono strutturate come articolazioni della didattica ordinaria. Sarebbe utile allora che le scuole definissero con chiarezza i criteri per classificare le diverse attività e attribuire a ciascuna di esse uno spazio meglio definito all’interno del curricolo di istituto, del PTOF, nonché del Programma Annuale. Sarebbe ugualmente utile interrogarsi sul valore di tali iniziative, inteso come coerenza con gli obiettivi educativi e didattici individuati come prioritari dall’istituto, sui risultati ottenuti nel tempo grazie a esse (ammesso che vengano effettivamente misurate), ma anche sulle metodologie promosse e sui tempi di realizzazione. La questione dovrebbe riguardare soprattutto le iniziative che le scuole intendono mettere in campo contro la dispersione scolastica. È chiaro che gli interventi, soprattutto quelli che le scuole definiscono di recupero, non possono essere la riproposizione, seppure destinata a gruppi di alunni/e più ristretti, di metodologie e modalità di conduzione delle lezioni tradizionali, in cui il modello prevalente è ancora la lezione frontale. È altresì evidente che le scuole potrebbero opportunamente aprirsi a realtà esterne, come previsto anche dal decreto del Ministero, che già agiscono in molti territori, per co-progettare iniziative in grado di valorizzare anche e soprattutto gli apprendimenti informali e non formali, in aggiunta a quelli formali proposti dalla scuola stessa.
Qualunque sia l’indirizzo che la scuola si darà, è necessario scongiurare alcuni rischi, primo fra tutti quello di mettere in pista un numero sproporzionato di iniziative / progetti, difficili da governare e pertanto poco organici alla scuola stessa. Un altro rischio, come già accaduto in passato, è quello di importare esempi e pratiche, più o meno buone, in maniera acritica, senza cioè il necessario adattamento al proprio contesto di scuola, compresa la cultura professionale delle persone che vi lavorano. C’è infine il rischio che le scuole improvvisino, realizzando azioni non sorrette dalle necessarie competenze professionali, intese come
- adeguata formazione dei soggetti chiamati a realizzarle (sapere);
- necessaria pianificazione delle azioni da realizzare (saper fare);
- solida cultura professionale e organizzativa (saper essere).
In questo particolare momento di questo particolare anno scolastico, in cui devono prendere avvio le iniziative del PNRR contro la dispersione, quelle del Piano Scuola 4.0, la rendicontazione sociale, il nuovo rapporto di autovalutazione, il piano di miglioramento e il PTOF, è necessario mantenere una visione di insieme (uno sguardo unitario) sulle diverse azioni che già si realizzano dentro le scuole, per evitare, da un lato la duplicazione di rassicuranti pratiche dall’esito incerto (o forse solo mai misurato), dall’altro per differenziarne la tipologia e arrivare magari ad aggredire uno stesso problema da molteplici e variegati fronti.
Spetta a chi dirige il compito di mantenere la rotta, cogliendo ogni utile opportunità per garantire unitarietà all’organizzazione, ma anche per sollecitare la consapevolezza di tale unitarietà nei docenti, in tutto il personale della scuola, nelle famiglie, nei partner e nei portatori di interesse più significativi. Il messaggio deve essere chiaro e inequivocabile: la scuola ha selezionato i propri obiettivi, di miglioramento e di sviluppo, e agisce in maniera consequenziale, per favorirne il raggiungimento attraverso processi, azioni, iniziative e progetti coerenti con gli obiettivi stessi. È un messaggio che deve arrivare in maniera diretta dal PTOF stesso, cioè dal documento di pianificazione strategica dell’istituto, in cui le diverse iniziative sono portate a sistema in maniera coerente e organica, visibili all’interno e all’esterno della scuola, sostenute dalle necessarie risorse, a dimostrazione dell’impegno di tutte le persone che lavorano nella scuola.
Affinché si componga un disegno organico, è necessario che lo sguardo di chi dirige mantenga il fuoco su tre diverse prospettive, di cui sappia cogliere e far cogliere la complementarietà:
- i risultati dei progetti, in coerenza con le azioni e gli obiettivi definiti (gli output, per così dire);
- i risultati di apprendimento degli/delle alunni/e, destinatari per i quali quelle iniziative sono state messe in atto (gli outcome);
- i risultati di apprendimento organizzativo, inteso come apprendimento che si sviluppa all’interno della scuola attraverso momenti collettivi di riflessione, di confronto e di agire effettivo e diventa patrimonio professionale dell’intero istituto (risultati in termini di impatti).
Per facilitare il compito e mantenere uno sguardo vigile, può essere utile elaborare o riesaminare, se già in uso, strumenti che
- siano una risorsa per la pianificazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e la messa a sistema complessiva delle azioni che si intende realizzare;
- consentano di governare in maniera più agevole la complessità delle iniziative e dei progetti che le scuole realizzano e realizzeranno;
- documentino le scelte e le strategie messe in atto dall’istituzione scolastica;
- rendano possibile far dialogare fra loro i diversi documenti in corso di elaborazione (RAV, PdM, PTOF, Programma Annuale, Contratto di Istituto, …);
- facilitino le azioni di monitoraggio e rendicontazione, non soltanto quelle che verranno richieste dal Ministero, bensì quelle necessarie alla scuola per valutare il proprio operato.
Ci sono elementi che, qualunque sia lo strumento adottato, devono essere presenti nel momento in cui si pianifica un’iniziativa o un progetto. Occorre
- individuare obiettivi misurabili e coerenti con quelli di istituto riportati nel PTOF;
- definire indicatori e target;
- definire la sequenza delle azioni, anche di quelle apparentemente meno significative;
- individuare i responsabili;
- stabilire, per ogni azione, il piano temporale (quando e per quanto tempo);
- indicare le risorse necessarie per la realizzazione;
- definire un sistema di monitoraggio, in cui siano indicate le scadenze e le modalità di raccolta e diffusione dei dati.
Sarebbe inoltre opportuno definire un piano appropriato di comunicazione interna ed esterna, in cui indicare quando, cosa, a chi e come comunicare lo stato dell’arte delle varie iniziative.
Quanto riportato più sopra dovrebbe concretizzarsi in uno strumento a cui facciano riferimento tutti coloro che collaborano alle diverse iniziative, siano esse parte del Piano di Miglioramento, dei progetti del PNRR e del Piano Scuola 4.0, di ogni altro progetto realizzato dalla scuola. Un foglio excel o una tabella word possono essere altrettanto funzionali di strumenti più sofisticati che solitamente scoraggiano i/le docenti.
È certo che la definizione di uno strumento omogeneo per iniziative diverse comporta una riflessione che riguarda non soltanto la scelta delle attività, la loro pianificazione, realizzazione e monitoraggio, bensì un ripensamento più complessivo sul significato dell’azione educativa e didattica dell’istituto, sulla professionalità di chi ci si impegna, sul fare scuola. Una riflessione di questo genere deve trovare nella scuola uno spazio adeguato per svilupparsi, prendere forma e diventare così un elemento della cultura professionale di quell’istituto. È importante che non sia solo il risultato della riflessione (o dell’intuizione o persino dell’ostinazione) di una persona (o di un ristretto gruppo) , ma che possa diventare patrimonio di tutta la comunità professionale, come risultato di una riflessione condivisa e di un apprendimento sociale. Si parte dagli strumenti, ma si arriva inevitabilmente alle persone, ai protagonisti delle azioni educative e didattiche.
La rilettura della progettualità di scuola assume quindi le caratteristiche di un ripensamento complessivo del fare scuola e può condurre a ulteriori, interessanti spunti di riflessione. È possibile infatti che le diverse iniziative da realizzare richiedano anche aggiustamenti, correzioni, interventi su aspetti che riguardano i processi organizzativi (la necessità, ad esempio, di condensare alcuni interventi in un particolare arco temporale, con la conseguente necessità di rimodulare gli orari). È altresì possibile (auspicabile) che la necessità di pianificare azioni, variegate ma organiche, contro la dispersione promuova una riflessione sulle metodologie didattiche, sui modelli di lezione, sulla laboratorialità, sul significato stesso di dispersione. Ne potrebbe addirittura nascere un’esigenza di formazione su temi che derivano proprio dall’esperienza di quella scuola, in quel particolare contesto spazio-temporale! Ecco dunque che, partendo dagli strumenti, necessari per governare le azioni progettate, si toccano i nodi di una organizzazione complessa come la scuola: le persone, i processi, la cultura professionale, la dimensione sociale dell’apprendimento organizzativo.
La scuola valorizzerebbe in questo modo la propria dimensione di comunità professionale, con quelle connotazioni che Antonio Valentino richiama in un suo scritto[3]. Anche il profilo del/della dirigente ne uscirebbe rafforzato proprio in quelle dimensioni di leader per l’apprendimento di cui scrive, tra gli altri, lo stesso autore: capace di motivare le persone, sviluppare consapevolezza, orientare le scelte del collegio, creare le condizioni per favorire il confronto e la mediazione, delegare senza tuttavia smettere di presidiare le aree di propria competenza, adoperarsi per promuovere apprendimento per tutti i soggetti della scuola.
[1] SI veda il vocabolario Treccani on line, consultabile al seguente indirizzo web: https://www.treccani.it/vocabolario/progettualita/
[2] Barbara Balconi, Documentare a scuola – Una pratica didattica e formativa, Carocci, Roma, 2020.
[3] Antonio Valentino, Investire sulle Comunità professionali nelle istituzioni scolastiche. Condizioni e approccio
https://www.gessetticolorati.it/dibattito/2022/10/06/investire-sulle-comunita-professionali-nelle-istituzioni-scolastiche-condizioni-e-approccio/