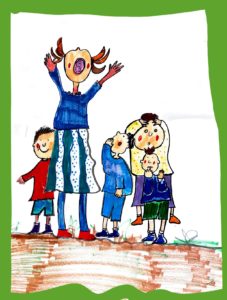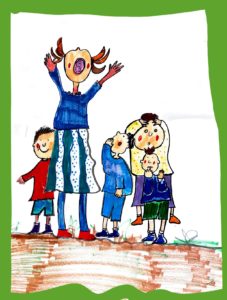 di Stefano Stefanel
di Stefano Stefanel
Il dibattito sulla valutazione formativa, i richiami alla valorizzazione del merito, l’idea che lo studente migliore è quello che studia sulla carta e solo se autorizzato va sul web, il concetto di apprendimento inteso come forma guidata di conoscenza, i miliardi riversarti sul digitale ma collegati ad una cultura proibizionista sull’uso dei dispositivi di proprietà, il concetto vago di divari territoriali collegato ad azioni di recupero finanziate prima ancora di essere decise, la richiesta di finalizzare il sapere al proprio futuro anche se nessuno sa indicare quale sarà sono tutti elementi dell’attuale contemporaneità che cozzano contro lo scoglio da aggirare: la pedagogia.
In teoria disciplinarismo e pedagogia dovrebbero essere strettamente collegate: se voglio insegnare qualcosa devo avere a che fare con un contenuto e questo contenuto sta per forza dentro una disciplina, che, a sua volta, richiede un determinato metodo per essere insegnata, cioè la pedagogia dovrebbe servire per transitare contenuti (e abilità e competenze che ne seguono) dalla mente di un sapiente alla mente di un non sapiente. Difficilmente vado ad imparare qualcosa che già so, difficilmente qualcuno mi insegna ciò che pensa io sappia o ritenga io debba sapere (i prerequisiti).
Da oltre cento anni la pedagogia è stata considerata una “materia” a sé stante, non necessariamente collegata al suo compito: far apprendere. Infatti, in alcune scuole si studia la pedagogia come una forma di pensiero filosofico minore, interessante, ma con valore più storico-sociale che metodologico. Il problema, però, è un po’ più complesso e va a toccare le discipline così come sono state codificate e così come si sono imposte, le uni a scapito delle altre. Da questo punto di vista Le parole e le cose di Michel Foucault ha dimostrato che le discipline sono strumenti di potere (politico) e che talune hanno preso il sopravvento, mentre altre vivono nell’ombra. In Italia questa evidente stortura ha dato vita al costrutto artificiale delle “classi di concorso”, una struttura di sapere che è diventata struttura di potere con un valore economico molto forte, strettamente collegato ai posti di lavoro che è in grado di farsi riconoscere.
L’ostilità dei disciplinaristi nei confronti dell’educazione civica sta tutta qui: l’educazione civica è una disciplina chiara e obbligatoria che non ha prodotto nuovi posti di lavoro. Quindi la sua trasversalità va abbattuta. Finora non ci sono riusciti, ma chi ha pazienza vedrà presto nascere le cattedre di educazione civica con tanto di abilitazione. Il disciplinarismo ha alcune caratteristiche molto marcate, che si possono riassumere in tre modalità didattiche.
La trasmissività vista come l’elemento base della disciplina: io ti racconto, ti spiego, ti argomento quello che devi imparare, tu studi e lo impari. La trasmissività impone la conferenza, la cultura del contenuto, la spiegazione anche di ciò che è già chiaro, la meta-spiegazione artigianale (la lezione in classe) di quello che è oscuro, il riassunto virtuoso, la chiacchiera diventata orazione.
Il manuale o il libro di testo in cui è codificato il riassunto di tutto lo scibile disciplinare, in fascicoli da compulsare e leggere annualmente, visto che tutto è diviso per annualità e prevede una chiara spesa da sostenere come base per accedere a quel sapere codificato, stantio e immobile, ma comunque certo, almeno nei limiti di quanto la comunità disciplinare ha deciso sia certo in quel momento.
La memoria come ricordo di ciò che è stato trasmesso attraverso conferenze (anche operative: gli esperimenti nei laboratori) e che deve essere esercitata senza supporti tecnici e multimediali in quelle che sono le prove disciplinari per eccellenza, cioè i compiti in classe e le interrogazioni.
La pedagogia, dunque, viene sempre più vista come un elemento di ostacolo alla disciplina, quasi che il piegarsi alle esigenze del discente debole sia un cedimento inaccettabile verso una contaminazione al ribasso della purezza disciplinare. Il discente forte – ed è questo il punto di grande ambiguità del concetto di merito – è perfettamente inserito nello specifico disciplinare ed apprende per trasmissione, tradizionalismo manualistico, memoria. Siamo dunque di fronte ad un problema molto serio che vede la disciplina come strumento delle élite e la pedagogia come strumento del popolo. Il sapiente è un disciplinarista se comprende che deve esserci un elitarismo nell’insegnamento che non può permettere alla disciplina di scendere verso la banale comprensione, il modesto impegno, il poco interesse; mentre è un pedagogo se cerca di raggiungere il popolo col sapere. Con il termine dispregiativo di “pedagogismo” si indica la china facilitatrice verso concetti e apprendimenti non facilitabili e come tali necessari più per il mantenimento del potere della disciplina che per migliorare l’apprendimento della stessa in studenti comunque giovani e generalisti.
Tutto questo lo aveva già detto Foucault molto chiaramente, ma il pensiero pedagogico novecentesco (Montessori, Dewey, Gardner, Brunner) ha sottovalutato la forza del potere economico sotteso alla disciplinarietà dei saperi. Ne ha fatto le sue spese anche la filosofia, per sua natura trasversale, diventata nei libri di testo liceali una parodia di un percorso storico-letterario, con teorie elencate insieme a dati biografici e bibliografici in cui tutti i pensieri sono metafisici, astratti, simpaticamente astrusi. Lo spacchettamento tra filosofia e pedagogia ha fatto il resto e la lezione di un grande pedagogo come San Tommaso d’Aquino è andata totalmente perduta.
Se si scende a questo livello la partita non si può vincere: il sapere alto, la specializzazione non ha pedagogia e, infatti, la disciplina più forte negli studi liceali è la matematica, che avanza solo per trasmissione e spiegazioni di teorie sempre più complesse, rese forti da un’inutile prova finale d’esame, troppo semplice per chi la matematica la conosce da disciplinarista, troppo difficile per gli altri che dimenticano tutto subito e vivono il resto della loro vita senza la matematica, dimenticando la matematica, per lo più odiando o disprezzando la matematica. D’altronde non c’è nessuno che a tavola o al bar dica: “io a scuola non capivo niente di grammatica o di scienze o di storia”, ma molti dicono, spesso con orgoglio: “sono sempre andato male in matematica”. La disciplina prima e più importante dei nostri giorni è finita in mano a indiani e cinesi, capitale primo delle multinazionali, mentre in Italia è lo spauracchio dei liceali e basta. Tutto il resto, da noi, lo fanno le macchine, che la scuola non vuole affiancare all’insegnamento della matematica come parte essenziale di supporto, perché vuole una matematica di memoria e lavagne d’ardesia.
Gli specialisti ci sono sempre stati nella storia dell’umanità e sempre ci saranno: non è mai stato questo il problema. Ma i disciplinaristi non sono degli specialisti, sono, forse, dei cultori della materia, cioè competenti dentro i limiti di una disciplina. La contaminazione è inutile in uno specialista, ma viene ritenuta pericolosa da coloro che non sono specialistici, ma sono solo disciplinaristi, perché la contaminazione fa perdere potere alle discipline. La struttura enciclopedica è una “lotta mortale” tra discipline, che vogliono avere più voci riconosciute possibili, perché tante sono le voci, tanto è il potere. Le arti del trivio e del quadrivio una battaglia simile l’hanno disputata circa mille anni fa.
Se torniamo a noi lo svilimento della funzione della pedagogia, soprattutto nelle scuole superiori, non è un modo per preservare il rigore e la precisione disciplinare, ma solamente per delimitare il campo del potere. Discipline che si contaminano, che agiscono su base multidisciplinare e interdisciplinare alla fine finiscono per perdere la loro specificità e a trasformarsi in altro. Questa battaglia la scienza, ad esempio, l’aveva già combattuta alla fine dell’Ottocento e all’inizio del Novecento quando si è sviluppata una notevole filiera di divulgazione scientifica, iniziata da Ernst Mach con e Letture scientifiche e popolari e continuata anche con grandi scienziati che si sono impegnati nella divulgazione come Einstein, Bohr ed Heisenberg. Ed è una battaglia che ha reso le discipline più arcigne, desiderose di essere trasmesse, ma ostili verso la pedagogia, cioè verso quell’azione del docente che comprende come raggiungere la mente del discente, non per riempirla, ma per farla diventare migliore.
Per questo servono i voti e non le valutazioni formative: per delimitare il campo della disciplina. Se il voto è negativo viene sancito il “debito disciplinare”, cioè quel terreno incerto e di controllo per cui l’insegnante non deve trovare metodi nuovi per raggiungere risultati di apprendimento che non ha raggiunto con i metodi trasmissivi, sperimentali, misurativi in vigore, ma semplicemente rubricare l’insuccesso, quella debolezza disciplinare che non permette di andare avanti. Più le discipline sono obsolete più sono difficili e astruse e per questo forti, perché essendosi tramutate in classi di concorso alimentano la schiera di chi insegnerà quella disciplina nella scuola italiana. Il tramonto della pedagogia, però, è il tramonto dell’apprendimento. E senza apprendimento non c’è progresso.