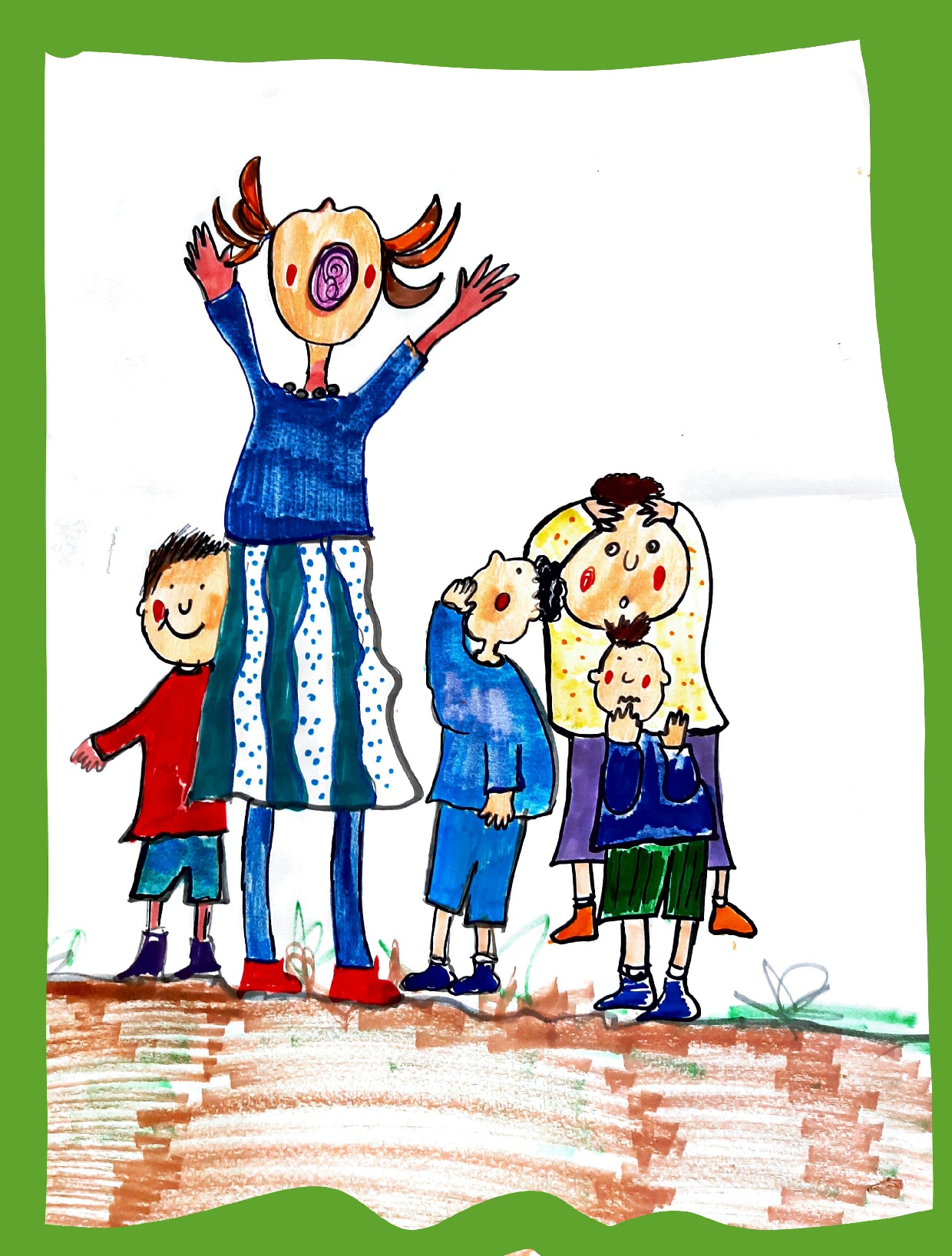di Stefano Stefanel
di Stefano Stefanel
Premessa biografica
Mi sono laureato in filosofia a Trieste nel 1979 con una tesi su Ernst Mach e la filosofia della scienza dal titolo Per un dibattito sui rapporti tra il machismo e il materialismo dialettico (relatore Pier Aldo Rovatti) con 110/110. Nel 1981 mi sono diplomato a Padova nella Scuola di specializzazione in Filosofia (indirizzo Estetica) con 70/0 e lode e una tesi dal titolo Percorsi filosofici tra Mach e Musil[1] (relatore Giangiorgio Pasqualotto), poi pubblicata col medesimo titolo. Ho anche partecipato ad un concorso universitario arrivando al terzo posto ma con 100/100 di voto complessivo nelle tre prove (40/40 e 40/40 nei due scritti: uno sull’ontologia in Kant e Hegel e l’altro sulla critica alla metafisica in Nietzsche e Heidegger; 20/20 nell’orale), ma con meno titoli di chi mi ha superato. Ho poi superato 5-6 concorsi a cattedra in filosofia, rinunciando sempre al ruolo nei Licei che avevo vinto per continuare a insegnare alle Scuole medie. Poi dal 2001 ho iniziato a fare il dirigente scolastico e dal 2012 dirigo un Liceo scientifico (quello che ho frequentato da studente). La scelta di rimanere alle medie ha avuto due motivazioni: la prima era che mi sentivo più vicino alla didattica dei Lehrjahren (“veder crescere l’apprendimento dalla parte delle radici” dicevo parafrasando il titolo di un libro degli anni Settanta); la seconda che non intendevo insegnare Storia della filosofia e che per non insegnarla al Liceo avrei dovuto mettermi in conflitto con scuola, colleghi, studenti e famiglie. E quindi ho “fatto” filosofia alle medie (Kinderphilosophie) finché sono diventato dirigente. Oltre al libro sopra citato ho pubblicato molti articoli su riviste filosofiche (Edizione della Società Filosofia Italiana – Sezione Friuli-Venezia Giulia di cui sono stato fondatore e Presidente per 7 anni; Testi & Contesti, Bollettino della SFI Nazionale e altre riviste).
—————————————————–
Il motivo per cui ho tediato il lettore con la tiritera di cui sopra è che il libro di Massimo Mugnai uscito da pochissimo dal titolo Come NON insegnare la filosofia[2] (Raffaello Cortina Editore, Milano 2023) racconta la mia storia ed esprime il mio pensiero come meglio non avrei saputo fare.
La mia adesione alle tesi di Mugnai è assoluta e il dissenso in un paio di punti nasce probabilmente dalla diversità dei nostri percorsi di vita e di studio, più che da una diversa visione della questione. Alla base della tesi di Mugnai c’è quello che io ho sempre pensato: per uccidere la filosofia bisogna insegnare Storia della filosofia agli adolescenti[3]. Il “braccio armato” della storia della filosofia è il manuale liceale. Mugnai descrive il problema così: “La struttura portante del manuale, però, è la stessa da quasi settant’anni: una narrazione della storia della disciplina, secondo la quale le varie teorie e concezioni filosofiche si susseguono nel tempo; è un immane racconto dossografico senza capo né coda[4]”.
Dirlo meglio di così è impossibile e difatti non lo dico. Aggiungo solamente che contestualizzare storicamente il pensiero di un filosofo (o anche di un’opera letteraria) significa sminuirne la forza e tradurre tutto in riassunto, cosa certo utile per gli studiosi, terribile per gli studenti. Quando Protagora scrive che “l’uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono perché sono e di quelle che non sono perché non sono” e quando Anassimandro dice che “le cose fanno ritorno là da dove sono venute secondo la necessità. In questo modo pagano reciprocamente la colpa di essere mortali” mi pare ci sia poco da aggiungere: c’è solo da argomentare, studiare, analizzare, dibattere, cioè, fare filosofia. Cosa aggiunga il contesto, in cui sono state scritte, alle due frasi sopra riportate proprio non lo vedo. La Storia della filosofia è molto bella (li ho fatti tutti da giovane, quegli esami: Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia contemporanea: altro a Trieste non c’era, sennò facevo anche quello), ma per gli studiosi, non per gli studenti (anche se studiosi).
La critica ai manuali di Mugnai è perfetta con un unico neo: propone anche lui un manuale sistematico (cioè, sugli argomenti) sulla scia di quello che si fa in varie nazioni che lui cita.
Il manuale sistematico è una bella cosa, ma non è un manuale, è semmai un testo di proposta. Mugnai ricorderà, però, il naufragio di Mario dal Prà, in questo senso, col suo manuale sistematico di Storia della filosofia per i Licei degli Anni Sessanta[5], schiacciato poi dai vari Geymonat, Abbagnano e Fornero, Ferraris, ecc.
Poiché però il rapporto col testo diventa sempre più debole e il tempo sfugge ritengo che la strada da seguire sia quella di fare filosofia a scuola senza alcun manuale, andando sui testi a vedere cosa c’è di interessante. Esemplifico brevemente: per introdurre i Presocratici partirei da quello che di loro dice Aristotele nella Metafisica e andrei a leggere con gli studenti i frammenti che ci sono stati tramandati per vedere se su questo punto Aristotele aveva ragione e se aveva preso un abbaglio (ovviamente io sono per la seconda che ho scritto). E via di seguito: provate a ragionare con gli studenti sulla traduzione di “intelligo id” di Spinoza e fatemi sapere a cosa serva contestualizzare storicamente la prima parte dell’Ethica. [6]
°°°°°
Esiste anche il problema dei docenti di filosofia su cui Mugnai dice parole definitive. Per cui aggiungo solo alcune considerazioni: molti sono laureati in storia e dunque non hanno un grande background filosofico e quindi hanno oggettive difficoltà ad insegnare filosofia senza i riassunti. Quelli laureati in filosofia per lo più continuano a studiare e ad interessarsi alla filosofia o cercano di agganciare una carriera universitaria. Anch’io avevo quell’idea, pensavo che il mio scopo filosofico fosse quello di dimostrare che Ernst Mach è un Grande Filosofo e non un Filosofo Minore e che con lui lo spinozismo era entrato nelle scienze. Da giovane ero un teoretico antistoricista che avrebbe dovuto per forza di cose insegnare in un Liceo, visto che all’Università non era aria. Ho continuato a studiare filosofia e lo faccio anche ora (ho appena finito di leggere un libro su quel gran pasticcio che si autodefinisce “nuovi realismi”) e mi sono accorto che gli insegnanti di filosofia al mattino parlano e spiegano i Filosofi Maggiori, al pomeriggio si occupano ossessivamente di Filosofi Minori, una volta erano gli epigoni del marxismo, oggi francesi vari e qualche tedesco, mantenendo un certo disprezzo italico per la filosofia analitica.
Leggendo il libro di Mugnai mi è venuta questa domanda: perché gli insegnanti si occupano nei loro studi (pomeridiani) dei Filosofi Minori e spiegano al mattino i Filosofi Maggiori attraverso riassunti (manuali) a giovani di 16, 17, 18 anni? Se è vero che nel mondo gli Studiosi Maggiori (cioè gli studiosi di rango, gli ordinari) si occupano dei Filosofi Maggiori è altrettanto vero all’università gli Studiosi Minori (quelli che vogliono entrare, i ricercatori, gli accoliti, i volontari, gli “sgomitatori”, ecc.) si occupano di Filosofi Minori o di Minuzie Filosofiche.
Allora mi chiedo per quale motivo gli studenti liceali devono sapere cosa pensano i Filosofi Maggiori attraverso riassunti, mentre i loro docenti al pomeriggio dei Filosofia Maggiori non si occupano più (chiedo al lettore di non farsi venire la tentazione di dire perché li hanno già letti tutti). Mugnai tutto questo lo mette in evidenza con grande maestria: “acquisire competenze nell’ambito della storia della filosofia non equivale ad acquisire competenze nell’ambito del ragionamento filosofico[7]”.
°°°°°
E arriviamo al punto su cui penso che Mugnai ragioni da professore ordinario e quindi non abbia il punto di vista di chi la scuola la vive dal basso. Scrive Mugnai: “Le competenze, perciò, fanno riferimento soprattutto a conoscenze parziali, finalizzate al raggiungimento di determinati scopi: rendere competente uno studente significa dargli la possibilità di mettere in pratica, prima possibile, le conoscenze acquisite[8]”.
A livello altissimo (diciamo, generalizzando, a quello degli ordinari, anche se non proprio di tutti loro) conoscenze e competenze coincidono: chi è esperto sulle ginocchia, sulla guerra del Peloponneso, sugli enzimi o su Pomponazzi ha tutte le conoscenze necessarie e sufficienti che gli servono per essere competente.
Dunque, a livello alto (ho scritto ordinari, non professori di Liceo) spesso il proprio sapere crea confusione sul concetto di competenza. A livello liceale deve esserci un equilibrio tra conoscenze e competenze, perché le competenze senza conoscenze non esistono, mentre troppa conoscenza assemblata e memorizzata uccide la competenza (agli esami di maturità studenti bravissimi a cui si chiede di deviare da quello su cui si sono preparati spesso si perdono tra lo sconcerto dei docenti interni che non si capacitano dell’intoppo). Quindi le competenze non sono uno stratagemma per studenti che valgono poco, ma sono l’unica possibilità che un sapere si cementi in modo da formare quella base su cui far crescere l’apprendimento[9]. “Intelligo id”, dove senza “id” non c’è alcun “intelligo”.
Su un punto Massimo Mugnai coglie quello che è il problema centrale della filosofia in Italia: “se ci domandiamo se è possibile fare filosofia (buona filosofia) senza conoscere la storia della disciplina, la risposta è banale: sì, è possibile”[10]. Resta, dunque, incomprensibile perché si voglia continuare ad avere pessimi conoscitori di Storia della filosofia (e anche di Storia della letteratura italiana) quali sono certamente gli studenti e non si va nella direzione delle competenze filosofiche, che sono comunque un’ottima modalità per abituare la mente ad argomentare e ad approfondire. Certamente con i manuali in adozione e le modalità di spiegazione della Storia della filosofia attraverso riassunti di filosofi e dei pensieri filosofici, spesso astrusi, non si sviluppa alcuna competenza e ci si impedisce di riconoscere le competenze che gli studenti nel loro Zeitgeist (spirito del tempo) stanno sviluppando in modo autonomo, come facevamo noi 50 anni fa. Quindi va cercata un’altra strada e io penso sia quella indicata da Mugnai.
In chiusura, dunque, un grande grazie a Massimo Mugnai, sperando che il folle mondo della filosofia (che non è pop [11], nemmeno un po’) cominci ad avere pietà dei suoi studenti e metta fine allo strazio del riassunto raccontato.
[1] Stefano Stefanel, Percorsi filosofici tra Mach e Musil, Lalli, Poggibonsi 1984.
[2] Massimo Mugnai, Come NON insegnare la filosofia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2023.
[3] Nel 2014 sul sito Pavone Risorse ho pubblicato un breve articolo dal titolo: Filosofia nei Licei: ripartire da zero, che ha avuto un effetto pressoché nullo. (http://www.pavonerisorse.it/scuolaoggi/filosofia_nei_licei.htm).
[4] Ibid, pag. 76.
[5] Mario Dal Prà, Sommario di storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1964 e successive ristampe.
[6] Sempre dalla mia (noiosa) biografia: ho insegnato per 22 anni alle scuole medie e non ho mai – dico mai – adottato un manuale. I ragazzi hanno sempre comprato libri, non manuali. Libri integrali, non per le medie. Si sono laureati, lavorano, hanno filosofato da ragazzi. Di questo ho scritto in alcuni interventi pubblicati sulla Kinderphilosophie.
[7] Mugnai, cit, pag. 174.
[8] Ibid, pag. 72. A completamento di questo passo rimando alla perfetta fotografia del passato, una sorta di descrizione della mia vita da studente liceale: “Si può dire che la scuola degli anni Sessanta fornisse agli studenti molta informazione, ma che la formazione fosse il frutto di un’attività di acculturazione in buona parte autonoma e individuale”, pag. 167.
[9] La frase: “E’ evidente che, negli ultimi dieci anni, il livello delle competenze degli studenti delle superiori si è notevolmente abbassato, in quasi tutte le materie” (Ibid, pag.. 165) tradisce il punto di vista del professore ordinario. Non si è abbassato proprio un bel niente, anzi nei giovani c’è un notevole aumento di competenze, che però non sono ancora state rubricate dalle università e dalla scuola e quindi vengono ritenute inutili. Invito il prof. Mugnai (si fa per dire, credo non leggerà nemmeno una riga di quello che ho scritto) a verificare il tasso di resistenza e resilienza dei giovani rispetto a saperi obsoleti, stantii, baronali che vengono dispensati come sapere assoluto e la loro capacità di uscirne con grandi disposizioni verso un futuro molto più incerto e incerto del nostro. L’opinione del prof. Mugnai su Luca Ricolfi e Paola Mastrocola, pag. 167 mi trova lontanissimo: sono due personaggi oscuri, che scambiano un liceo classico di Torino per il sistema scolastico nazionale.
[10] Ibid, pag. 48.
[11] Ibid, “Filosofia pop e filosofia tradizionale”, pag. 146.